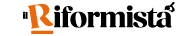Nel nostro Paese la stagione delle riforme ricorda un po’ quella dell’amore nella ballata di Franco Battiato: «viene e va»; di regola secondo un moto segnato da una qualche emergenza che ci induce a riflettere su «come ho speso male il mio tempo, che non tornerà». Così, l’emergenza sanitaria ha riacutizzato ed esasperato le crisi persistenti della giustizia e del sistema penitenziario: capitoli da decenni aperti, sospesi, richiusi, talora scritti ma in questo caso sempre riscritti, in una vicenda, apparentemente senza fine, di riforme che evocano riforme e richiedono nuove riforme. Non si tratta più di categorie della storia, ma di una categoria dello spirito o, più miseramente, di un modo per rinviare i problemi, per esorcizzarli, per placare l’ansia che suscitano, per sublimarli o, alla fine, per rimuoverli: espedienti, fughe, elusioni.
L’emergenza farisaicamente indotta dal pubblico dominio di pratiche d’autogoverno della magistratura, a tutti note da sempre, fino alla nausea, ha reso – udite, udite – indifferibile e urgente la riforma del Csm per riportare le corporazioni correntizie alla loro matrice originaria di associazioni culturali (sempre che tale matrice sia davvero un tempo esistita: la mitologia induce, a volte, qualche proiezione fantastica). Dell’annoso problema si parla, si scrive e si ripete da decenni ormai. Dovrebbe essere questa la volta buona? Può anche darsi; ma, con ricette a base di riforme elettorali e di percorsi per la scelta dei dirigenti secondo lo stile atletico dei tremila siepi, non ci sarà da attendersi un gran pranzo riformatore. Sarebbe il caso di rammentare che i flussi corporativi aggrumati intorno al potere e agli interessi stanno alle istituzioni come l’acqua nei canali: alla fine ne assumono sempre la forma. Occorre agire sulle sorgenti: reclutamento, formazione, carriere. Temi esplosivi, meglio lasciar perdere.
L’emergenza della cosiddetta Fase 2, della ripartenza economica, e di un’azione amministrativa efficiente ed efficace per agevolarne il corso, ha indotto ad evocare un vecchio commensale al banchetto delle riforme. Presentando in una recente lettera al Corriere della sera il quadro delle “azioni fondamentali” che il Governo si propone di compiere nel prossimo futuro, il Presidente del Consiglio ha sottolineato l’esigenza che «sui funzionari onesti» non gravi «eccessiva incertezza giuridica», rendendo necessario, «ad esempio», circoscrivere «più puntualmente il reato di abuso d’ufficio e la medesima responsabilità erariale». La campana suona dunque per l’art. 323 c.p., che punisce – per dirla molto alla buona – l’agente pubblico che procura intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale ingiusto, oppure un danno ingiusto, violando una norma di legge o di regolamento. La fattispecie sembra scorrere liscia come l’olio: il giudice accerta se sussiste l’inosservanza di un precetto o di un divieto e se ne è scaturito un profitto o un pregiudizio del tipo richiesto; dopo di che assolve o condanna.
I conti tornano in apparenza; ma così in effetti non si può dire che sia. Per comprendere le ragioni di questo persistente “disagio” che circonda la vicenda applicativa dell’abuso d’ufficio (giustificando, almeno in parte, il proposito manifestato dal Presidente del Consiglio) bisogna ricapitolarne la vita, che per verità risulta travagliata, simile a quella di un giovane povero chiamato a gestire una fortuna troppo più grande delle sue spalle. La riforma ora invocata sarebbe la quarta, nel giro di una trentina d’anni: nel 1990 la prima, nel 1997 la seconda, nel 2012 la terza (quest’ultima tuttavia solo per aumentare la pena prevista).
Prima del 1990, l’abuso di ufficio puniva, con vaga nonchalance, “qualunque fatto” commesso con abuso dei poteri per favorire o danneggiare qualcuno, ed era ridotto, nel cantuccio riservatogli dal codice del ’30, ad occuparsi di minutaglie di provincia: spiccioli di favoritismo e avanzi di angherie. Il terreno più vasto era infatti occupato da due autentici giganti dell’epoca: l’interesse privato in atti di ufficio e il peculato per distrazione, dotati di una straordinaria (e diabolica) “duttilità” repressiva. Nessuno poteva in effetti stabilire con sicurezza il confine tra lecito e illecito maneggiando il mantra evocativo delle loro fattispecie: profluvi di dottrina e cataste di giurisprudenza chiamate a dipanare le intricate matasse della loro applicazione si riducevano a pestare l’acqua nel mortaio senza poter mai stabilire la direzione degli schizzi.
La riforma del 1990 ridisegna il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione: congeda i due giganti e trasforma il ranocchio dell’abuso di ufficio in un principe, consegnandogli un setaccio che avrebbe dovuto selezionare scrupolosamente il grano (l’azione amministrativa espressiva di scelte discrezionali corrette) dal loglio (il favoritismo indebito e la prevaricazione abusiva). Il setaccio si rivelò tuttavia (o fu ritenuto: a questi fini è la stessa cosa) non adeguato alla bisogna. I fremiti degli amministratori impauriti dettero allora vita ad una commissione di riforma (della riforma da poco compiuta). Questa non poté peraltro concludere i suoi lavori, perché anticipata da un fulmineo intervento legislativo da cui scaturì a tamburo battente il testo attualmente in vigore. La sollecitudine legislativa fu maliziosamente attribuita alle vicende processuali di un insigne personaggio, che con la fattispecie di nuovo conio si trovò a beneficiare di un proscioglimento che la formulazione precedente non avrebbe, probabilmente, consentito. Supposizioni ovviamente assurde in un Paese di antica civiltà giuridica, quale il nostro si vanta a buon diritto di essere.
La riforma della riforma non era certo di facciata; capovolgeva anzi l’assetto originario, spostando il baricentro della condotta criminosa dall’abuso alla violazione di legge.
Mentre il primo implica una valutazione su modi e scopi dell’esercizio di un potere, penetrando nel cuore stesso della discrezionalità amministrativa, la violazione di legge sembra ridurre il parametro di valutazione entro i limiti di una norma che precisamente identifichi ciò che l’agente pubblico può o non può fare. All’inizio la giurisprudenza si adeguò rigidamente al nuovo dettato normativo, come una vera e propria bouche de la loi. Ma si avvide ben presto che in tal modo si delineava una “zona d’ombra” quando (ed accade assai spesso) la discrezionalità dell’agente pubblico non è accompagnata da prescrizioni specifiche concernenti l’esercizio del potere attribuito. Il nuovo assetto finiva così col calare una cortina, resa impenetrabile al giudice, proprio nel caso delle distorsioni funzionali più gravi, compiute profittando di una discrezionalità vasta, non presidiata da vincoli normativi precisi, e tuttavia sfociata in vantaggi, o in danni, sicuramente ingiusti.
L’irrazionalità e l’incongruenza di un testo normativo stimolano sempre una reazione sotto forma di interpretazione “correttiva”, o “adeguatrice”, anticamente definita “teleologica” (ma alla fine si tratta pur sempre della riscrittura del testo), non diversamente da quando la disposizione normativa esce dalla penna del legislatore oscura o vaga. Se in quest’ultimo caso al giudice viene rimesso l’incomprensibile di significato, nel primo gli si pone tra le mani l’indecifrabile di senso. Come non ritenere che senso e significato spetti allora proprio a lui definirli?
Si è così sviluppata intorno all’art. 323 una vera e propria riconversione ermeneutica che, passo dopo passo (e sarebbe interessante seguirli tutti, uno per uno: un vero percorso di formazione) ha condotto l’assetto reale dell’abuso d’ufficio all’esatto punto cui l’avevamo lasciato prima del 1990: una fattispecie a largo raggio che incrimina la condotta dell’agente pubblico non solo quando sia svolta in contrasto con precise norme che regolino l’esercizio del potere, ma anche quando essa sia orientata alla realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito. Sono queste ultime parole delle Sezioni Unite della Suprema Corte, e postulano che sia il giudice a valutare gli interessi in gioco, a stabilirne la consistenza, ad apprezzarne l’offesa. Siamo tornati all’origine: la violazione di legge non è che l’antico abuso di potere del codice Rocco.
Ma il contesto non è più quello di allora, quando l’abuso era un ranocchio normativo; ora è un principino la cui signorìa si colloca sul limitare che divide – o dovrebbe dividere – giurisdizione penale e pubblica amministrazione, ma in un modo peraltro del tutto particolare, perché non rappresenta, propriamente, una “guardia” di confine, quanto piuttosto l’autore di quel confine. È quindi inevitabile che si trovi esposto alle tensioni che caratterizzano i rapporti tra giudice e pubblica amministrazione. Ma qui sta il punto, il vero punto della vicenda. Si è detto: rapporti tra giudice e pubblica amministrazione, mentre si sarebbe dovuto dire piuttosto: rapporti tra pubblico ministero e pubblica amministrazione. Infatti, chi scorre le sentenze di cassazione che confermano condanne in tema di abuso d’ufficio (e delineano il quadro della legalità “raggiunta” dal “formante” giudiziario), si trova per lo più sciorinate, al netto di specifici apprezzamenti “tecnici”, vicende gravide di disvalore pregnante.
Il fatto è che in cassazione arriva solo una frazione (percentualmente nemmeno troppo elevata) dei casi in cui si procede per abuso di ufficio, con esito vario e per un tratto di tempo lungo e indefinito: da quando si è abolita la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, potenzialmente eterno. Lo sguardo deve allora concentrarsi non più sulla legalità “raggiunta”, ma su quella “offerta” all’inizio, quando tutto comincia, e cioè sulla capacità selettiva che la fattispecie può davvero esercitare rispetto all’avvio di un procedimento penale. È questo infatti il momento cruciale per l’amministratore investito dell’indagine, soprattutto se si tratta di un innocente (cioè, per usare il termine autorevolmente proposto di chi se ne intende: un colpevole che riuscirà a farla franca).
Infatti l’inizio stesso esaurisce, per lo più, l’intera gamma degli effetti esiziali che il malcapitato può trovarsi a subire. Su questo piano, l’asticella risulta davvero bassa assai: alla stregua della deriva ermeneutica di cui si è detto, basta un atto censurato per qualche profilo di irregolarità e un sospetto più o meno consistente di vantaggi patrimoniali privati o di un qualche danno ad altri cagionato per evocare il fantasma della notizia di reato, che è ben in grado di accompagnare anche molto a lungo i sonni del processo.
Per evitare questi incubi notturni insistere di bulino sulla fattispecie dell’art. 323 per affinarne la “precisione” equivarrà a cercar farfalle sotto l’arco di Tito. Servirebbe – come ognuno intende – qualcosa di diverso; e si tratterebbe, con ogni plausibile evidenza, di parole difficili da ascoltare; almeno fin che dura questa stagione.