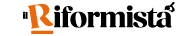“La montagna ha partorito il topolino”, si dice in genere, in occasioni come queste, quando un appuntamento importante dà luogo a un risultato deludente. Rispetto alle recenti decisioni dell’Eurogruppo, penso che sia una formula inadeguata e fuorviante, perché oscura cos’era e ancora cos’è la posta in gioco di queste decisioni. Essa si può riassumere in questo frangente in una questione che illustra tutte le altre e che decide su quali strade scelga l’Europa per l’uscita dalla crisi prodotta dal Coronavirus, a partire dalla risposta da dare alla dura recessione già annunciata. La questione sono gli Eurobond: la cruna dell’ago attraverso la quale si può pensare di affrontare la sfida.
Gli Eurobond sarebbero, infatti, la messa in comune tra diversi Paesi del debito necessario per un programma comune di investimenti per una ripresa qualificata. Sarebbero, cioè, l’inizio – solo l’inizio, ma significativo – di un percorso per la messa in comune di una parte di bilancio europeo, l’avvio di un cambiamento di rotta rispetto all’Europa reale, imprigionata nel modello globale del “finanzcapitalismo”, per dirla con Luciano Gallino, e svuotata dal concerto governativo. La scelta avrebbe potuto essere favorita da quella già operata dalla Bce, con la temporanea uscita dall’austerity e con la sospensione degli “stupidi” ma ferrei vincoli sul debito dei Paesi membri, e con una politica monetaria che, portando a oltre 100 miliardi l’ombrello europeo sui debiti sovrani dell’Eurozona, mette i singoli Paesi nella possibilità di indebitarsi.
La Bce, con una scelta opportuna, ha rivelato così la forza e il limite strutturale del suo agire, per andare oltre ci vorrebbe la politica. Appunto, l’Europa politica, ma qui è ricascato l’asino. Gli Eurobond dovrebbero servire a una politica di investimenti comuni che, fronteggiando l’emergenza del coronavirus e contrastando la recessione, possano gettare le basi, se le scelte politiche di indirizzo di spesa lo sapranno fare, di una svolta nella politica economica per la lotta alle povertà e alle diseguaglianze, per una riconversione ecologica, per un nuovo Stato sociale in scuola, sanità e reddito per tutti. Gli Eurobond sono solo l’apertura di una possibilità che dovrebbe essere qualificata da scelte politiche riformatrici, ma un’apertura decisiva per il futuro europeo. Strategicamente un vantaggio sia per i Paesi del sud dell’Europa, che per la sua potenza mercantilista, la Germania.
Cosa vi si oppone? Il fronte neoconservatore europeo che ricorre alla demonizzazione della mutualizzazione del debito, che si appella all’egoismo degli interessi immediati di chi si considera formica contro la cicala, che teme l’insolvenza di qualcuna di queste ultime e che si fa scudo di un interesse minore, ma immediatissimo. Il debito dell’Eurobond, infatti, pagherebbe un tasso di interesse determinato dalla media dei Paesi che lo garantiscono, cioè superiore a quello della Germania e dell’Olanda. Non sarebbe molto se non poggiasse sulla ideologia della continuità dell’Europa reale, eppure essa vacilla e la crisi del virus ne accentua le fragilità e la espone al rischio di un suo disfacimento. È quel che ha avvertito dal fronte interno, Mario Draghi. È quello che ha avvertito anche una parte importante della stessa società civile tedesca, da filosofi e pensatori, quali quelli guidati da Habermas, a varie sinistre interne, al Dgb (il potente sindacato tedesco), fino a figure istituzionali come il Presidente del Parlamento.
Ma ora, il rischio si fa più acuto, dopo il pessimo accordo dell’Eurogruppo, accordo che resta imprigionato nella sua dura costituzione materiale. Ogni Paese dovrà, se le cose resteranno queste, affrontare l’uscita dall’emergenza scoperto, in una contesa che si farà sempre più mondiale. Le grandi potenze, la Cina, l’America, la Russia, si apprestano a conquistare spazi crescenti del mercato mondiale e non solo del mercato. L’Europa può farvi fronte solo con una svolta nel suo modo di essere, nelle sue politiche economiche, nell’assetto delle sue istituzioni, nella sua vita democratica. Altrimenti, neppure l’Unione europea reggerà. Per andare in questa direzione, per aprire la partita, c’è ora, non domani, il passaggio per la cruna dell’ago, la messa in atto degli Eurobond, l’avvio di un bilancio comune, la messa all’ordine del giorno di un piano europeo, di una programmazione per un diverso modello economico, sociale, ecologico, democratico.
Si parla troppo spesso di un nuovo piano Marshall, dimenticando le politiche neoliberiste che l’hanno duramente accompagnato, e che esso venne dall’esterno. Forse, sarebbe meglio, se proprio si vuole trovare un ascendente a ciò che si deve fare, riferirsi al New deal di Roosevelt dopo la crisi del ’29. In una contesa che non è mai del tutto vinta né del tutto persa ci sono però dei passaggi stretti, molto incidenti sulla prospettiva. Questo sugli Eurobond è uno di questi. L’Eurogruppo, i governi europei avrebbero già dovuto decidere, siamo ancora invece nel guado, ma purtroppo l’esito è pressoché pregiudicato. Il rinvio sugli Eurobond ha una pesante palla di piombo al piede che dà un forte potere di decisione al fronte neoconservatore.
Le altre misure adottate hanno un impatto marginale rispetto alla gigantesca perdita di reddito prevista nell’anno e hanno una modalità di attuazione incerta e tempi insicuri. Quello che sta accadendo in Italia sulle provvidenze del governo, rispetto a chi ne dovrebbe fruire e ne avrebbe già dovuto fruire, ne è una spia drammatica ed evidente. Lo stesso Sure, quello per cassa integrazione e disoccupazione, entrerà in vigore dopo che sarebbe ratificato dai 27 Stati. Del Mes, conosciamo la sua pessima storia e l’ambiguità è il limite dell’ultima sua formulazione, l’incertezza del suo uso.
La palla è stata fatta correre nell’inseguimento del recovery plan, un piano di rilancio proposto dalla Francia, di cui l’accordo dice poco e male. Né si capisce come quel che è stato rifiutato ieri possa essere accolto domani, dopo che il fronte degli Stati che si era costituito per ottenere gli Eurobond si è disunito. La Francia di Macron è tornata a privilegiare il suo asse storico, l’alleanza con la Germania e perfino la Spagna del governo delle sinistre si è ritirata dalla contesa. Il governo italiano ha fin qui mantenuto la richiesta che era quella comune di tutto il fronte, ma è rimasta isolata e al suo interno si vede affiorare la tendenza di accettare “quel che passa il convento”, provando a mitigarne le conseguenze più allarmanti.
Il rinvio sulla discussione sul recovery plan non è peraltro neppure neutrale, infatti bisognerebbe ora risalire alla corrente che ha portato al pessimo accordo dell’eurogruppo in una condizione politica nel rapporto tra gli Stati più difficile di quello che lo ha preceduto. È l’Europa reale che prende ancora una volta il sopravvento sull’Europa possibile e ora, alla luce dell’emergenza, persino assolutamente necessaria. Se quest’ultima risultasse sconfitta, bisognerebbe riprendere la riflessione sulla struttura dell’Ue, sul suo deficit democratico, sulle sue forme di governo e sulle sue esclusioni. Si allungherebbe, così, certamente, il cammino, ma è inevitabile, dopo una sconfitta. Se si è dovuto pensare al ricorso agli Eurobond è anche perché la Bce, diversamente dalla Federal affair e dalla Banca d’Inghilterra, non stampa moneta, e perché l’Europa patisce le conseguenze politiche della separazione della Banca centrale del Tesoro.
Dunque, può essere che sia necessario fare un passo indietro per farne due avanti, senza dimenticare però che il passo indietro non è una scelta, ma è imposto da una sconfitta, e che i due passi avanti sarebbero tutti da fare e certo non in una condizione politicamente favorevole. Se l’Europa possibile e necessaria, anche in questa occasione, risultasse sconfitta – come purtroppo sembra probabile – bisognerà ragionare a fondo anche sulle sue ragioni, sul perché possa darsi una così drammatica contraddizione tra la maturità storica di una svolta e la sua negazione nella realtà concreta.
Sarà necessario farlo anche per sottrarsi all’occupazione dell’intera scena politica europea di una dialettica regressiva tra i neoconservatori dell’Europa reale e i sovranisti di ogni genere e specie alla ricerca di uno Stato nazionale sovrano che non c’è mai stato, né può esserci, se non all’interno di un determinato e storicamente definito conflitto di classe. Forse allora a un nuovo ciclo di quest’ultimo su scala europea ci si dovrebbe rivolgere e ci si dovrebbe pensare.