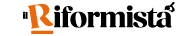Alessandro Natta è stato davvero quel che Longo era stato per finta: un segretario di transizione. La morte di Berlinguer era stata tanto improvvisa quanto, vent’anni prima, quella di Togliatti, trovando però un partito ben più smarrito, diviso, privo di bussola. Privo anche di una figura come quella di Longo, il cui leggendario passato di combattente e di comunista della prima ora gli conferiva l’autorità e la popolarità necessarie per prendere in mano il partito orfano.
Natta, classe 1918, aveva allora 67 anni. Nato a Oneglia in Liguria da famiglia cattolica e agiata, era militare in Grecia l’8 settembre 1943 ed era stato pertanto internato nei campi di prigionia tedeschi, esperienza che avrebbe poi raccontato in un celebre libro, L’altra resistenza. Rientrato in patria nel 1945 si era iscritto quasi subito al Pci e nel 1984 aveva già alle spalle 10 legislature in veste di parlamentare, a partire dalla prima elezione nel 1948. Collaboratore stretto di Togliatti e poi di Berlinguer, era un leader di grande e raffinata cultura. Laureato alla Normale di Pisa, appassionato conoscitore del latino e del greco, amico del grande latinista Scevola Mariotti e del filologo Sebastiano Timpanaro, con i quali era in contatto continuo, adorava infarcire i suoi discorsi, in aula e fuori, di citazioni latine.
Storica l’espressione allibita di Onofrio Pirrotta, Tg2, quando, a domanda sulla situazione politica, il comunista rispose fluido: “Multa renascentur quae iam cecidere” (“Molte cose date per cadute possono tornare”). Al Tg2 dovettero cercare di corsa un traduttore. Non tutti conoscevano Orazio. Nei confronti dei movimenti giovanili e sociali del decennio precedente, a partire dal ‘68, Natta era stato diffidente. “Estremisti borghesi” li aveva definiti e proprio a lui era toccato il ruolo di pubblico accusatore nel processo contro gli eretici del manifesto che si concluse con la loro radiazione del partito. Aveva condiviso la linea di crescente autonomia dall’Urss di Togliatti e di Berlinguer, la via italiana al comunismo, l’eurocomunismo, l’avvicinamento alle forze socialdemocratiche europee. Ma con maggiore prudenza del suo predecessore.
Natta doveva la nomina a segretario, che non aveva cercato e forse neppure voluto e che non si aspettava affatto, all’incarnare la figura più rassicurante tra i dirigenti comunisti dell’epoca. Sembrava il più capace di mediare tra le aree ormai apertamente divise del partito: i miglioristi di Napolitano e Chiaromonte, la sinistra ingraiana, i filosovietici di Cossutta, i giovani emergenti, impazienti e insofferenti, tra cui spiccavano D’Alema e, con qualche anno in più sulle spalle, Achille Occhetto. Natta mediò. Le divisioni si accentuarono nel corso del decennio ma non esplosero. Il prezzo fu la rinuncia a impostare una linea politica chiara e una strategia efficace da offrire a un partito che, dopo il fallimento del compromesso storico, era privo di entrambe e che neppure l’ultimo Berlinguer aveva saputo compiutamente definire e indicare.
Nelle elezioni europee del 1984, pochi giorni dopo la morte di Enrico Berlinguer, il Pci era risultato, per la prima e unica volta, come primo partito. Natta provò a bissare l’anno successivo, in una importante tornata di elezioni regionali, caricando di valenza politica nazionale quelle amministrative. Il risultato, il 12 maggio 1985, fu deludente. Poco dopo arrivò la mazzata del referendum sulla scala mobile, lo scontro frontale tra il craxismo, aggressivo e rampante, e la resistenza del Pci. L’abrogazione della riforma della scala mobile, voluta dal Pci, fu sconfitta. I no ottennero il 54, 3%. Il Pci si consolò con il risultato dei Sì, un 45,7% che andava ben oltre il bacino di voti comunisti. Era una consolazione illusoria. La sconfitta nelle urne coronava quella sociale compiutasi con il trionfo della Fiat nei 35 giorni del 1980.
Natta tentò la carta di un congresso di rilancio. Mirava a un’impossibile quadratura del cerchio: trasformazione nella continuità. La scelta dello schieramento a fianco delle socialdemocrazie occidentali fu esplicita ma la presa di distanza dall’Urss restò invece in sospeso. Si lasciò spazio ai “giovani” ma senza cesure reali nel gruppo dirigente, che restò in mano ai sessantenni. Soprattutto il Pci di Natta non riuscì neppure a impostare un’analisi dei mutamenti sociali che colpivano la sua tradizionale base sociale operaia e a elaborare una strategia per fronteggiare L’offensiva senza tregua di Craxi. Le elezioni dell’87 furono una batosta durissima che decretò la fine della segreteria Natta, orchestrata per la prima ma non ultima volta da Massimo D’Alema.
Nel maggio 1988 il segretario fu colpito da un leggero infarto. In ospedale gli furono preannunciate le sue dimissioni a favore di Occhetto. Chiese di posticipare il passaggio di consegne di qualche mese, fino a ottobre, in modo da poter essere presente alla fatale Direzione. Gli fu assicurato che sarebbe andata così. Poi apprese dalla radio, ancora in ospedale, che si era invece dimesso subito. La prese malissimo. Scrisse una lettera alla Direzione rimasta poi secretata per anni: “Compagni, non vi siete comportati lealmente. C’è stato un tramestio, davanti alla mia stanza d’ospedale. Quello che avete fatto per me è stato offensivo, perché erano cose del tutto non necessarie”.
Uomo scevro di ambizioni, era pronto, come scrisse lui stesso, a “tornare umile frate”. Avrebbe preferito farlo con rispetto e trasparenza. L’episodio della sua defenestrazione illustra una caduta di stile nei rapporti interni al partito destinata a proseguire e ingigantirsi egli anni successivi, sia nel Pci che nel successivo Pds e poi nei Ds.
La segreteria di Natta fu senza dubbio statica, incapace dello slancio coraggioso che sarebbe stato necessario per fronteggiare una crisi profonda e latente del Pci, di cui la caduta del Muro, l’anno seguente, fu solo il fattore scatenante.
Eppure forse mai come in quegli anni il Pci e la sua cultura cambiarono, sia pur non per spinta e decisione del segretario. Sino a quel momento, anche nel “partito nuovo” di Togliatti e nel tentativo fallimentare di incontro con la Dc di Berlinguer, il Pci era stato, nelle sue radici, il partito della classe operaia. Negli anni ‘80, con la rivoluzione industriale postfordista che muoveva già passi da gigante, dopo una sconfitta operaia senza precedenti, diventò un’altra cosa. Un partito pacifista, ecologista, per la prima volta attento alla differenza di genere, contrario ai blocchi, impegnato sul fronte dei diritti civili quanto e più che su quello dei diritti sociali. Quando di lì a pochissimo fu sepolto dai detriti del muro crollato, del partito di “Gramsci, Togliatti, Longo, Berlinguer” restava già molto poco.