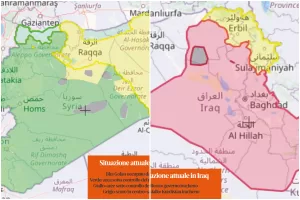Editoriali
Arte & Cultura, il brand che crea un’atmosfera

Spostare altrove la responsabilità delle decisioni è una tattica vecchia quanto il mondo, non solo in politica. “Papà ha detto così” è la versione mammista della tecnocrazia come stile di governo. In tempi di grave crisi delle classi dirigenti è normale che qualcun altro debba assumersi la responsabilità di pianificare e ideare, come quando le aziende in crisi chiamano i consulenti esterni prima di licenziare.
Questo preambolo per dire che già in partenza non mi aspettavo molto dal piano di rilancio nazionale di Vittorio Colao e soci, presentato in questi giorni al presidente del Consiglio. Non perché non sia convinto che i membri del comitato non siano tutti stimabili esperti nei loro campi. Ma proprio perché tutta l’operazione delle varie task force è inquadrabile in una dinamica risaputa, che nel migliore dei casi serve per prendere tempo fino alle vere decisioni e nel peggiore per non approdare veramente a nulla. Leggendo le paginette del rapporto però lo scetticismo mi si trasforma in fastidio.
Tralascio ciò di cui non mi intendo, che è molto, e mi concentro sulla parte “Turismo, Arte e Cultura, brand del Paese”, titolo che fa grande dispiego di maiuscole e mette in ordine gerarchico le preoccupazioni di chi ha lavorato a queste proposte: salvare la stagione turistica 2020 e mettere a frutto il famoso “patrimonio artistico” nazionale, quel petrolio italiano che secondo la vulgata ci renderà tutti ricchi e felici.
Alla fine, la maggior parte dello spazio è dedicato al settore turismo, alla creazione di nuove professionalità, all’attrazione di capitali e investimenti, etc.. Niente di male – penserà qualcuno – visto che è un settore che genera circa il 13% del PIL nazionale. Tuttavia se l’Italia dai tempi del Grand Tour è stata destinazione di grandi flussi di visitatori non è solo perché ci sono le spiagge, le discoteche e il misto mare, ma soprattutto perché città, monumenti e opere d’arte la rendevano una meta attrattiva più prestigiosa di tanti altri posti dotati di bel tempo e catering ittico.
Tutta questa tradizione, reinterpretata come “brand” dell’Italia, è vista come una specie di giacimento dal quale estrarre ricchezza, sostanzialmente consumandola e vendendola. In effetti scorrendo la parte finale del capitolo gli unici accenni a dove si situi questa “miniera” della cultura fanno riferimento ai musei, che vanno rinnovati, potenziati e in cui bisogna portare investimenti privati e in un incremento dei siti riconosciuti dall’UNESCO per l’Italia.
Per citare un altro avvocato Conte (Paolo, da Asti) “son gente per cui le arti stan nei musei”. L’idea che arte e cultura siano soprattutto produzione e una produzione contemporanea e non un giacimento di roba verghiana ereditata dal Rinascimento non sembra essersi fatta strada tra le slide.
Le dinamiche culturali di un paese influenzano anche il rapporto con l’antico e con le istituzioni museali, che sono in profonda trasformazione. Da bene culturale si parla sempre più di comunità culturale. Secondo la Convenzione di Faro il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. L’eredità culturale è una responsabilità individuale e collettiva e il suo uso sostenibile ha come obiettivo lo sviluppo della qualità della vita.
Tutto il contrario dall’over-tourism sfruttatorio che ha usato i centri storici italiani come zone estrattive per poi abbandonarli al vuoto post-Covid. L’intera idea del “brand” e dei capitali privati che investono nei musei sembra arrivare da modelli precocemente invecchiati e che l’attuale crisi mondiale del turismo fa già apparire discutibili.
Ma soprattutto, arte e cultura si basano su idee e azioni di persone che lavorano nel campo e producono una comunità di scambi che è il vero soggetto generatore della vita culturale. L’idea di cultura che esce da queste slide è di una serie di siti e manufatti imbalsamati nel tempo da usare come investimenti immobiliari finché durano. Di queste persone e di questi scambi culturali, di questa cultura fluida e viva che incidentalmente costruisce e influisce sul tessuto sociale del paese, nelle pagine di Colao non c’è traccia.
Ma poco male, visto che poi nel piano non c’è nessuna indicazione pratica su come e quando veramente trasformare queste generali indicazioni in decisioni politiche. La palla ripassa alla politica, sempre in attesa che essa recuperi le competenze all’interno delle sue stesse istituzioni (dove comunque non mancano) e
che si dimostri una buona volta più coraggiosa e più visionaria nell’immaginare il futuro. Perché oggi, oltre ad avere una visione è anche necessario essere un po’ visionari.
*Duquesne University Rome
© Riproduzione riservata