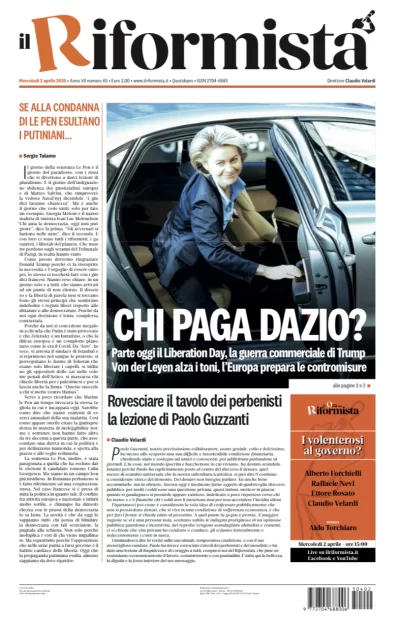L’Europa è sola. Me la immagino come un ragazzo circondato da tre bulli – Stati Uniti, Cina e Russia – che lo spingono contro il muro. La Conferenza di Monaco ha squarciato il velo dell’ipocrisia: il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, non si è rifugiato dietro le consuete formule di circostanza, ma ha detto chiaramente ciò che fino a poco tempo fa si poteva solo intuire. L’Europa va destabilizzata e, se possibile, anche sgretolata. Un progetto enunciato senza reticenze, che solleva una domanda inquietante: che fine ha fatto il patto euro-atlantico siglato dopo la Seconda guerra mondiale? Abbiamo commesso errori fatali negli ultimi anni?
Sappiamo che Mosca non ha mai smesso di lavorare per indebolire l’Unione, mentre Pechino gioca su più tavoli, sfruttando la fragilità del continente per rafforzare la propria posizione globale. E Washington? Da alleato storico è diventato – paradosso dei nostri tempi – un competitore spietato: l’Europa non è più un partner, ma un ostacolo alla ridefinizione del nuovo ordine mondiale. Come giustamente osserva Guido Crosetto, ministro della Difesa, Trump ragiona in termini affaristici: se ci sono benefici, allora si affrontano i costi (se sei un cliente e magari possiedi “terre rare”, allora se ne può parlare); in caso contrario, i Paesi deboli vengono abbandonati al loro destino. Alla faccia del diritto internazionale.
Il crudo pragmatismo del ministro della Difesa, sommato al discorso odierno di Mario Draghi al Parlamento europeo, impone una riflessione limpida: o l’Europa si ricostruisce, oppure crolla, avendo smarrito la sua traiettoria politica originaria.
Sin dalla sua nascita, il progetto europeo non è mai stato solo un’architettura economica o burocratica, ma una visione politica e culturale fondata su principi inalienabili. Jacques Delors, uno dei padri dell’Unione, insisteva sulla necessità di costruire un’Europa forte e duratura attorno ai suoi diritti fondamentali, al primato della persona, all’inclusione e alla democrazia. Un’Unione che si regga su una solidarietà effettiva tra i suoi membri, su un progetto concreto di difesa comune e su una rinnovata coesione tra i Paesi fondatori e tutti gli Stati aderenti dovrebbe cambiare l’agenda dell’Unione. Se l’Europa saprà davvero ricompattarsi attorno ai suoi valori, trasformando le sue debolezze in un progetto politico di grande respiro, potrà finalmente smettere di essere il bersaglio della prepotenza altrui.
Non siamo necessariamente al punto zero di questa storia ma serve uno scatto di reni, la consapevolezza di dover diventare un attore geopolitico strutturato e non il ventre molle delle crisi globali. In termini economici, l’Europa non avrebbe nulla da invidiare ad altri blocchi per PIL, know-how, progetti di crescita, bilancia commerciale, valore dell’export. Ma – come sottolinea Draghi – è appesantita da vincoli interni, indecisioni, squilibri tra Paesi trainanti e Paesi a rimorchio nell’Europa centro-orientale, iper-burocrazia e triangolazioni farraginose tra i livelli istituzionali. Questi freni sono anche il prodotto dell’inerzia degli ultimi anni a Bruxelles.
Eppure, la narrazione del “liberi tutti” ci porta a sbattere, mentre il coraggio di pensarsi come uno “Stato unico” è la chiave per una visione positiva. Diciamolo con una provocazione: e se iniziassimo a parlare di “sovranità europea”, una sovranità centripeta (e non centrifuga) capace di tutelare gli interessi continentali?
A quel punto, l’Europa non sarà più un bersaglio facile.
L’immagine dei tre bulli si rovescerà: un’Unione più solida e sicura di sé non sarà più la vittima da isolare, ma il quarto attore globale, capace di sedersi al tavolo dei giganti non da spettatore, ma da protagonista. Perché la forza non risiede solo nella potenza economica o militare, ma nella capacità di incarnare un modello di società giusto, equo e inclusivo.
Se l’Europa saprà farlo, non solo si difenderà, ma potrà persino imporsi come l’attore che riscrive le regole del gioco.
© Riproduzione riservata