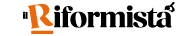Chissà che singolare sensazione susciterebbe oggi la sagoma stessa di Joseph Beuys, artista, performer, protagonista di se stesso, della propria leggenda; scultore, se solo questa categoria resa inutilizzabile in senso stretto dalle avanguardie potesse racchiuderne la cifra. L’uomo è alto, silenzioso, il cappello di feltro grigio sempre con sé, come fosse una corona, una mitria, magari una tiara personale, la sua, gilè da pescatore, anche questo un simbolo, a suo modo, religioso, militante.
Quando le avanguardie erano invece contemplate con quotidiana stupita ammirazione, scorgere Beuys che raggiunge il perimetro ideale del proprio happening permanente, meglio, il cerchio di gesso del Caucaso dell’arte, per citare il conterraneo Bertolt Brecht, suggeriva la sensazione di assistere ai preparativi e alle prove dello sciamano. La sua figura, il suo silenzio, i gesti, a coincidere con l’opera. Avrebbe compiuto cento anni il prossimo 12 maggio, Beuys. L’uomo nasce infatti nel 1921 a Krefeld, Germania, l’infanzia nella Hindenburg-Oberschule di Kleve, e presto l’adesione alla Hitler-Jugend, la Gioventù hitleriana. La guerra ce lo fa scorgere dietro la carlinga di un aereo, sergente radio-mitragliere della Luftwaffe, presto abbattuto per dono del destino. Si racconta che il senso narrativo, forse anche alchemico della sua intera opera, giunga dal modo in cui troverà salvezza. Marzo 1944, durante una missione di guerra sul Fronte orientale, il suo Stuka precipita al suolo in Crimea. Verrà recuperato il giorno dopo da una squadra di soccorso e ricoverato in un ospedale tedesco. Sosterrà invece di dovere la vita salva a una tribù di nomadi tartari, alle loro segrete remote pratiche mediche.
Una sua installazione, sempre a suo modo, concettualmente, celebra plasticamente l’accaduto: un furgone Wolkswagen, una fila di slitte che custodiscono torce, feltro e grasso di coniglio. Esattamente i materiali della cura, li porterà sempre con sé, disponendoli di volta in volta, cominciando da quel tessuto. Forse anche il borsalino fisso sul capo, probabilmente a nascondere una calotta di metallo, innalza ancora una volta il simbolico delle materie e degli oggetti ai suoi occhi apotropaici. Nel suo ideale “Mutus Liber”, manuale per trasformare il metallo vile in oro, nel suo caso nell’oro dell’arte, di Beuys si racconta ancora che a scrivergli i discorsi fosse una ex SS, sembra ancora che negli anni Cinquanta si sarebbe candidato con un partito di ispirazione hitleriana. Resta però che se da decenni la città di Kassel è sinonimo di arte, con la rassegna “documenta”, la D rigorosamente minuscola, lo deve a Beuys, così come sempre a lui appartiene l’immagine dell’artista impegnato in una battaglia politica di riscatto ecologico, sebbene il concetto in Beuys assuma un significato ulteriore, magico, utopistico, appunto.
“La rivoluzione siamo noi” racconta un multiplo fotografico che ne mostra la sua figura intera in cammino. Oppure: “Difesa della natura”. Anche la zappa è un simbolo che ne accompagna la volontà politico-cerimoniale. Joseph Beuys muore a Düsseldorf il 23 gennaio 1986. Si narra pure di quando, giunto in Italia nei primi anni Ottanta, dopo una sosta a Napoli con Andy Warhol, figure antitetiche eppure entrambe certe d’avere pronto un trono nel “secolo breve”, va ospite in Sicilia, a Giardini Naxos, del barone Gianni Pennisi di Floristella, con questi che lo esorta a lasciare dono di sé: «Senti, Beuys, tutti quelli che vengono qui devono disegnare qualcosa», Beuys allora con un carboncino traccia la figura di un cervo sul muro della “tavernetta” della villa del gentiluomo; il cervo, a suo modo, simbolo di una mitologia cristologica e insieme pagana.
Poco dopo, nel Natale del 1981, la tappa a Gibellina, la cittadina ricostruita dopo il terremoto del 1968 con il contributo degli artisti, nella Valle del Belìce, a seguirne il soggiorno trova un grande fotografo, Mimmo Jodice, straordinario lo scatto che lo mostra di spalle mentre contempla il piccolo cimitero della città abbandonata: cappello, taccuino, come a voler comporre un erbario, prendere nota dell’intero catasto naturale del mondo. Se il profano dovesse adesso giustamente domandare di cosa esattamente sia composta l’opera di Beuys, oltre le slitte, il feltro il grasso le torce, e ancora quel pianoforte vestito interamente da una “gualdrappa” ancora di feltro segnato da una croce rossa, anche questo simbolo di salvezza, potremmo dire che, a suo modo, l’uomo ha fatto dono all’arte delle proprie “reliquie”.
Particole del suo esistere al mondo della propria affermazione, perfino da soggetto politico agente, espressione, anzi, precipitato vivente della memoria del tempo della guerra, la Germania al suo “anno zero”, tra le macerie lasciate dal nazismo nei suoi inemendabili crimini, esatto, un alchimista: sembrava quasi che ogni oggetto, fosse anche un foglio di giornale, o una banconota, una volta da lui timbrati con il bollo ufficiale della Free International University (Fiu), improvvisamente, assumesse l’aura dell’arte e l’imprimatur del suo significato ulteriore. Forse Beuys avrebbe anche voluto camminare sulle acque come Christo sul Lago d’Iseo o altri irripetibili maestri dell’avanguardia, o restare nella memoria collettiva insieme alla scia di fuoco dello Stuka che scende in picchiata fino a frantumarsi al suolo del secolo.