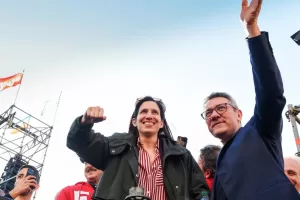La scelta del Pontefice
Chi sono i nuovi cardinali nominati da Papa Francesco, non schierati e sempre accanto agli ultimi

Per chi vota Papa Francesco? Alle elezioni Usa sicuramente per Biden, ci dicono diversi arguti commenti di cui si parla da domenica. E la “prova” è presto “provata”: ha nominato un cardinale “afro” (l’arcivescovo di Washington) e dunque in automatico il Papa è per la linea aperta e “democratica” dell’arcivescovo. Se fosse vero, se bastasse così poco, forse potremmo cominciare a chiedere per chi vota il Papa come sindaco di Roma. Perché proprio non passa, ai commentatori (o presunti tali), il vizio di interpretare ogni azione della Santa Sede in chiave di politica interna di qualche nazione.
È un onore ricevuto da Giovanni Paolo II che quando andava in viaggio all’estero – dal Cile all’Indonesia – e parlava, che so, di aborto, o di ruolo della politica e di doveri dei politici, sembrava sempre rivolgersi ai parlamentari o ai governi italiani. È un sistema ben rodato e consolidato quello di far litigare il Papa di turno con i politici e magari serve a far vendere più copie. Però non spiega affatto la peculiarità delle scelte del pontefice. Anzi qui poi, a ben guardare, c’è un vago sapore razzista: fa davvero notizia la nomina di un cardinale afroamericano? Piuttosto la notizia sarebbe sul perché ce ne sia soltanto uno e sul perché la maggioranza dei vescovi Usa siano bianchi, in un paese ispanico oramai al 30% e più.
Invece di stupirci là dove non c’è niente da scoprire, andiamo a vedere il significato di un gesto di governo di esclusiva pertinenza del Papa regnante: la nomina di nuovi cardinali. Del resto un solo statunitense – sebbene sia l’arcivescovo di Washington – non sposta né il baricentro della politica e tanto meno il baricentro della Chiesa negli Usa. E non ci dice nulla delle preferenze politiche del Papa in tema di elezioni presidenziali. Non corre in campagna elettorale e non fa politica politicante. Piuttosto agisce da Papa con uno stile diverso dai suoi predecessori. E queste nomine lo confermano una volta di più. E intanto vediamole.
Il primo della lista è mons. Mario Grech, maltese, 63 anni, di recente nominato segretario generale del Sinodo dei vescovi, in uno snodo chiave per la definizione dei temi e dei rapporti tra Santa Sede ed episcopati e abbastanza giovane da reggere a lungo le redini delle assise che porteranno la Chiesa ad affrontare le sfide del futuro. Abbiamo poi sei cardinali italiani: il primo è mons. Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, dopo che il cardinale Becciu si è dimesso da tale carica e ha rinunciato ai diritti del cardinalato, tra i quali figura appunto quello di entrare in Conclave. Segue mons. Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e segretario della Commissione episcopale per le Migrazioni della Cei, noto per il suo impegno a fianco dei rom. Diventa cardinale senza essere vescovo (non è una notizia: si può fare!) il frate francescano Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi. E questi tre sono elettori, avendo meno di 80 anni.
Gli altri tre italiani ultraottantenni sono mons. Silvano Tomasi, arcivescovo titolare di Asolo e nunzio apostolico, padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia – volto noto anche della televisione – e soprattutto mons. Enrico Feroci, che ad 80 anni suonati è ancora parroco, a Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva e per molto tempo è stato direttore della Caritas di Roma a contatto con i più scottanti problemi sociali della capitale. Tra i cardinali non italiani c’è una “prima assoluta” per il Ruanda e il Brunei, con mons. Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, e mons. Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei.
Per gli Usa, come detto, c’è mons. Wilton D. Gregory, arcivescovo di Washington, il primo cardinale afroamericano; mons. José F. Avincula, arcivescovo di Capiz, nelle Filippine, e mons. Celestino Aòs Braco, arcivescovo di Santiago del Cile. Papa Francesco, oltre ai tre cardinali italiani non elettori, ha deciso infine di unire al Collegio cardinalizio mons. Felipe Arizmendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristobal de Las Casas, in Messico: un riconoscimento per la teologia india e per l’impegno speso dal vescovo a favore delle popolazioni del Chiapas nei lunghi anni (leggi i predecessori di Francesco) in cui di teologia india non si poteva parlare. Con il concistoro del 28 novembre i cardinali diventano 232, di cui 128 elettori, otto in più rispetto al limine massimo stabilito da Paolo VI ma più volte superato dai suoi successori. I porporati elettori torneranno ad essere in 120 al massimo nell’aprile 2022 (nel 2021 compiranno 80 anni in sei, mentre saranno in 11 nel 2022).
Dopo il prossimo Concistoro i cardinali elettori creati da Papa Francesco saranno 73, 39 quelli di Benedetto XVI e 16 quelli di Giovanni Paolo II. Gli europei saranno 53 (di cui 22 italiani), i latinoamericani 24, gli africani 18, gli asiatici 16, i nordamericani 13, 4 i provenienti dall’Oceania. Dopo quella italiana (22) la componente più nutrita continuerà ad essere quella statunitense (9) seguita da quella spagnola (6). Brasile, Canada e Francia ne hanno 4. Germania, India, Messico, Polonia e Portogallo 3. Le statistiche servono a smontare qualche tesi precostituita di queste ultime 48 ore. Qualcuno ha detto che il collegio cardinalizio diventa ad “immagine” di Papa Francesco, dimenticando l’ovvia considerazione che più a lungo un papa regna, più cardinali nomina. Ma in caso di Conclave è tutto da dimostrare che un Papa attraverso le nomine sia in grado di “condizionare” la scelta del successore. Basta guardare al Conclave dopo Giovanni Paolo II che portò Ratzinger, il quale era stato creato cardinale da Paolo VI nel 1977 (e non da Giovanni Paolo II. Per dire!).
Quanto alla caduta di peso specifico della componente italiana sicuramente c’è, ma procede lentamente ed è mitigata dal fatto che il continente europeo, sebbene il cattolicesimo sia generalmente e quasi ovunque in calo, ed i preti pure, ha sempre numeri rilevanti in Curia e nel collegio cardinalizio. Si conferma invece un dato che non fa notizia perché non riguarda aspetti politici ma ecclesiali. Papa Francesco nella sua visione geopolitica della Chiesa, si dimostra attento al versante pastorale, cioè diventano vescovi e cardinali quei sacerdoti capaci di operare scelte ed agire in concreto dalla parte della gente. Non è populismo ma attenzione alle persone ed alle loro esigenze di senso per la vita.
I vescovi di sedi un tempo considerate tradizionalmente cardinalizie – ad esempio le città o le capitali di maggiore importanza – non vengono creati cardinali in automatico come accadeva con spesso nel Novecento e nei primi anni Duemila. Un criterio di scelta è la caratura pastorale e la capacità di esprimere nei fatti atteggiamenti di vicinanza, prossimità, misericordia, fratellanza. Da parabola del Samaritano, appunto. Questa, almeno, è la Chiesa secondo Papa Francesco.
© Riproduzione riservata