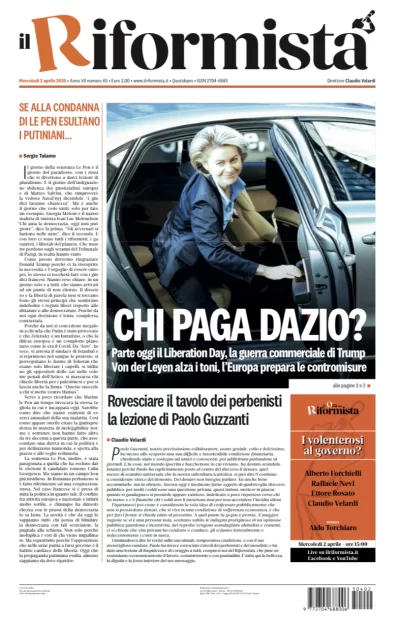Il guzzantino
Cosa è successo nel 1973: fine della guerra in Vietnam e golpe in Cile

Che sensazione amara e lontana tornare a frugare nel 1973, un anno che, come tanti altri può meritare il titolo di anno fatidico della grande svolta. Non fu una sola svolta. Ma molte di più. Fondamentalmente per due eventi e le loro conseguenze. Nel 1973 si chiuse con la catastrofe dei diplomatici in fuga con gli elicotteri da Saigon la guerra del Vietnam con la sconfitta militare americana. Una dura e amara lezione che gli americani hanno capito e digerito con qualche decennio di ritardo e, bisogna dire, con una capacità autocritica di cui noi non abbiamo la più pallida idea. Il secondo evento fu il Cile con il colpo di Stato con bombardieri sul palazzo presidenziale che rovesciò il governo del presidente Salvador Allende per instaurare un regime militare feroce come quello della Junta argentina degli anni successivi, e che sarà abbattuto dalla fermezza di Margaret Thatcher nella guerra delle Falkland.
Quel colpo di Stato fece da innesco ad una svolta fondamentale anche se destinata al fallimento: Enrico Berlinguer, segretario del Pci, trarrà da quella disavventura che mostrava la realistica logica brutalità della guerra fredda tra superpotenze, la ragione logica e politica per rilanciare qualcosa di simile alla svolta di Salerno che Palmiro Togliatti portò in Italia abbandonando la sua residenza all’hotel Lux di Mosca. E quell’oggetto misterioso diventò subito popolare con il nome di Compromesso Storico. La storia del compromesso storico di Enrico Berlinguer è ancora oggetto di molte interpretazioni tra le quali io inclino per quella suggerita dalla raccolta dei documenti della Cia che fu pubblicata in Italia. Ciò che ho imparato come giornalista e poi come parlamentare presidente di una Commissione d’inchiesta sulla vicenda del dossier Mitrokhin è che la “guerra fredda” non fu affatto un conflitto tra ideologie, ma il mascheramento di un vero conflitto militare latente, non poi così freddo.
La guerra del Vietnam provocò quasi due milioni di morti e si svolse nella zona calda della guerra fredda, come lo era stata la guerra di Corea nel 1950 quando la Cina scatenò un attacco per impadronirsi della Corea oltrepassando il trentottesimo parallelo. E poi la guerra si manifestava all’improvviso in altri teatri, come l’attacco alla Casa Rosada in cui Salvador Allende si difese fino all’ultimo colpo dell’arma che gli aveva portato in regalo da Cuba Fidel Castro L’ultimo colpo lo riservò a se stesso. Anche quella fu guerra fredda. Come lo era stato il colpo sovietico a Praga nel 1968. Il golpe in Cile di Pinochet fu la risposta brutale organizzata dalla Cia contro la crescente presenza sovietica in Sud America alla maniera con cui il regime egiziano di Abdel Fattah el-Sisi è stato la risposta brutale contro la jihad dei Fratelli Musulmani.
Sono stato molte volte nel Cile di Pinochet come inviato di Repubblica e mi è capitato di alternare le mie permanenze in Cile a quelle nella Polonia in cui il generale Jaruzelski aveva instaurato un auto colpo di Stato per impedire che al suo Paese capitasse quel che era già successo prima all’Ungheria nel 1956 e poi alla Cecoslovacchia. A Santiago durante la dittatura militare le librerie erano piene zeppe di testi marxisti e castristi non perché il regime fosse liberale, ma perché ignorava la cultura non essendo una questione militare. Al regime non importava quel che pensava la gente. Il mio spagnolo migliorava e mi permise il lusso di leggere davanti alla finestra sulla piazza del palazzo che era stato di Allende, il capolavoro di Gabriel Garcia Marquez El amor en los tiempos del còlera in un’edizione con la copertina gialla ormai corrosa dalle riletture.
Sulla piazza i generali avevano trasformato in monumento un’automobile esplosa che avrebbe dovuto colpirli con un’azione della “Izquierda Unida”. E scoprii con incredulità che nella Santiago del regime di Pinochet esisteva un quartiere periferico in cui era arroccata la resistenza della sinistra unita con il suo pueblo di campesinos e che si entrava e si usciva da quella cittadella come attraverso il “checkpoint Charlie” che divideva le due Berlino. Era mai possibile che il regime militare di Pinochet consentisse l’esistenza di un intero quartiere di legno sui cui spalti sventolavano le bandiere rosse con la falce e il martello? La paradossale risposta è sì, perché ai colonnelli cileni non importava nulla delle ideologie ma servivano soltanto uno scopo militare. Scoprii nei miei viaggi successivi al golpe (fu allora che la parola spagnola “golpe” entrò nel nostro vocabolario sostituendo “colpo di Stato”) che in Cile viveva una intera nazione tedesca in una enorme area che si chiamava “Colonia Dignidad” in cui si parlava ancora un tedesco ottocentesco. I cileni avevano pascoli con mucche bavaresi e indossavano calzoni di pelle e penne sul cappello. Da quella parte del Cile venivano i quadri dell’amministrazione e militari.
Dall’altra parte, a Varsavia qualche anno più tardi, in un negozio potevi trovare fra tante mensole vuote un unico colbacco malconcio e pagarlo una fortuna. A Varsavia lo Stato era attento alle librerie: letteratura cattolica sì, letteratura comunista castrista, no. Avevo un amico, Cristoph, un buon comunista intellettuale che pretendeva di condire la pasta col ketchup e quando gli spiegavo che nella Santiago di Pinochet si poteva comprare la letteratura castrista che non trovavo nelle librerie di Varsavia, mi guardava come se fossi un agente provocatore. Penso oggi di avere avuto un’enorme fortuna nel fare il mestiere che ho fatto specialmente a Repubblica perché Eugenio Scalfari mi fece partire per ogni angolo del mondo per scoprire frammenti di realtà che facevano a pugni con le versioni accreditate dal politicamente corretto, sia di destra che di sinistra.
Berlinguer lo sapeva benissimo essendo stato cooptato dal gruppo dirigente della vecchia guardia togliattiana. E aveva capito che se voleva ottenere i due risultati più ambiti – tagliare il cordone ombelicale con l’Unione Sovietica e portare il suo partito al governo – avrebbe dovuto passare attraverso le forche caudine di un compromesso. Storico, ma non inedito: il Pci di Togliatti aveva già votato l’articolo 7 della Costituzione che convalidava i patti di Mussolini col Vaticano, perché per lui l’obiettivo di conquistare le “masse cattoliche” (tutto si divideva in “masse” a quei tempi) organizzate dalla democrazia cristiana, un partitone con dentro venti partitini, pronto ad adattarsi a qualsiasi politica realistica. Il colpo di Stato in Cile fu una iniezione di realtà e gli articoli di Enrico Berlinguer furono pubblicati non sull’Unità ma su Rinascita, un settimanale meraviglioso perché realista su cui potevi trovare la descrizione dello stato dei fatti quando ancora il partito prendeva sul serio la separazione tra politica e propaganda e rispettava la lezione marxista secondo cui la verità è la premessa per la rivoluzione e non il suo ostacolo.
L’Europa intesa come progetto di unione era ancora uno sfrontato cartello di paesi che si erano accordati per impedire la concorrenza e il libero mercato delle materie energetiche e dell’acciaio: il contrario del liberismo, senza alcun rispetto della concorrenza ma anzi l’instaurazione del monopolio come basamento su cui costruire un’Europa politica che per ora non si è vista. L’Italia intanto era sbranata da una vera libidine di guerra civile. Esisteva allora un partito neofascista guidato da un uomo intelligente e di grande qualità come Giorgio Almirante (cosa che mi stupì quando lo andai a intervistare nel suo ufficio) ma l’interdizione nei confronti dei neofascisti costituiva una sorta di riserva energetica per quella parte della sinistra che cercava di ostacolare il compromesso storico attraverso scorciatoie più o meno manesche o da guerra di religione. Tirava un’aria da Brigate Rosse nascenti e c’era stato il primo sequestro del sindacalista Labate che era stato picchiato selvaggiamente, rapato come un collaborazionista e quindi rilasciato con un comunicato in cui si diceva che aveva avuto il suo giusto processo.
Emergevano dalla cronaca aree che miravano a soluzioni di forza alimentate da altre aree indistinguibili come matrioske dentro matrioske, perché si diffondeva sempre più la commistione nazi-maoista che accoglieva i cosiddetti “cameragni” (fusione ironica di camerati e di compagni). Il terreno di coltura di questa geografia spezzettata e pretestuosa stava nella imminenza di una guerra europea che tuttavia non sarebbe mai scoppiata: una guerra militare, non ideologica. Da parte occidentale la guerra consisteva nel contenimento dell’espansione sovietica, mentre a Mosca il think-tank del Kgb di Yuri Andropov (che non era solo un servizio segreto ma una scuola di pensiero) puntava a un risultato politico da raggiungere con qualsiasi mezzo, anche militare: una Unione Europea che includesse l’Unione Sovietica (la “Eurss” secondo il titolo di un saggio di Vladimir Bukowski) che corrispondeva al progetto del generale de Gaulle di un’Europa “dall’Atlantico agli Urali”. Il significato geopolitico di allora resta attuale anche nelle vicende russe, bielorusse ed ucraine di oggi: accoppiare la capacità tecnologica dell’Europa con le risorse naturali e la potenza militare russa. A quel tempo non eravamo nelle condizioni di decifrare.
Certo è che la presenza di servizi segreti, gente di mano, agenti provocatori e infiltrati di ogni razza agiva da innesco per eventi truci e imprevedibili: bombe che uccidevano chi le stava deponendo, una famiglia di fascisti del Msi arsa viva in casa con i cadaveri carbonizzati dei ragazzi affacciati alla finestra e morti e aggressioni e bastonature e attentati. Era impossibile trovare un filo conduttore. La scelta di Berlinguer avvenne non soltanto come conseguenza del colpo di Stato cileno, ma anche per la presa d’atto di una nuova guerra civile latente in Paese dilaniato da continui scioperi e scontri con la polizia di cui approfittavano frange che puntavano a impedire qualsiasi compromesso. Quel caos ben organizzato rispecchiava gli echi del duello dei titani. La strada che aveva preso Berlinguer non piaceva all’Unione Sovietica perché l’avrebbe privata di uno strumento con cui contrastare le iniziative militari della Nato. Berlinguer aveva aperto un gioco rischiosissimo cercando di mantenere i piedi in entrambe le staffe, quella della scelta occidentale sotto “l’ombrello della Nato” (come dirà a Giampaolo Pansa del Corriere) e quella di fatto filo-sovietica di contrasto all’installazione dei missili di media gittata opposti ai missili sovietici installati sui Balcani.
La Democrazia Cristiana con le sue molteplici anime e antenne vedeva e accompagnava processi fra di loro diversi e persino opposti, ma al suo interno sempre di più si confermava la leadership di Aldo Moro, il più attrezzato per capire e appoggiare la proposta di Berlinguer. Appena letti gli articoli sul colpo di Stato in Cile, Moro con cautela snervante ma anche con realismo entrò nella prospettiva di un compromesso storico in cui avrebbe svolto lui il ruolo più rischioso e che probabilmente gli costò la vita: quello del garante per il mondo occidentale, più per gli inglesi e i tedeschi che per gli americani. Ne parleremo quando arriverà all’anno giusto, ma avverto il lettore che nella permanente diatriba sull’origine dell’operazione che portò al rapimento, interrogatorio ed esecuzione di Aldo Moro, ho maturato sui fatti una convinzione che vedo poco contrastata dal comune sentire.
Questa convinzione si formò indagando sul caso Moro e in particolare nel corso di una Rogatoria Internazionale da me presieduta a Budapest nel palazzo della Procura generale dell’Ungheria in stile assiro-babilo-sovietico, dove i procuratori magiari ci mostrarono una quantità di rapporti e documenti riservati che ci furono mostrati e poi negati per un intervento della diplomazia russa, con le prove dell’ingaggio di un certo numero di membri delle Brigate Rosse (ricordo di sfuggita Antonio Savasta) arruolati della Stasi delle “vite degli altri” e del Kgb ai tempi in cui a Budapest alloggiava la banda del venezuelano Ilich Ramirez Sanchez, noto come Carlos lo Sciacallo, il quale portò a termine un centinaio di attentati e omicidi, in particolare in Francia (dove sconta due ergastoli) e in Italia. Quei documenti, con mia parziale sorpresa, nessuno poi li ha più voluti cercare, benché la loro esistenza sia formalmente certificata da atti del Parlamento della Repubblica. È strano perché quelle carte esibite e poi non concesse documenterebbero, anzi documentano, la cosiddetta etero-direzione di una parte delle Brigate Rosse gestite dalla “fiera dell’est”, come del resto anche la logica suggerisce pose fine al tentativo del compromesso eliminando il garante democristiano con la più spettacolare, ardita e mai perfettamente ricostruita operazione di commando in un paese occidentale.
Ne parleremo a suo tempo ma voglio ricordare che tutti i colpi sparati contro gli uomini della scorta di Moro in via Fani provenivano da un’unica arma nelle mani di un uomo che a detta di una testimone parlava una lingua straniera incomprensibile dando ordini. Siamo sempre al discorso delle uova di serpente in cui si tenta di cogliere il momento in cui vengono deposte e il meccanismo a tempo che dovrebbe farle poi schiudere portando i suoi frutti crudeli.
( 1 – Continua)
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1973:
14 gennaio: viene trasmesso il concerto di Elvis Presley Aloha from Hawaii. È il primo concerto della storia della tv ad essere trasmesso in tutto il mondo via satellite
17 gennaio: Ferdinand Marcos diventa presidente a vita delle Filippine
27 gennaio: gli accordi di pace di Parigi pongono ufficialmente fine alla Guerra del Vietnam
8 febbraio: creazione della Confederazione Europea dei Sindacati
17 marzo: Elisabetta II inaugura il moderno London Bridge
24 marzo: viene pubblicato dai Pink Floyd per l’etichetta Emi l’album The dark side of the moon che resterà quasi due anni nelle classifiche di vendita americane
27 marzo: Il Padrino vince l’Oscar come miglior film
4 aprile: viene inaugurato il complesso World Trade Center a New York. Le due Torri Gemelle vengono aperte al pubblico
7 maggio: durante una cerimonia davanti alla Questura di Milano in memoria del commissario Luigi Calabresi ucciso un anno prima, l’anarchico Gianfranco Bertoli lancia una bomba a mano sulla folla per colpire l’allora ministro dell’Interno Mariano Rumor. L’attentato provocò quattro vittime e quarantacinque feriti
18 maggio: a Washington, in seguito alle rivelazioni di due giornalisti del Washington Post, viene aperta un’inchiesta sullo scandalo Watergate, ovvero lo spionaggio subito dai Democratici nel corso dell’ultima campagna elettorale presidenziale. Nell’inchiesta è coinvolto anche il presidente degli Usa, Richard Nixon
1º giugno: in Grecia un referendum abolisce la monarchia e istituisce la repubblica. Il colonnello Geōrgios Papadopoulos, già al potere dal golpe militare del 1967, diventa presidente
10 luglio: viene rapito a Roma Paul Getty III, nipote dell’uomo più ricco del mondo. Per sollecitare il pagamento, i sequestratori tagliano un orecchio al ragazzo. La liberazione avverrà cinque mesi dopo, a fronte di un riscatto miliardario
23 agosto: a Stoccolma un tentativo di rapina alla Sveriges Kredit Bank si trasforma in un sequestro di persona: è l’evento da cui nacque l’espressione “Sindrome di Stoccolma”
29 agosto: a Bari, Napoli, Palermo, Cagliari, Barcellona ed altre città del Mediterraneo scoppia un’epidemia di colera causata da una partita di mitili provenienti dalla Tunisia
23 settembre: Juan Domingo Perón è eletto presidente dell’Argentina
24 settembre: Nasce il gruppo musicale Kiss
28 settembre: in un saggio su “Rinascita” intitolato Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile, il segretario del Pci Enrico Berlinguer lancia la proposta del compromesso storico con la Dc
© Riproduzione riservata