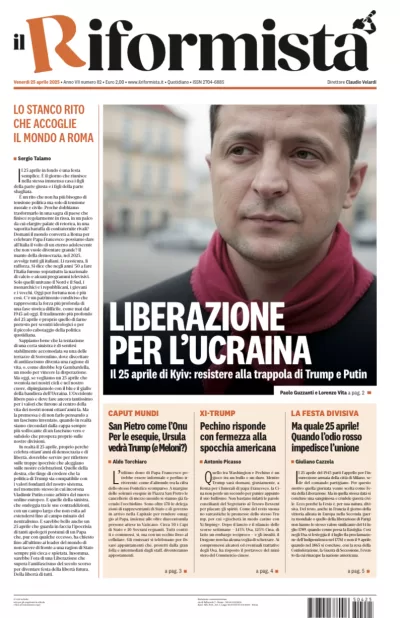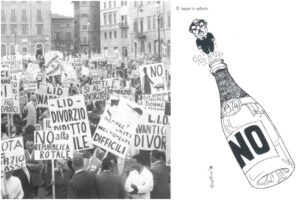Il guzzantino
Cosa è successo nel 1975: dalla guerra civile tra fascisti e rossi alla morte di Mara Cagol

Il 1975 è un anno di guerra civile latente. Molti scontri fisici tra estrema sinistra e neofascisti, in cui il numero di neofascisti uccisi superava quello dei morti di sinistra: un altro segno dell’evoluzione di una linea armata e organizzata nell’area su cui dominavano le Brigate rosse. Tirava ormai un’aria di feroce legittimazione e una voglia di resa dei conti come se la guerra non fosse finita e ne fosse in corso un’altra, latente e armatissima. Fu l’anno in cui una laboriosa sociologa di nome Mara Cagol con un assalto sudamericano al carcere in cui era recluso suo marito Renato Curcio riuscì a farlo evadere per poi morire durante lo scontro a fuoco con i carabinieri che avevano circondato i brigatisti che avevano sequestrato l’industriale Gancia al fine di ottenere un riscatto.
Fu l’anno in cui Pierpaolo Pasolini morì ucciso barbaramente a Ostia dal Rana che gli passò su e giù con la macchina sfigurandone il cadavere nel fango della più tenebrosa periferia romana. È anche l’anno in cui i Khmer Rossi del dittatore comunista Pol Pot prendono il potere in Cambogia e scatenano un genocidio che fa concorrenza per mostruosità a quelli di Hitler e di Stalin, ma anche l’anno in cui i Pink Floyd raggiungono l’apice del successo e in cui la Soka Gakkai internazionale, la versione giapponese del buddismo organizzato, viene fondata ufficialmente.
È ancora l’anno in cui seguita a trascinarsi l’eterno processo per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 in cui adesso sono imputati sia estremisti di destra che di sinistra: un processo destinato di nuovo ad arrestarsi perché è emerso un personaggio equivoco, certo Giannettini che si rivela un agente del servizio segreto Sid e la sua posizione appare tanto scandalosa quanto inspiegabile. Sicché tutto si ferma in un ingorgo di reticenze.
In Inghilterra accadono grandi cose: Charlie Chaplin viene insignito col titolo di baronetto dalla regina Elisabetta e Margaret Thatcher viene eletta leader del partito conservatore inglese e dunque candidata a diventare Prime Minister quando i tories vinceranno le elezioni. A marzo si apre il quattordicesimo congresso del partito comunista che Enrico Berlinguer vince largamente con la sua idea del Compromesso Storico contro l’ala filosovietica di Armando Cossutta. Lo scontro permette di contare quanti nel partito sono filosovietici e pronti a una resistenza ad oltranza all’idea un eurocomunismo sotto la leadership italiana, che colleghi sullo stesso fronte i comunisti francesi, spagnoli e portoghesi, anche se Spagna e Portogallo stanno vivendo ancora sotto dittature di destra agonizzanti. La nuova alleanza ha il progetto di staccare la spina con l’Unione Sovietica evitando però uno strappo troppo doloroso.
Lo strappo definitivo, infatti, non arriverà mai e, per gli anni a venire, Eugenio Scalfari dalla Repubblica (che ancora non è nata ma nascerà di lì a pochi mesi) inciterà Berlinguer a “varcare il guado” essendo il partito comunista sempre in mezzo al guado benché protetto (parole di Berlinguer) dall’ombrello atomico americano e la scelta di campo occidentale sia ormai matura. Ma è anche chiaro che Berlinguer non vuole rompere da destra e dunque dedica tutta la sua attenzione a una ideologia che vada oltre l’ormai esangue Rivoluzione d’Ottobre, fondata sulla questione morale. La questione morale sollevata da Berlinguer consiste in una affermazione di supremazia etica: i comunisti, oltre che bravi sono per definizione anche onesti. L’onestà compare per la prima volta come una questione ideologica.
La dissociazione dal marxismo leninismo sovietico diventa una necessità che porta a radicalizzare le differenze tra i comunisti e gli altri.
Questa “linea” serve a Berlinguer per gettare un ponte e stringere il patto di alleanza, detto compromesso storico, con la Democrazia cristiana intesa come il partito dei cattolici. In questo Berlinguer seguiva fedelmente la strada battuta da Palmiro Togliatti quando volle approvare, con un colpaccio a sorpresa nell’articolo 7 della Costituzione, l’inclusione dei Patti Lateranensi sottoscritti da Benito Mussolini col Vaticano (e che sono alla base dell’attuale conflitto sul progetto di legge Zan) e che secondo Togliatti era la password necessaria per avvicinare le masse cattoliche rispettandone l’identità. L’eurocomunismo da una parte e il compromesso storico dall’altra furono i due strumenti attraverso i quali il segretario del partito comunista italiano cercava la via d’uscita dalla tutela sovietica, mantenendo salda una sinistra orgogliosa e anche sdegnosa, competitiva e di fatto definita come geneticamente superiore, dunque ostile a qualsiasi altra forza di sinistra perché non si sarebbe capito per quale motivo un militante di sinistra non dovesse essere comunista dal momento che soltanto quel partito garantiva il bene.
Lo scontro con il Partito socialista era dunque inevitabile, anche se il Psi dopo la parentesi manciniana era in mano al professor Francesco De Martino, uomo convintissimo della consanguineità con il Pci: una posizione che lo esporrà al colpo di maggioranza di qui a un anno con l’avvento di Bettino Craxi nella sede di via del Corso. Il 13 aprile del 1975 una violenta esplosione a Beirut scatenò la guerra civile in quel paese che finora fino a quel momento era considerato la Svizzera del Medio Oriente. Un evento importante sotto ogni punto di vista ma, se il lettore mi consente una digressione personale, molto importante per me che oggi scrivo queste note, perché coprii gran parte di quella guerra per la Repubblica e quella prima uscita in un Medio Oriente inferocito e polveroso, dove la vita non valeva assolutamente nulla e meno ancora le dichiarazioni, fu per me il primo incontro con la realtà inimmaginabile.
La guerra del Libano metteva in crisi un paese occupato dall’Olp di Yasser Arafat che vagava nel Medio Oriente senza trovare pace né patria, e di lì nacque anche una mia conoscenza diretta con Arafat che si concluderà molti anni dopo con l’ultima intervista che quest’uomo dette a un giornalista quando lo andai a trovare a Roma all’hotel Excelsior e lui malato e spaventato mi dedicò tutta la notte per raccontarmi la sua vita e poi sparire inghiottito dal suo compound dove sarebbe stato avvelenato e ucciso. Tutto ciò era ancora da venire e certo allora non si potevano conoscere le conseguenze dei fatti che avvenivano giorno per giorno tra cui la prima attività di uno sconosciuto ragazzo intraprendente di nome Bill Gates che aveva impiantato una azienda informatica in un garage da cui sarebbe uscita Microsoft e il personal computer.
In Spagna muore il dittatore Francisco Franco che aveva tenuto il potere per trentasei anni dopo essersi ribellato alla Repubblica spagnola e aver vinto quella guerra con l’aiuto di Hitler e Mussolini, mentre la parte opposta aveva ricevuto armi e istruttori dell’Unione sovietica. La guerra di Spagna aveva lasciato una grande piaga aperta che seguitava a produrre dolore e nostalgie ancora durante gli anni Sessanta e Settanta quando nelle nostre case venivano a cena con le loro chitarre gli ultimi esuli di quella guerra e delle meravigliose canzoni dei fronti di Guadalajara, dell’Ebro, del bombardamento di Madrid, tanto che oggi appare curioso che quelle canzoni di sinistra dedicavano versi feroci a “los moros” ovvero i soldati di colore delle truppe coloniali che Francisco Franco aveva usato per il suo colpo di Stato.
Francisco Franco morì quell’anno, dopo una infinita malattia e le ostinate cure che lo avevano imbalsamato mentre era ancora vivo. Finalmente era sparito dalla scena e la Spagna si trovava di colpo senza dittatore e senza democrazia. La situazione fu presa in mano dall’unico organismo sotterraneo sopravvissuto che era l’Opus Dei che provvide a reinsediare sul trono di Madrid il principe Juan Carlos di Borbone, un giovanotto che aveva vissuto il suo esilio a Roma e che Sandro Pertini si vantava di avere avuto più volte ospite in casa sua. La Spagna voltava pagina senza avere risolto i suoi problemi ideologici e alla fine della dittatura il partito comunista di Santiago José Carillo Solares si vide che era ben poca cosa rispetto al ruggente Partito comunista spagnolo guidato dal comandante Carlos, nome di battaglia dell’italiano Vittorio Vidali che io conobbi a Trieste ben vivo e fiero delle sue antiche battaglie. L’ultimo capo comunista rivoluzionario spagnolo era dunque stato un italiano figlio di un operaio di Monfalcone e animatore dell’organizzazione socialista triestina “Arditi Rossi” per poi diventare un valoroso e crudele agente di Stalin nella guerra di Spagna come Comandante Carlos, fondatore del leggendario “Quinto Regimiento”.
La sua azione in quella guerra aveva prodotto un conflitto sempre più violento fra comunisti e sinistra non comunista, le cui conseguenze si riverberavano ancora nella politica italiana del dopoguerra, provocando la crescita di quell’anticomunismo di sinistra che fu una componente genetica dei socialisti italiani, fra loro spaccati tra frontisti e autonomisti, come gli anni di Craxi mostreranno subito dopo quel 1975.
(1/CONTINUA)
LA CRONOLOGIA DEGLI EVENTI DEL 1975
25 gennaio: il presidente di Confindustria Giovanni Agnelli e i sindacati confederati firmano un accordo sul punto unico di contingenza
27 gennaio: inizia il terzo processo per la strage di Piazza Fontana
11 febbraio: Margaret Thatcher è la nuova leader del partito conservatore inglese
4 marzo: Charlie Chaplin viene nominato baronetto dalla regina Elisabetta
8 marzo: in Italia viene approvata la legge 39/75 che abbassa la maggiore età da ventuno a diciotto anni
18 marzo: si apre il XIV congresso del Pci: è vincente la linea del compromesso storico di Enrico Berlinguer
27 marzo: esce il primo film di Fantozzi
4 aprile: Bill Gates crea la “Microsoft Corporation”
9 aprile: Federico Fellini vince il suo quarto Oscar con il film Amarcord
13 aprile: un attentato a Beirut è la causa scatenante dello scoppio della guerra civile
6 maggio: viene rapito da una formazione dei Nap il magistrato Giuseppe Di Gennaro
10 maggio: la Ferrari dopo vent’anni torna a vincere il Gran Premio di Montecarlo con Niki Lauda
19 maggio: con la legge 151/75 viene riformato il diritto di famiglia: è sancita la parità giuridica fra coniugi, attribuita ad entrambi la patria potestà, eliminato l’istituto della dote e il riconoscimento giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio
31 maggio: è approvata la legge 191 sul servizio militare di leva, che riduce la durata del servizio da 24 a 12 mesi
13 giugno: viene assassinato a Reggio Emilia Alceste Campanile, attivista di Lotta Continua
19 luglio: viene inaugurato il parco divertimenti Gardaland
24 agosto: Giacomo Agostini vince a Brno il suo quindicesimo titolo mondiale
15 settembre: viene pubblicato Wish you were here, nono album dei Pink Floyd
2 novembre: viene barbaramente ucciso Pier Paolo Pasolini
6 novembre: circa 350.000 marocchini sotto la guida di re Hassan II invadono il Sahara Occidentale. È l’evento della “Marcia Verde”
20 novembre: a 83 anni, muore Francisco Franco, dittatore spagnolo al potere da 36 anni
10 dicembre: in Inghilterra viene abolita la distinzione giuridica tra uomo e donna
30 dicembre: in Italia viene approvata la legge 685 sugli stupefacenti: viene stabilita una distinzione tra spacciatore e consumatore; viene introdotta la distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti e la nozione di modica quantità per uso personale permette la non punibilità di quest’ultimo
© Riproduzione riservata