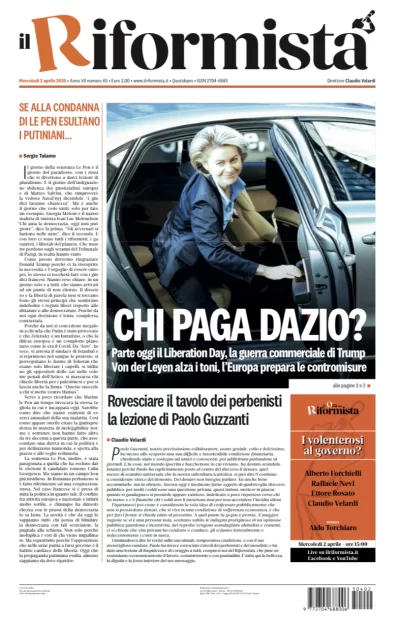Pubblico è (di nuovo) bello?
Da Ilva ad Alitalia lo stato torna “imprenditore”, ma attenzione alla giustizia

Pubblico è bello? Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di fine anno ha accennato al “modello Ilva”. Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, illustrando il nuovo piano quinquennale ha enunciato investimenti per trenta miliardi di euro. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha promesso per i prossimi cinque anni un corposo piano d’investimenti. Il presidente Sergio Mattarella, elaborando il discorso di Capodanno a reti unificate, ha sottolineato l’idea di “coesione sociale”. È noto a tutti come recentemente il governo Conte nel decreto Milleproroghe abbia introdotto un articolo che prevede, in caso di revoca della concessione autostradale ad Atlantia, la possibilità da parte di Anas di assumere la gestione ad interim. Il “modello Ilva” considera un parziale intervento dello Stato (probabilmente attraverso la controllata Invitalia) finalizzato alla conversione green di parte della produzione. Investimento pubblico orientato a trasformare gli stabilimenti siderurgici in un boccone ghiotto o, per lo meno, rendere il gruppo ex Ilva un investimento meno incerto. La formula non è valida solo per ArcelorMittal, ma, in caso di non chiusura dell’accordo, si offre un pacchetto con annesso incentivo già confezionato pronto per essere servito ad altri interessati alla grande acciaieria.
L’ambizioso piano d’investimenti della neo presidente Ursula von der Leyen è stato definito come Green New Deal. Ed ecco che sembrano rispuntare alcune vecchie politiche economiche del passato: il New Deal, questa volta con una pennellata di verde. Nelle linee guida del neo presidente della Commissione europea al primo posto troviamo la European Green Deal (senza il New) che, probabilmente non a caso, verrà elaborato nei “miei primi cento giorni in ufficio”. Cento giorni per mettere a punto una nuova politica. Anche il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt che a seguito della tragica depressione del 1929 promise un “nuovo patto con il popolo americano” elaborò e attuò il New Deal (letteralmente nuovo corso) dove la spesa pubblica interveniva per sostenere l’economia. Le prime misure furono adottate nei tempi previsti: la “Sessione dei cento giorni”. Se esiste un “modello Ilva” potremmo in futuro aspettarci un “modello Alitalia”? La privatizzazione dell’ex linea aerea di bandiera non decolla, anzi precipita. Bisogna rammentare (rinfacciare?) come l’annosa questione Alitalia tra esuberi, prestiti ponte, inefficienze e fallimenti sia diventata una tragica commedia. Il professore Andrea Giuricin, docente dell’Università Bicocca di Milano, ha calcolato come dal 2008 a oggi sia costata complessivamente allo Stato dieci miliardi di euro. Una parziale inefficiente privatizzazione costata più di una privatizzazione. Dal cielo al mare. La compagnia Tirrenia (gruppo Onorato Armatori) naviga in cattive acque. Ha recentemente scongiurato il fallimento, ma il futuro appare burrascoso. Il Tribunale di Milano che ha rigettato l’istanza di fallimento depositato da alcuni hedge funds detentori di bond, ha sottolineato come per pagare i debiti contratti con alcune banche la compagnia di navigazione potrebbe essere costretta ad alienare alcune navi. L’associazione di categoria Confitarma (Confederazione Italiana Armatori), di cui il gruppo Moby Spa (gruppo Onorato) non fa più parte, ha avviato un tavolo di confronto con il governo per discutere di un eventuale intervento pubblico nel settore. Insomma, sembra proprio che lo Stato torni ad essere un attore protagonista dell’economia italiana.
Il passo è importante e impegnativo: da arbitro a giocatore. Maynard Keynes amava dire che in tempi di crisi lo Stato avrebbe dovuto assumere disoccupati per scavare buche e altri per riempirle. Antitetica la posizione degli economisti neo liberisti della Università di Chicago, per l’esponente Milton Friedman nell’economia non ci doveva essere alcuna interferenza dello Stato. Ed ecco che incomincia a prevalere la politica del laissez-fair dove alla libertà di mercato corrisponde la libertà individuale. Le parole chiave sono note: deregulation, privatizzazione e contenimento delle spese sociali. Roland Reagan e Margaret Thatcher tra gli attuatori della politica della Scuola di Chicago. Una delle conseguenze della politica del mercato come osannato principale protagonista e arbitro dell’economia è stata la sbornia della facile globalizzazione. Anche in Italia abbiamo vissuto negli anni Ottanta dello scorso secolo (ma non è poi così lontano) il periodo dove le imprese pubbliche andavano privatizzate a tutti i costi. Sulle modalità e sulla convenienza di alcune vendite si potrebbe discutere molto. Vendere o valorizzare? In pochi ricordano che il giovane Enrico Mattei nell’immediato dopoguerra venne chiamato per liquidare l’Agip (Azienda Generale Italiana Petroli), caparbiamente si oppose alla privatizzazione e successivamente fondò l’Eni che in poco tempo divenne un colosso energetico e la spina dorsale della ricostruzione post bellica del Paese. Ora, come abbiamo visto, terminata, o per lo meno ridimensionata, l’ondata neo liberista, come detto in Italia si ricomincia a parlare seriamente di partecipazione diretta dello stato nell’economia. E per partecipazione diretta s’intende che lo Stato diventa imprenditore o socio di peso d’imprese che navigano nel mercato con le regole di mercato. Saremo in grado di affrontare questa nuova importante sfida? Assisteremo alla nascita del nuovo ministero della Partecipazioni Statali?
Torneremo a quelli che con dispregio venivano chiamati i “boiardi di stato”? La siderurgia e le autostrade nate e sviluppate con lo Stato torneranno pubbliche e i Benetton torneranno a produrre maglioni colorati? Lo slogan “pubblico è bello” in contrapposizione a “piccolo è bello” soddisfa esigenze economiche o anche quelle politiche particolarmente legate a quelli che in tanti classifichino come “populismi”? Abbiamo gli strumenti per gestire una fetta d’economia a controllo pubblico. O meglio, riguardo la gestione delle imprese non ci dovrebbero essere problemi: l’Italia è un buona fucina di ottimi manager. Ma il controllo politico e la mano, a volte invadente, della giustizia? Insomma, chi controlla i controllori?
© Riproduzione riservata