Viviamo in un tempo che parla troppo e ascolta poco
Dantedì, ridare posto alla parola come gesto responsabile, come atto di conoscenza, come tensione verso il bene
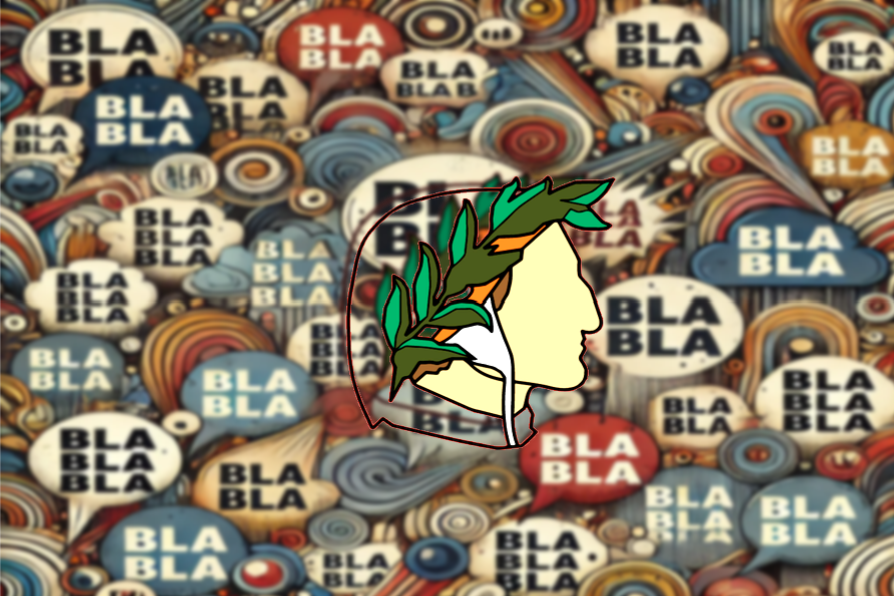
Viviamo in un tempo che parla troppo e ascolta poco. Basta accendere la televisione e guardare un talk show qualsiasi per rendersene conto. È un tempo in cui le parole si consumano in fretta, si moltiplicano a dismisura ma si dimenticano prima ancora di depositarsi. La scrittura è spesso ridotta a banale didascalia, a riflesso automatico, e la letteratura scivola verso il rango di lusso inattuale. Quanto alla poesia, meglio non parlarne: relegata in un angolo, è ormai a rischio estinzione. Anche quella che una volta viveva nella musica si è trasformata in un profluvio senza metrica, che svuota la canzone e la rende simile alla lettura di un rogito notarile.
E allora viene da chiedersi: che posto ha, oggi, la parola scritta? E chi ha ancora il coraggio di usarla per cercare il vero?
Ogni 25 marzo, due nomi giganteschi si impongono nel calendario culturale. Il primo è quello di Dante Alighieri, celebrato nel Dantedì, giornata nazionale dedicata al poeta che ha dato forma non solo alla nostra lingua, ma anche al nostro modo di guardare il mondo. Il secondo è quello di J.R.R. Tolkien, ricordato nel Tolkien Reading Day per aver saputo creare, con la forza del mito e della parola, un intero universo narrativo. Una coincidenza? Sì, ma tutt’altro che banale. Perché entrambi — pur lontani nel tempo e nello stile — hanno usato la parola come strumento per scavare nella profondità dell’uomo, per disegnare una mappa della coscienza, per tendere un filo tra terra e cielo. La stessa data del 25 marzo non è stata scelta a caso, ma richiama un giorno liturgico di enorme rilevanza: l’Annunciazione, ovvero il concepimento del Cristo — nove mesi prima del dies natalis — e, nella visione dantesca, il giorno del “transito” pasquale attraverso i regni ultraterreni. Così come, nella finzione narrativa tolkieniana, Frodo distrugge l’Unico Anello sul Monte Fato. In entrambi i casi, un gesto radicale: attraversare il buio per salvare qualcosa. Non una fuga nel fantastico, ma un ritorno all’essenziale.
Eppure è a Dante che dovremmo tornare oggi, con uno sguardo più netto: non per dovere scolastico o per fedeltà culturale, ma perché la sua voce parla ancora all’oggi, forse più di quanto immaginiamo. Dante scrive per giudicare, ma anche per redimere; per mettere a nudo la colpa, ma anche per offrire una via d’uscita. La Commedia è un’opera-mondo, certo, ma soprattutto è un viaggio nella verità dell’uomo. Una verità scomoda, dura, luminosa. Chi ha orecchie per sentire — studenti, lettori, cittadini — sa che in quei versi si nasconde qualcosa che oggi manca quasi del tutto: la parola come gesto responsabile, come atto di conoscenza, come tensione verso il bene.
È qui che si gioca la duplice attualità dell’opera dantesca: da una parte, ci porta “al di là di noi”, in un altrove che interroga le nostre convinzioni, i nostri limiti, le nostre illusioni; dall’altra, ci riporta “all’al di qua per noi”, nella storia concreta, nelle città corrotte e nella fatica di vivere tra potere, viltà e speranza.
Se si segue la traiettoria dell’Alighieri si esce dalla Commedia più leggeri, ma si esce forse più veri.
E allora, cosa resta oggi della sua lezione? Non formule magiche, né tantomeno scorciatoie, bensì — a mio avviso — tre parole che possiamo ancora custodire e su cui riflettere: Limite, perché riconoscere i confini non è una debolezza, ma un gesto di forza; Luce, perché anche nell’ombra più fitta può accendersi una direzione; e Lotta, perché nulla si ottiene senza passaggio, senza rischio, senza impegno. Dante lo sapeva, e lo scriveva con versi che ancora bruciano nel nostro animo non per abbellire ma per scuotere la coscienza del “Bel Paese”.
E noi? Siamo ancora disposti a lasciarci ferire — come una lama a doppio taglio, direbbe San Paolo — da una parola che non consola, ma salva? Ve lo dico con due terzine:
Tace la pace dove il cor s’infrange,
e i giovani vagan senza dimora,
tra voci vane e luce che non plange.
Futuro è verbo che più non s’onora,
ché l’uom lo scorda dentro il suo frastuono,
e il suon del verso langue e non lavora.
© Riproduzione riservata





