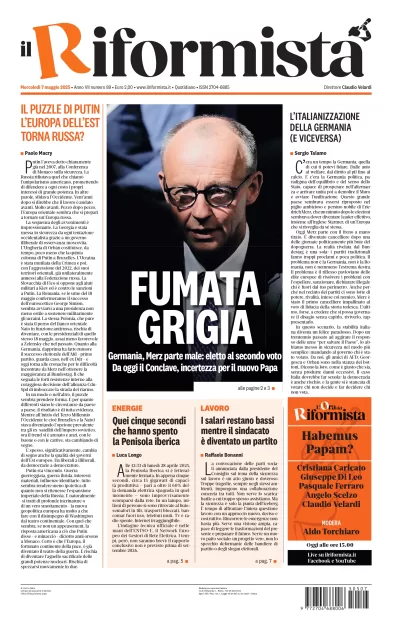La decisione "cerchiobottista"
Diffamazione a mezzo stampa e carcere per i giornalisti, la Consulta molla la grana ai magistrati

La scorsa settimana la Corte costituzionale ha emesso un comunicato con cui anticipa importanti decisioni sui rapporti tra il diritto costituzionale di «manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di divulgazione» e il reato di diffamazione a mezzo stampa, posto a tutela della reputazione della persona destinataria di espressioni offensive della sua reputazione.
Prima dell’intervento della Corte la disciplina penale era particolarmente severa: la diffamazione a mezzo stampa commessa mediante l’attribuzione di un fatto determinato era punita dall’art. 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 con la reclusione da uno a sei anni e la multa non inferiore a lire 500.000. Per la diffamazione con il mezzo della stampa che potremmo chiamare “ordinaria” (cioè senza attribuire un fatto determinato) l’art. 595 comma 3 del codice penale stabilisce la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a € 516. La decisione della Corte costituzionale viene da lontano, posto che un anno orsono con l’ordinanza n. 132/2000 la Corte aveva sollecitato il Parlamento a porre mano ad una riforma complessiva della materia; compito che evidentemente esula dalle competenze della Corte, limitate a valutare l’eventuale illegittimità costituzionale di una o più norme di legge.
In particolare, la Corte aveva chiarito che sarebbe stato necessario introdurre un sistema che contempli non solo il ricorso a sanzioni penali, ma anche rimedi civilistici, misure risarcitorie e riparatorie in favore della vittima della diffamazione e se del caso sanzioni di carattere disciplinare. Da allora è trascorso un anno e la Corte, preso atto del mancato intervento del Parlamento, ha anticipato le sue decisioni ricorrendo allo strumento non abituale di un comunicato stampa, in attesa di depositare la sentenza con le relative motivazioni. Siamo così venuti a conoscenza che la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13 della legge del 1948 che puniva la diffamazione a mezzo stampa commessa mediante l’attribuzione di un fatto determinato), mentre è stato “salvato” l’art. 595 comma 3 del codice penale, che – come abbiamo visto sopra – prevede per la diffamazione “semplice” la reclusione o, in alternativa, la pena pecuniaria.
La Corte conclude il comunicato ribadendo che resta «attuale la necessità di un complessivo intervento del legislatore, in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento – che la Corte non ha gli strumenti per compiere – tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale». Ecco dunque un ulteriore forte monito rivolto al legislatore, che vi è da augurarsi venga raccolto dal Parlamento prima della fine della legislatura. È presumibile che la Corte abbia deciso di anticipare la dichiarazione di illegittimità della diffamazione a mezzo stampa punita con la reclusione da uno a sei anni per evitare che vengano nel frattempo pronunciate altre condanne ad una così severa pena detentiva per un reato che si sostanzia in forme sia pure improprie e illecite di manifestazione del pensiero.
La Corte sembra cioè suggerire che per la diffamazione a mezzo stampa non dovrebbe mai essere prevista la pena detentiva, ma semmai congrue sanzioni pecuniarie, magari accompagnate da misure riparatorie e risarcitorie ed eventualmente integrate con la sospensione o l’interdizione dall’esercizio della professione. Se queste saranno le argomentazioni della Corte, stupisce che non sia stato dichiarato illegittimo anche l’art. 595 comma 3 del codice penale nella parte in cui prevede in alternativa alla pena pecuniaria la reclusione da sei mesi a tre anni. Il giudice rimane così investito – come chiarito nello stesso comunicato della Corte – della facoltà discrezionale «di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità».
Si ha l’impressione che la Corte abbia voluto dare “un colpo al cerchio e un colpo alla botte”, da un lato affermando che, grazie al principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, sia pure esercitata impropriamente, la diffamazione non può essere sanzionata con la pena detentiva; dall’altro scaricando sulla magistratura la responsabilità di applicare la reclusione nei “casi di eccezionale gravità”. In una materia sorretta dal principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero, una scelta così delicata non dovrebbe essere demandata al potere discrezionale della magistratura, ma affrontata in prima persona dalla stessa Corte mediante una dichiarazione di illegittimità costituzionale della pena detentiva prevista dall’art. 595 del codice penale.
In alternativa, la Corte potrebbe con particolare forza sollecitare il potere legislativo ad intervenire, riuscendo ad invertire la tradizionale inerzia del Parlamento a fronte dei numerosi moniti della Corte rimasti inascoltati. Potrebbe essere questo un bell’esempio di leale e doverosa collaborazione tra due istituzioni centrali del sistema di democrazia rappresentativa, nell’ambito delle rispettive competenze del Parlamento di produrre leggi conformi alla Costituzione e della Corte di svolgere il ruolo di giudice della legittimità costituzionale delle leggi.
© Riproduzione riservata