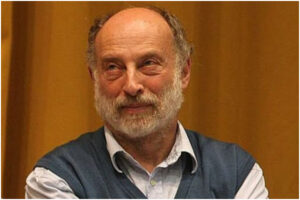Il nuovo libro dell'autore
“Dio”, il libro di Stefano Levi Della Torre: un’analisi sull’umano che non teme le ambiguità

«Dio è una domanda travestita da risposta», scrive Stefano Levi Della Torre nel suo ultimo libro – Dio, Bollati Boringhieri 2020. Chi non ha mai invocato Dio nei momenti in cui ha temuto per la propria vita – “Dio aiutami!” -, o quando si è trovato di fronte a una felicità inaspettata – “Dio ti ringrazio!”?
In un saggio precedente, uscito da Einaudi nel 2012, che ho avuto il piacere di presentare al Festival della Letterature di Mantova – Laicità, grazie a Dio -, era già chiara la motivazione profonda che può portare, anziché a respingere in modo pregiudiziale la religione, come fa gran parte della laicità, a vederne la portata simbolica e antropologica, la ricchezza dei bisogni umani che si porta dentro. Ma spostare l’attenzione sulla “fede”, su quel “desiderio di credere” che ostacola da sempre la scienza dal tentativo di affrancarsi dalla soggettività, è un passaggio ulteriore verso una conoscenza dell’umano che non teme di scoprire limiti, contraddizioni, ambiguità. È questo il pregio e la radicalità della riflessione con cui Stefano Levi si addentra in un terreno che, pur essendo collettivo e sociale, e occupando gran parte della storia, è rimasto nell’ombra di un “privato” coperto dal pudore, dalla vergogna o dall’indicibilità. Parlare di Dio vuol dire affrontare «vuoti di sapere» – «l’esistenza dell’universo è una constatazione», ma resta la domanda del «perché dell’universo», del «come mai il mondo è proprio quello che è invece di essere in altro modo» -, ma anche pulsioni profonde, legate alle esperienze dei primi anni di vita, che parlano la lingua del «desiderio» e della «paura».
«Il credere è una necessità primaria e una premessa e un orizzonte. Se nella prima infanzia non credessimo nelle parole che ci insegnano, e se non credessimo che sono vere e che corrispondono a cose e fatti, non impareremmo neppure a parlare. Il credere è il primo passo sulla via del sapere (…) L’affinità con i moventi infantili del credere si rispecchia nell’idea e nel sentimento di essere figli – “figli di Dio”, inteso come padre (…) In questa visione della fede , l’amore religioso è amore minorile, amore filiale: amore per chi protegge e salva, per chi dunque è buono, è il bene».
Nei vent’anni che ho trascorso nella mia famiglia contadina, unica ad avere il privilegio dello studio, benché femmina, costretta per mancanza di spazi a dormire in camera con i miei genitori, spettatrice muta delle loro notti, in cui era difficile per una bambina distinguere tra sessualità e violenza, che cosa poteva placare la mia solitudine, le mie angosce, quel senso inspiegabile di colpevolezza a cui non sai dare un nome, se non immaginare un interlocutore lontano da quella miseria, lo sguardo di un Dio capace di consolazione e di assoluzione, un genitore o una potenza misericordiosa da cui ricevere amore e forza per affrontare la sofferenza?
Il Dio che “conosciamo” è idea e immaginazione – scrive Stefano Levi -, «una finzione che ha una funzione, un placebo efficace, un’idea che ha influito concretamente nella storia (…) è lo sguardo che ci costituisce, un testimone della nostra esistenza e di ogni esistenza». A quel “Dio della mia infanzia”, visto che tale è rimasto per me, non ho mai smesso, ogni qualvolta la mia vita si è inceppata o, al contrario, è stata colta da momenti sorprendenti di felicità, di rivolgermi con la “fede” di una credente senza religione, forse solo col bisogno, che è di tutti gli umani di «aggirare l’inesistenza e la morte», o, come all’inizio della vita e nell’innamoramento, di trovare nello sguardo dell’amato o dell’amata la certezza «di essere voluti nel mondo».
Sotto questo aspetto, il credere religioso, la fede, sembrano dunque legati alla nostalgia infantile di una autorità che sia garanzia di vita e risposta ai nostri interrogativi e smarrimenti. Ma l’analisi di Stefano Levi va oltre e si chiede se l’idea di attribuire l’origine dell’universo a un progetto divino non si collochi su quel crinale che sta tra natura e storia, là dove compaiono «potenze indistinte», «soverchianti e inspiegate», il territorio del sacro che la religione tenta di addomesticare e che le scienze, a loro volta, finiscono per inglobare. «… è il tempo della sacralizzazione della scienza quasi a sostituire la religione, il tempo della presunzione scientista dell’illimitata conoscibilità del mondo e della sua riducibilità a strumento, il tempo dei fondamentalismi ideologici e dei messianismi politici, di nuovi culti collettivi della nazione e della razza, delle nuove idee di salvezza e provvidenza storica».
Nel Disagio della civiltà, all’inizio del secolo scorso, già Freud metteva in luce i rischi riguardo ai mostri che poteva generare il delirio di onnipotenza della ragione: «…queste cose che l’uomo, mediante la scienza e la tecnica, ha prodotto (…) Oggi è diventato lui stesso quasi un dio, una specie di dio-protesi, veramente magnifico quando è equipaggiato di tutti i suoi organi accessori: ma essi non formano un tutt’uno con lui e ogni tanto gli danno del filo da torcere». Per quanto la presunzione dell’uomo – ma dovremmo dire della comunità storica maschile che ha riservato a sé il governo del mondo, quel «maschio adulto, possidente» a cui si rivolgono i Dieci Comandamenti, sia stata più volte piegata dall’evoluzione del suo stesso sapere, abbia conosciuto lo scacco portato dalla rivoluzione copernicana, dal darwinismo e dalla psicanalisi, alla sua centralità nell’universo e al suo dominio sulla natura, «il nostro sistema simbolico – scrive Stefano Levi – resta tolemaico».
Ciò nonostante non sembra venuta meno quella domanda di senso – del perché il mondo sia fatto così come ci appare -, che va inspiegabilmente, paradossalmente, a collocarsi in quel vuoto di senso, in quella oscurità che è il Dio della nostra immaginazione. L’insicurezza, che oggi mina un sistema costretto a far fronte ai cambiamenti climatici, alle ondate migratorie e alle pandemie, potrebbe rafforzare «l’inquietudine del sacro», e quindi «forme di religione e di fede, nuove o tradizionali, a suo rimedio». Sapremo trovare altre strade che non siano la speranza e l’attesa di essere salvati da una creazione dei nostri desideri e delle nostre paure?
© Riproduzione riservata