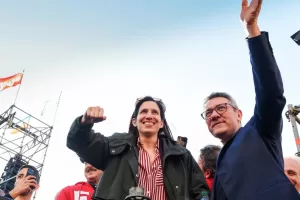Coprifuoco e futuro
“Finita la paura il mantra grillino svanirà, ripartiremo dalle relazioni”, parla Giuseppe De Rita

Giuseppe De Rita, 88 anni, sessanta dei quali passati a raccontare l’Italia con i rapporti Censis. Il decano dei sociologi punta il dito sulle troppe incognite di un periodo nebuloso, dominato dalla lunga e generale incertezza. Il peggiore dei mali. «Se non avessimo avuto questa seconda ondata, mi sarei aspettato una società più vitale, più forte. Con uno spazio più alto per l’innovazione. Una sorta di piccola rinascita. La piccola imprenditoria, il mondo digitale, stavano mostrando una capacità di reazione. Con questa seconda ondata cambia un po’ tutto».
E non in meglio.
Non in meglio. La prima ondata ha avuto il merito di aver visto una reazione generale e univoca del Paese.
Ci siamo detti “ne usciremo migliori”…
Ma bastava anche solo: “ne usciremo”. Questa volta invece no, perché c’è una doppia incertezza. Le persone non capiscono più che cosa sta avvenendo. Le conversazioni sono popolate da dubbi, da perplessità. E chi più si informa, meno ne capisce. Nessuno ha capito se il tampone va fatto, quale tampone vale la pena fare, se esistono i parzialmente positivi. Se il tampone di oggi vale anche domani. Gli esempi possono essere migliaia, e tutto questo crea un macroclima di incertezza spaventoso. Ci guardiamo negli occhi smarriti. È la grande incertezza collettiva.
Doppia incertezza, diceva. Qual è la seconda?
È quella di chi ha un ruolo-guida. Tutti coloro che devono creare certezza. Se saltano i grandi maitre-à-penser, impigliati nelle incertezze, va a rotoli il sistema. Vale per gli opinion leader, vale per gli scienziati, per i decisori pubblici. La politica non sa più cosa dire, e vale tanto per l’opposizione quanto per la maggioranza. Li vedi che si chiedono ogni giorno cosa possono inventare, ma non hanno un’idea precisa su nulla. Chi sta in cabina di pilotaggio brancola nel buio.
Finendo per alimentare nuove paure.
Danno un messaggio di paura. Di terrore. Diffondono il panico. La comunicazione pubblica è fatta ormai solo di divieti, di proibizioni e inibizioni. La cosa impressionante è che chi avrebbe dovuto indirizzare la cosa pubblica ha perso quattro mesi per eliminare il compagno di banco di mio nipote per introdurre il banco con le rotelle, dicendoci che avrebbe così risolto i problemi. E oggi scoprire che quello non era così necessario, toglie ulteriore sicurezza.
Neanche gli intellettuali danno conforto.
Non esistono più grandi pensatori. Non c’è più un Umberto Eco.
C’è invece l’effetto eco. Quello del vuoto.
E ricordo che il bisogno di sicurezza è un bisogno primario. È fondamentale per la tenuta individuale e quindi collettiva. Non a caso aumenta il consumo di psicofarmaci.
Ricorda un momento della storia dominato da tanta incertezza?
Non esiste alcun confronto possibile. Mi vengono in mente i 55 giorni del sequestro Moro, un periodo di paura generale in cui la gente stava in casa a seguire le notizie alla televisione. Ma era una paura che si sentiva soprattutto a Roma, era localizzata. E delimitata nel tempo. Oggi è tutto indefinito, anche l’arco temporale.
E l’uomo post-covid rimarrà un animale sociale?
E se non fosse un animale sociale cosa sarebbe? Un animale e basta? Avremo imparato le nuove regole sanitarie, ma dovremo sapere ricostruire una architettura sociale, fatta di relazioni più forti.
Nascerà una domanda di nuova sicurezza, cercando magari l’uomo forte?
Se me lo avessero chiesto due anni fa, avrei detto di sì. Nel 2018 il Censis ha pubblicato il Rapporto in cui tracciavamo il desiderio da parte degli italiani dell’uomo forte. Oggi non me la sentirei di sottoscriverlo. Cambiano le premesse, siamo in un altro scenario. L’uomo forte rischia di dire solo cose banali, ha poteri comunque limitati dall’ampiezza del fenomeno sanitario globale.
L’uomo forte oggi è debole?
Oggi sarebbe uno che rischia di fare confusione, anziché risolvere i problemi. Abbiamo capito la debolezza dell’uomo forte, sì.
Quale può essere allora lo sbocco? La perdita di fiducia verso le istituzioni?
Bisognerebbe idealmente ricongiungersi nella fiducia verso le istituzioni. A cominciare dal basso, dal tessuto di convivenza e di relazioni. Noi abbiamo distrutto la relazione, che è quanto ci porta maggiore sicurezza.
La crisi del confronto alto rafforza quello orizzontale? Ripartiremo dalla prossimità?
Una prossimità di relazioni, però. Non inerte. Una prossimità che riparta dal rapporto di vicinato, nei condomini. Dalle associazioni, dai quartieri. Dagli amministratori locali. Dobbiamo recuperare il senso della relazione basilare: una volta conquistato l’atrio del portone, che dobbiamo saper riaprire, ecco che si dischiude la relazione con la politica, a partire dall’ente locale. Riappropriamoci del cortile, poi della strada davanti casa. E sapremo tornare nel mondo.
Anche il Parlamento dovrebbe essere luogo di relazione, di dialogo.
Tutte le istituzioni lo sono o dovrebbero esserlo. Ma il Parlamento è dove si è affermato negli ultimi dieci anni il Vaffa di Grillo. La negazione di ogni relazione. La rottura con l’altro come affermazione del sé, solitario. La paura della società ha creato il substrato sul quale è riuscito a farsi strada il Vaffa.
E il Vaffa ha vinto.
Ha vinto, ma oggi abbiamo capito i suoi limiti. Ha creato una società dissociata, un ossimoro in cui i problemi piccoli diventano grandi e i problemi grandi, irrisolvibili.
Il termine “distanziamento sociale” le piace?
Assolutamente no, è idiota. Il distanziamento sul piano sociale significa altro. Quello tra il Re e i suoi sudditi. Si sarebbe dovuto dire distanziamento fisico, sanitario. Che oggi si usino trovate semantiche sbagliate è indicativo, è una spia di quanto ci siamo persi.
A ben guardare la crisi covid crea anche distanziamento sociale nel senso proprio. Garantiti e precari, redditi certi contro incerti…
Hirschman diceva che lo sviluppo è uno squilibrio continuato. Senza il quale non c’è dinamica. Il lavoro sta cambiando e le relazioni da ricostruire porteranno a un nuovo equilibrio tra gli attori.
Alla crisi seguirà, di squilibrio in squilibrio, un grande sviluppo. La Rete crea nuove dinamiche di dialettica collettiva?
Guardo alla Rete provando a vivere senza. Ma se mi chiede se l’innovazione tecnologica potrebbe supplire alla mancanza di relazioni con relazioni da remoto, io le rispondo di no. Perché la vita di relazione è qualcosa che non è solo trasmissione di pensiero cui si risponde con un altro pensiero. È un fatto chimico.
Ci vogliono le persone, di persona.
Tu non fai dialettica sociale senza litigare, senza fare conflitto, senza piacersi. Senza questi elementi c’è solo finta relazione, come quella dei social.
I social network creano un universo relazionale parallelo?
Sono un grande infingimento. Un luogo dove tutti fingono, dove si va per insultare mezzo mondo, e uno si sente il Re della terra pur continuando a non essere nessuno. È una discesa agli inferi della relazione.
Non crede neanche nella didattica a distanza, la dad.
Pensare che un ragazzino possa imparare qualcosa sentendo la televisione sarebbe già un fatto raro. Che si possa imparare stando per ore al computer sarebbe miracoloso. Si impara stando insieme agli altri, in quel contesto maieutico fatto dello stare immersi nelle esperienze e nel confronto, che include lo stabilire amicizie e le inevitabili tensioni. A distanza si possono seguire lezioni, certo, ma vuole mettere? Se non c’è umanità non c’è formazione.
Una cultura narcotizzante ci rende incerti. Quale implicazione può avere sulla domanda politica, ci sarà più polarizzazione?
Il problema non è di domanda. È un problema di offerta. È la politica che crea l’attenzione della gente nei problemi. La domanda è sempre banale. Si chiedono bonus per le baby sitter, bonus per le biciclette. Siamo alla lista della spesa. Le polarizzazioni ideologiche no, sono alle spalle. Se la politica risponde alla domanda banale con una risposta banale, non è più un rapporto tra domanda e offerta di politica, è il nulla. La rincorsa del consenso o la paura del dissenso, sempre in assenza della mediazione. Manca chi media. Al massimo si rimedia.
Lei parla di letargo della società. Quanto può durare?
Il letargo è la necessità di mettersi al riparo. Ma la società rimane viva. In giugno avevo previsto per l’autunno un grande ritorno dell’economia sommersa: pagheremo meno tasse, useremo solo il contante, faremo di tutto per sopravvivere in condizioni difficili. Perché lo avevo visto negli anni Settanta, quando gli italiani ricorsero all’economia sommersa. Ma la seconda ondata cambia le cose.
Sarà comunque autunno caldo. Prevede che la rabbia troverà nuovi rivoli?
In Italia ognuno pensa a se stesso. I rivoli ognuno li trova per sé, non credo in una esplosione della piazza.
Qualcuno la sta già animando.
Vorrei guardare bene come è fatta questa piazza. La mia sensazione è che sia pre-organizzata e che non andrà da nessuna parte.
E la società nel suo complesso, dove andrà, uscita dal tunnel?
Credo profondamente nella nostra società. Non posso che avere la gioia di dire che ce la caveremo, bisogna vedere se con un bagno di vitalità sommersa o scegliendo il letargo, rimanendo paralizzata, chiusa in casa in attesa del disgelo. Il dualismo italiano è sempre stato tra chi combatte e chi si siede. Nella crisi covid li vediamo entrambi: i combattenti e i seduti.
Chi vincerà?
L’italiano medio, che è quello che sa mettere in rapporto perfetto queste due spinte
© Riproduzione riservata