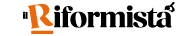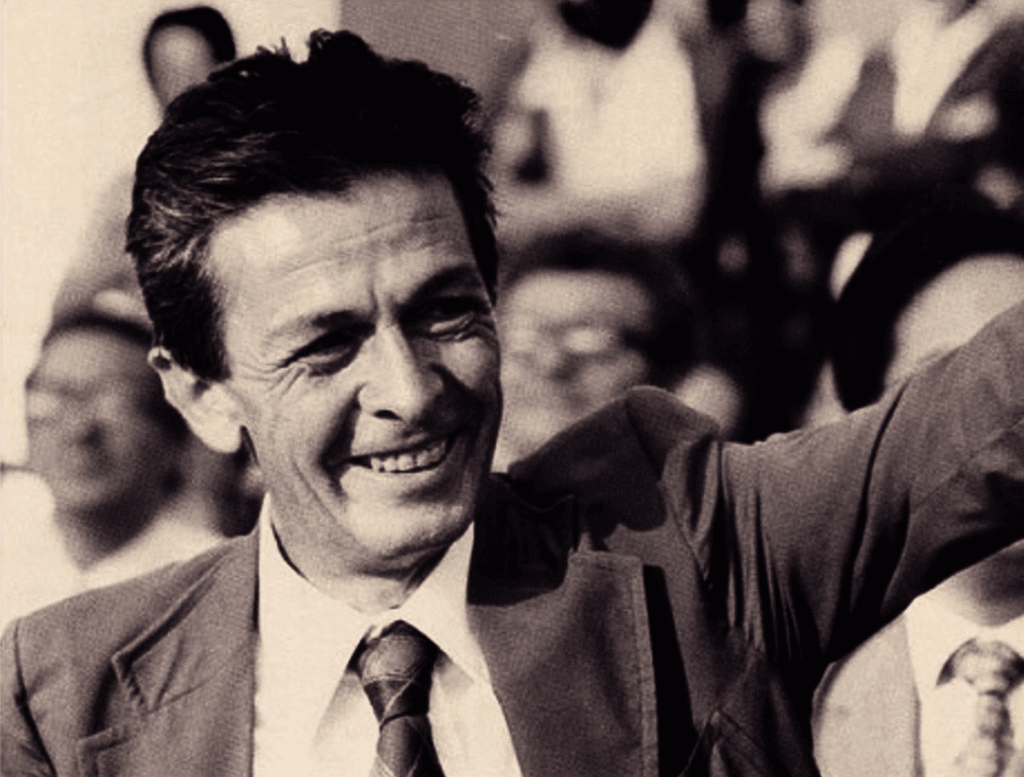Condivido con Fausto Bertinotti lo spirito di apertura e di dialogo per un confronto serrato non certo per una rissa. Nel suo campo i dogmatici e i faziosi sono ben altri. Poi come Fausto sa bene i peggiori fra tutti sono i dorotei (che è una sorta di categoria dello spirito equamente distribuita in tutti i partiti e schieramenti) che preferiscono un rigoroso silenzio perché considerano un lusso inutile la battaglia delle idee e molto più efficace il ricorso alle tecniche della gestione del potere svolte direttamente o per interposto giornale o per interposto pubblico ministero. Con tutta questa genia, non con i comunisti-operaisti come Bertinotti, ho tuttora uno spirito più che “guerresco” (la guerra, quella vera, l’hanno fatta loro alcuni anni fa), ma duramente conflittuale.
Non è stato certamente l’operaismo, ma l’ultima versione del berlinguerismo, quella dei cosiddetti “ragazzi di Berlinguer”, che ha lavorato in modo scientifico a “spegnere”, come diceva Machiavelli, il socialismo italiano e Bettino Craxi. I “ragazzi di Berlinguer” non hanno affrontato il 1989, realizzando un proprio autonomo revisionismo che desse il senso di un trapasso culturale e storico dal comunismo italiano alla socialdemocrazia e all’Internazionale Socialista. È quello che invece hanno provato a fare con tutti i loro limiti e contraddizioni i tanto vituperati miglioristi (Napolitano, Chiaromonte, Macaluso e Ranieri) che non a caso sono sempre stati minoritari nel partito e in più di un’occasione hanno rischiato la pelle. Poi, per applicare fino in fondo anche al Pci quella che Togliatti chiamava “l’analisi differenziata” (che in effetti applicò quasi a tutti, anche ai fascisti, molto meno all’Urss), fra i “ragazzi di Berlinguer” ci sono state due opzioni: quella del tutto utopica di Achille Occhetto, che puntava a superare il comunismo italiano da sinistra recuperando temi e suggestioni da Pietro Ingrao, e quella, tutta fondata sulla realpolitik di D’Alema, Violante, Veltroni (al di là delle sue variazioni sul tema).
Come è noto il tentativo di Occhetto fu reso impraticabile da due lati, dallo stesso Ingrao che non voleva superare il comunismo, ma “rifondarlo” e, appunto, dalla componente “realpolitik” dei “ragazzi” che nel frattempo si era collegata in modo profondo a una parte dell’establishment bancario, mediatico, giudiziario di questo paese (esemplare il loro rapporto organico con la Repubblica di Scalfari e di De Benedetti) giocando tutta la partita sull’ingresso nell’area di governo. Questa componente ereditò, gestendola ad un livello più basso ma anche molto concreto, la preclusione berlingueriana nei confronti di Craxi per cui cavalcò fino in fondo quel giustizialismo ispirato sia da un’area della magistratura, sia da Repubblica, sia da un settore del mondo imprenditoriale italiano che aveva dovuto rassegnarsi a lasciar svolgere un ruolo egemone alle forze politiche, in primo luogo alla Dc e poi anche al Psi, fino a quando c’era stata la divisione del mondo in due blocchi e in qualche modo il “pericolo comunista”.
Quel pezzo assai aggressivo del mondo imprenditoriale ritenne che era venuto il momento di togliere la “delega” alla politica e ai partiti. Di conseguenza esso utilizzò il suo volume di fuoco mediatico, si liberò della Dc e del Psi cavalcando Mani Pulite. Lo fece con la massima faccia tosta perché proprio le grandi imprese, in primo luogo la Fiat, erano state l’anima strutturale del sistema di Tangentopoli che via via aveva coinvolto tutto e tutti, sistema di potere del Pci compreso. In quel sistema non esistevano certo dei poveri concussi come spiegarono nelle loro lettere ai Pm di Milano la Fiat e la Cir, Romiti e De Benedetti che sarebbero stati quotidianamente minacciati e rapinati dai perfidi e arroganti concussori nelle persone di Craxi, di Forlani e dei loro accoliti.
Siccome, poi, nello svolgimento dell’operazione a un certo punto qualcuno spiegò a “lor signori” e al pool di Milano che non si poteva far tabula rasa di tutte le forze politiche, ecco che, anche per ragioni di rapporti di forza, fu realizzato un atipico compromesso storico fra queste componenti dell’operazione di Mani Pulite con i “ragazzi di Berlinguer” che, come spiegò lucidamente Massimo D’Alema, ragionava rigorosamente in termini di occupazione degli spazi politici e di potere: «Eravamo come una grande nazione indiana chiusa fra le montagne con una sola via d’uscita, un canyon, e lì c’era Craxi con la sua proposta di unità socialista, in sostanza un progetto annessionistico. Come uscire da quel tunnel? Questo era il nostro progetto strategico: come trasformare il Pci senza cadere sotto l’egemonia craxiana che avrebbe segnato la disfatta della sinistra. Craxi aveva un indubbio vantaggio su di noi: era il capo dei socialisti in un paese occidentale, quindi rappresentava la sinistra giusta per l’Italia, solo che poi aveva lo svantaggio di essere Craxi.
Mi spiego. I socialisti erano storicamente dalla parte giusta, ma si erano trasformati in un gruppo affaristico avvinghiato al potere democristiano. Questo era il nostro vero dramma. L’unità socialista era una grande idea, ma senza Craxi. Allora avevamo una sola scelta, diventare noi il partito socialista in Italia». Tutto ciò si fondava su una grande mistificazione: come tu ben sai, caro Fausto, il Pci era fra i partiti italiani quello che aveva più fonti di finanziamento irregolare, sia detto senza alcun moralismo: dal finanziamento proveniente dall’Unione Sovietica alla rendita petrolifera dell’Eni, alle cooperative rosse, a una miriade di aziende private.
Non a caso, diversamente dai miglioristi, quel settore del Pds, forse con l’eccezione di qualche riflessione culturale sviluppata da Piero Fassino, fu assai parco sul terreno della revisione ideologica, ma invece assai aperto e attivo su quello delle privatizzazioni. In qualche caso, taluno dei “ragazzi di Berlinguer” si impegnò a tal punto su quel terreno da guidare anche una cordata di “capitani coraggiosi” venendo però contrastato dall’interno stesso del gruppo dirigente del Pds da parte di coloro che oramai avevano rapporti organici con l’establishment finanziario ed editoriale di questo paese. Queste sono le ragioni, caro Fausto, per le quali mantengo una contestazione di fondo che non è certo rivolta al “comunismo” come categoria dello spirito avendo anche la consapevolezza che la dialettica fra quella ipotesi culturale e quella socialista nel senso classico appartiene per larga parte a un passato prestigioso, ma certamente superato.
Invece anche per gli errori politici di Craxi e per il cupio dissolvi che caratterizzò ciò che rimase in campo del gruppo dirigente socialista, certamente nel ’92-’93 i “ragazzi di Berlinguer” vinsero la guerra nei confronti del Psi di Craxi, sia pure transitoriamente e illusoriamente. E allora per il sottoscritto e per altri compagni socialisti, in primis coloro che tuttora danno vita al Psi, a Mondo Operaio e ad alcune significative fondazioni, c’è oggi un obiettivo prioritario, quello di evitare che la storia del movimento operaio italiano si risolva, come è spesso avvenuto nel passato, nella storia fatta dai vincitori.
Credo che su questo terreno qualche risultato significativo è stato raggiunto per tre ragioni di fondo: perché c’è stato un lavoro autonomo fatto da alcuni storici di grande qualità: solo per fare qualche nome mi riferisco a Piero Craveri, a Simona Colarizi, a Andrea Spiri, ai dieci volumi costruiti da Gennaro Acquaviva e da Luigi Covatta; in secondo luogo perché da un certo momento in poi i “ragazzi di Berlinguer” hanno accuratamente evitato il confronto su questo campo preferendo occuparsi di altro e cioè di una gestione sempre più asfittica del potere; in terzo luogo perché alcuni dei più significativi intellettuali di origine comunista (Biagio De Giovanni, Beppe Vacca, Silvio Pons, lo stesso Istituto Gramsci) si sono collocati su una dimensione storico-critica più elevata, insomma, per usare una battuta di Antonio Gramsci, stanno lavorando “fur ewig”, al di fuori e al di là dello scontro che ha diviso i socialisti e i comunisti negli anni ’80 e ’90.
Dicevo che quella del ’92-’94 è stata per molti aspetti una vittoria transitoria e illusoria. Infatti avendo liquidato quello che era considerato il nemico principale, cioè il “social-fascista Craxi”, i “ragazzi di Berlinguer” hanno ritenuto di essere comunque arrivati a una piena conquista del potere politico e invece con loro sorpresa si sono trovati sbarrati il campo da parte di Berlusconi. Da qui prese corpo una sorta di bipolarismo anomalo, ben diverso dal bipolarismo europeo. Poi, anche in seguito alla devastante crisi economica del 2008-2010 quel bipolarismo è andato a gambe all’aria e ha finito col produrre i mostri con cui oggi ci troviamo a fare i conti, cioè il sovranismo razzista di Salvini e il populismo giustizialista e anti politico del Movimento 5 stelle. Non voglio scandalizzare nessuno, ma secondo me fra questi due mostri, la tematica berlingueriana della questione morale e della damnatio di tutti gli altri partiti e poi fra tutta la vicenda di Mani Pulite del ’92-’94, c’è un nesso, una sorta di consequenzialità.
Il grillismo e il sovranismo sono a mio avviso la conseguenza finale dei demoni messi in circolo addirittura da quel Pci che originariamente (dal 1945 in poi) era la forza politica più storicista, più impegnata nella valorizzazione della politica, del ruolo dei partiti, del parlamento e della mediazione: tutto ciò era una delle caratteristiche più significative del Pci, ma del Pci di Togliatti, non di quello di Berlinguer, alcuni tratti del quale (e le battute di Tatò esprimono lo spirito dei tempi) ha incorporato in sé stesso, con tutti gli aggiornamenti inevitabili. Ma più i tratti del VI Congresso dell’Internazionale Comunista, quello per intenderci del social-fascismo, che non quelli del VII, il Congresso dei fronti popolari (vedi a proposito di tutto ciò il bellissimo libro di Paolo Franchi). In questo quadro non capisco perché, caro Fausto, ti identifichi totalmente nell’ultimo Berlinguer, rappresentato come un generoso e appassionato interprete del movimentismo.
No, a mio avviso, l’ultimo Berlinguer fu rattrappito in un chiuso settarismo, certamente nobilitato da un impegno personale condotto usque ad effusionem sanguinis, per una spasmodica e disperata battaglia contro quello che era ritenuto il male e quindi come tale meritevole dell’onore delle armi come si deve a tutti i combattenti che credono fino in fondo nelle idee.
Ciò detto, vengo ad altre osservazioni sull’articolo così felicemente provocatorio di Fausto Bertinotti. A mio avviso il Psi di Craxi, degli intellettuali socialisti, del Progetto Socialista, della tematica sui meriti e i bisogni sviluppata da Claudio Martelli, e sul lavoro di governo di Gianni De Michelis, colse tempestivamente il cambiamento di fase del capitalismo: dal capitalismo fordista a quello del salto tecnologico, dell’innovazione, della fase globalizzante, che richiedeva in Italia una grande riforma dello Stato e rapporti di lavoro meno conflittuali e più partecipativi al limite della cogestione. In un certo senso si è trattato di una posizione che conteneva in sé anche elementi utopici perché una parte della classe operaia era su posizioni duramente conflittuali e una parte del mondo imprenditoriale era sulle posizioni di una sorta di marxismo alla rovescia (non la dittatura del proletariato, ma la dittatura degli imprenditori). Forse se tutto il movimento operaio italiano si fosse spostato sulle posizioni dell’innovazione, della partecipazione, al limite della cogestione sarebbe riuscito a influenzare gli indirizzi del capitalismo e a dare una sponda a quella parte di esso che, partendo da Adriano Olivetti, aveva una visione positiva e dinamica dell’attività imprenditoriale.
Del resto, come Fausto sa meglio di me, perfino sui fatti di Ungheria, per non parlare del piano del lavoro e di molti aspetti della politica sindacale, le posizioni di Peppino Di Vittorio erano molto spesso vicine al riformismo e al revisionismo socialisti, così come quelle di Luciano Lama sulla scala mobile nella sostanza erano molto vicine a quelle di Bettino Craxi e di Gianni De Michelis a testimonianza di una dialettica rispetto alla quale sempre il berlinguerismo ha rappresentato un elemento di rottura. Non a caso Enrico Berlinguer collocò Sergio Garavini accanto a Lama in funzione di guardiano del faro. Quanto poi alla tematica del “Vangelo Socialista” anch’io ritengo che Marx non sia un “cane morto” e che anzi ci offra strumenti di analisi e di interpretazione della realtà, Fausto, non di strategia della rivoluzione. Da quest’ultimo punto di vista la rivoluzione nelle punte alte del sistema capitalistico si è rivelata impossibile e l’unica via praticabile è tuttora quella che si può esprimere attraverso il compromesso socialdemocratico in molteplici versioni.
L’ipotesi marxista di rivoluzione nelle punte alte del capitalismo si è rivelata impossibile e impraticabile, mentre il leninismo, cioè quello che Gramsci chiamò «la rivoluzione contro il capitale», si è rivelato uno stupro storico che, parallelamente al nazismo, ha prodotto una delle versioni più aberranti del totalitarismo (gulag, antisemitismo e carestie). Per altro verso, però, il capitalismo sta esprimendo una miriade di contraddizioni, di perversioni e di potenziali pericoli rispetto ai quali l’analisi marxista può offrire decisivi strumenti di lettura e di interpretazione funzionali anche alla sua correzione, al suo condizionamento, non alla sua eliminazione. Aggiungo che del capitalismo globalizzato, finanziarizzato e deregolamentato non tanto Marx, quanto Rudolf Hilferding con il suo Capitale finanziario può dare una lettura di straordinaria modernità: diceva Hilferding che l’eccesso di finanziarizzazione dell’economia colpisce entrambe le classi fondamentali del rapporto di produzione capitalistico, cioè gli imprenditori e la classe operaia.
Non si tratta di una questione puramente teorica perché purtroppo oggi la socialdemocrazia europea e lo stesso partito Democratico americano oscillano fra estremi opposti, entrambi segnati da drammatiche sconfitte politiche: da un lato Corbyn, chiuso nel suo dogmatismo paleomarxista, dall’altro lato nella vittoria di Trump non c’è stato solo l’indubbio appoggio datogli dal sistema di internet di Putin applicato alla manipolazione delle democrazie occidentali. C’è anche il fatto che a suo tempo le principali leggi di deregolamentazione del sistema bancario e finanziario americano – che hanno prodotto la crisi dei titoli tossici che ha distrutto fabbriche, pensioni, credito al consumo di tanti americani del ceto medio e della classe operaia – sono state firmate da un presidente il cui nome è Clinton, come il candidato democratico inopinatamente sconfitto da Trump, un presidente fatto davvero su misura per la partita geopolitica di Vladimir Putin, un genio delle mosse nello scacchiere della geopolitica.
Per concludere, colgo l’occasione per un’ulteriore riflessione. Di fronte alle singolari vicende proprietarie ed editoriali di Repubblica Eugenio Scalfari si presenta come il gran sacerdote del liberal-socialismo che evidentemente in questa qualità sta anche interloquendo da pari a pari con il Papa dei cattolici. Effettivamente alle sue origini Repubblica è stato il giornale dei liberal-socialisti. Poi però quel liberal-socialismo si è perso per strada: non c’entrano niente col liberal-socialismo né Berlinguer, specie nella sua fase della questione morale, della quale Scalfari fu l’ispiratore e Repubblica il braccio armato, né Ciriaco De Mita, per il quale sempre Scalfari fece una campagna elettorale dagli esiti disastrosi.
A sua volta Rino Formica rileva ironicamente che, a fronte della scomparsa ormai da trent’anni dei liberali e dei socialisti come forze politiche organizzate, in questi giorni c’è addirittura una sorta di inflazione nella presentazione di prodotti editoriali di varia dimensione (autentici giganti e iniziative lillipuziane) che si autodefiniscono come socialisti liberali. Giustamente Rino rileva che: «C’è troppa confusione sotto il cielo. Mi pare che non si tratta di nostalgie, ma di presentazione di prodotto ignoto coperto da vecchi marchi». Al di là di queste condivisibili osservazioni non si può fare a meno di rilevare che mai il sistema politico italiano, malgrado il dramma che stiamo vivendo, ha presentato caratteristiche così negative.
A livello di maggioranza da un lato c’è, come abbiamo già visto, un Movimento 5 stelle segnato da posizioni populiste e giustizialiste, temperate da un Pd che ha l’unico pregio di assicurare la tenuta di un rapporto con l’Europa, ma che è caratterizzato da una sostanziale assenza di progettualità politica di stampo riformista dominato dalla gestione emergenziale del potere e schiacciato dai meccanismi ereditari della sinistra Dc e del tardo berlinguerismo. A livello di opposizione, le posizioni sovraniste e razziste sono molto pericolose e sempre più contraddittorie con il centrismo popolare di Berlusconi. In mezzo a queste due involuzioni potrebbe farsi strada una forza socialista riformista a condizione che essa sia autonoma dagli opposti blocchi.
Purtroppo, però, di questa forza mancano una nuova leadership, una classe dirigente, iniziative mediatiche di peso, non autoreferenziali. Esistono invece una forte cultura politica e, per altro verso, tante individualità sparse, alcune delle quali segnate da personalismi francamente ridicoli con il tempo che passa. Ma dalla cultura politica e dalle singole individualità alla aggregazione di un soggetto politico realmente autonomo e di peso c’è un salto di qualità assai difficile da realizzare. Comunque, come si dice, mai dire mai.