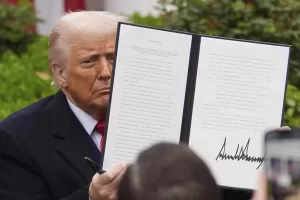Vi dico perché il riformismo è rivoluzionario
“Governo Draghi è di necessità e di tregua, ma ora il premier deve mediare coi partiti”, intervista a Rino Formica

Se c’è un uomo che il “riformismo” lo ha “frequentato” per una vita intera, quell’uomo è Rino Formica. Più che una intervista, quella che segue è una lezione di politica, quella alta, fatta di passione civile e lucidità intellettuale, impartita da un signore di 93 anni, uno degli ultimi “Grandi vecchi”, e grandi per statura politica e non per anzianità acquisita, della politica italiana. Dar conto di tutti gli incarichi di primo piano, di governo – Ministro delle finanze, dei trasporti, del commercio con l’estero, del lavoro e della previdenza sociale – e di partito, che il senatore Formica ha ricoperto, prenderebbe tutto lo spazio di questa intervista.
Senatore Formica, su questo giornale si è aperto un vivace dibattito a sinistra sul concetto di riformismo. Per Goffredo Bettini l’essenza di un riformismo forte consiste «nell’accorciare le distanze tra chi sta sopra e chi sta sotto». E per lei?
Vede, c’è un elemento di fondo, sempre valido, che distingue il riformismo dal conservatorismo. Il riformismo pone i problemi maturi per risolverli. Il conservatorismo attende che i problemi siano marci per poi non poterli risolvere. Tutto il resto, se c’è un avvicinamento o un allontanamento delle classi, sono tutte quante semplificazioni scolastiche. C’è poi un’altra cosa importante da aggiungere: la soluzione riformistica non esclude la soluzione della rottura, anche la soluzione violenta. Rivoluzione e riforme non sono necessariamente due termini in conflitto. Possono anche essere elementi convergenti. La rivoluzione crea un momento della rottura, la riforma modifica il sistema nel punto dove è avvenuta la rottura.
C’è chi sostiene invece che questa dicotomia rivoluzione/riformismo sia stata definitivamente cancellata e risolta nell’89 con la caduta del Muro di Berlino e il disfacimento dell’impero sovietico.
Dentro questa annotazione storico-politica io leggo anche un tentativo “riduzionista” del riformismo. È vero il contrario. Il riformismo oramai ha un campo enorme di interesse. Affronta tutti quanti i problemi della società. Mentre prima il riformismo era concentrato fondamentalmente su un elemento, le diseguaglianze sociali, oggi il riformismo ha un campo vasto perché affronta tutte quante le questioni. Vuole un esempio fresco fresco di questo riformismo “rivoluzionario”?
Certo che sì.
Pensi alla posizione ufficiale del presidente americano sulla vicenda di questi giorni, di queste ore, sul potere della polizia di uccidere. Quello di Biden è un elemento rivoluzionario e al tempo stesso riformista. Perché compie una rottura su quello che era un principio sacro: il potere della polizia era un potere assoluto, non valutabile, non censurabile, non affrontabile se non rompendo equilibri all’interno della società. Questo principio è stato rotto. Quello compiuto da Biden è un atto rivoluzionario che apre la strada alla riforma.
Per tornare al dibattito politico italiano, in particolare nel Partito democratico e a sinistra, un tema molto sentito riguarda l’alleanza Pd-5Stelle. Per Bettini si tratta di un’alleanza strategica dentro la quale il Pd dovrebbe essere la gamba sinistra. Michele Prospero, sempre dalle colonne de Il Riformista, ha sostenuto che con questa scelta il Pd si consegna all’antipolitica grillina. Lei come la vede?
Ma sa, mi pare un po’ degradante affrontare una polemica di questo tipo, che è fuori dalla tradizione, è fuori dalla nostra dottrina, ed è fuori da tutta una serie di atti storici che ha compiuto la sinistra. La sinistra italiana non è mai stata legata al populismo e alla demagogia populista. Mai. Poi certo ha commesso una serie di errori, che sono anche di visione generale: l’aver dato, ad esempio, eccessivo peso all’utopia, e cioè di non aver verificato come la prospettiva storica deve inverarsi negli atti di azioni quotidiane. Questo rapporto tra prospettiva ed evoluzione quotidiana molte volte si è rotto, sia in un senso che nell’altro, cioè sia in un eccesso di utopismo sia in un eccesso di pragmatismo che in definitiva è finito per diventare minimalismo di potere. Sono polemiche queste che danno il segno della decadenza. Mi lasci aggiungere una cosa che riguarda un vecchio vizietto della sinistra…
Di quale vizietto si tratta, senatore Formica?
Di una certa spocchia da primi della classe. Se il termine spocchia non le piace, diciamo vecchia illusione, propria e di una parte della sinistra storica italiana: quella di dire noi entriamo, poi siccome siamo i più forti, siamo i più intelligenti, i più capaci, i più furbi, alla fine ce li mangeremo o li “addomesticheremo”. L’idea loro era che poi, alla fine, avrebbero istituzionalizzato il populismo. Mentre è il populismo ad aver corroso le istituzioni e lo stesso Partito democratico. E all’orizzonte non intravvedo significative correzioni di rotta.
In tutto questo contesto del presente, c’è il giudizio sul segno del governo Draghi. C’è chi ha parlato di un governo “tecnico”, chi ha tirato in ballo l’italico vizio di andare alla ricerca, nei momenti di più acuta crisi, del salvatore della patria, e tante altre definizioni. Sulla base della sua lunghissima esperienza politica e di governo, le chiedo: qual è a suo avviso il segno più corretto di questa “operazione Draghi”?
Il segno sta nel suo atto costitutivo. E l’atto costitutivo è nella comunicazione che il presidente della Repubblica fece agli italiani quando incaricò Draghi di formare il Governo. Cioè che questo Parlamento non era in condizioni di esprimere un Governo e che quindi c’erano le condizioni per lo scioglimento delle Camere. Ma che la presenza di due emergenze – quella sanitaria e quella dell’elaborazione del piano per il Recovery fund offerto dall’Europa – impediva lo scioglimento delle Camere, perché sarebbe stato prodotto un danno all’intera comunità nazionale per l’immediato futuro. Mattarella lo ha scelto perché Draghi non è solo un “tecnico” di eccellenza. Ma perché rappresentava, a ragione, il garante della nostra credibilità internazionale, non solo in Europa ma oltre oceano. E poi lasci perdere queste miserevoli polemiche tra “tecnico” e “politico”. Se non sono politiche le scelte compiute da Draghi quando era presidente della Bce, mi si dica cosa è “politica”. Ciò detto, questo nasce come un Governo di necessità e di tregua. Coperto dalla garanzia del garante costituzionale del Paese che è il presidente della Repubblica. Se poi strada facendo questa copertura, che aveva come presupposto sottrarre il Governo ai giochi meschini di palazzo e di un Parlamento disgregato, è diventata meno incisiva di com’era nelle premesse, è un tema politico e la discussione è aperta. Se Draghi ha qualche difficoltà, come io vedo in questi giorni, si tratta di difficoltà – è una delle letture politiche del momento – che nascono dal fatto che si è affievolita la copertura istituzionale che era nell’atto costitutivo del suo Governo. Ciò ha costretto Draghi a far ricorso a delle pratiche che erano già state ritenute deleterie e distruttive. Cioè la mediazione di accordi con una politica, quella dei partiti, che politica non era più.
© Riproduzione riservata