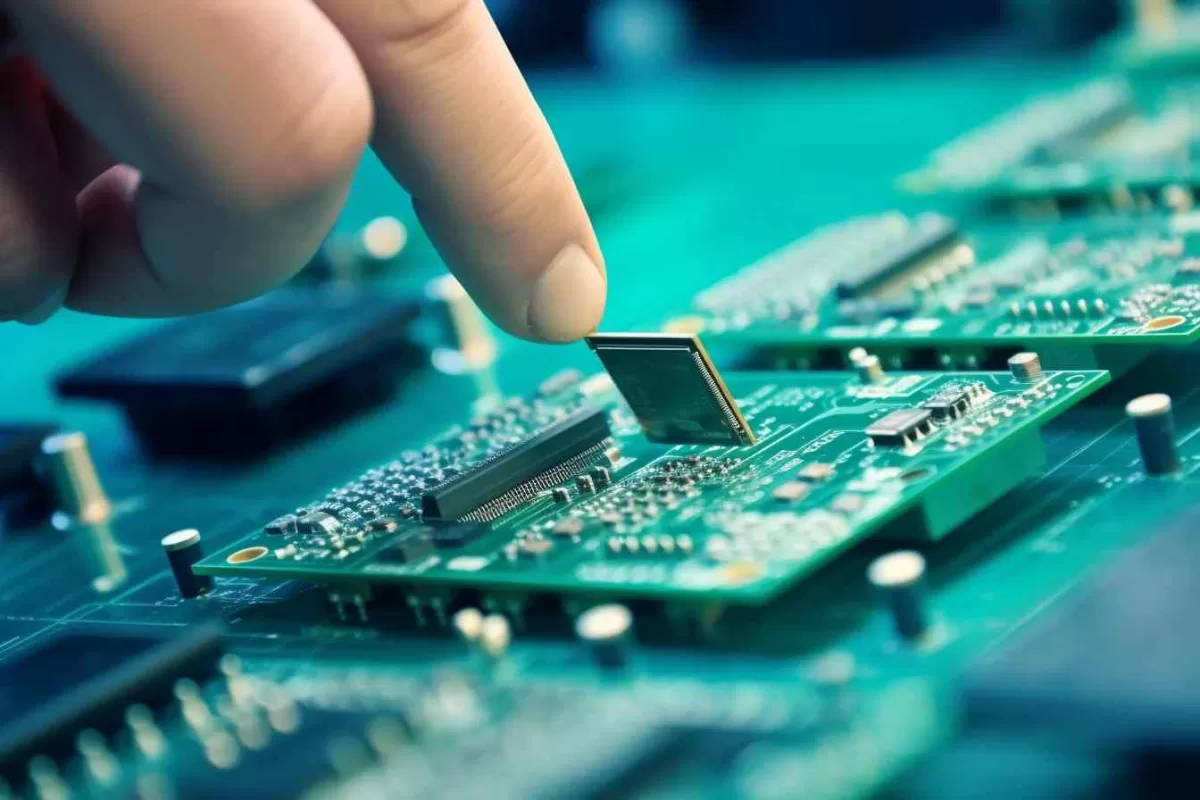E se dalla crisi economica (e pure politica) tedesca nascesse un progetto di industria europea, capace di tener testa ai colossi dell’innovazione tecnologica degli Stati Uniti e di tutta l’Asia? Intendiamoci: ci sono tutti i presupposti per considerare la Germania come il malato d’Europa. Peraltro, in questi giorni, sembra che la sua salute si sia aggravata. Le intenzioni della Intel, leader Usa dei microprocessori, e soprattutto della Volkswagen di bloccare gli investimenti e chiudere le fabbriche non sono rassicuranti. D’altra parte, non può trattarsi di una banale coincidenza geografica la scelta della Tsmc di aprire una sua gigafactory proprio in Germania, a Dresda.
L’obiettivo di Bruxelles
Al taglio del nastro dell’impianto del colosso taiwanese dei chip, peraltro concorrente diretta di Intel – un investimento iniziale di 3,5 miliardi di euro, che si prevede andrà a crescere fino a 10 – c’era anche Ursula von der Leyen. Fresca di conferma, la Commissaria Ue sa che nella corsa alla leadership del mercato globale dei microprocessori, l’Ue deve dare un colpo di acceleratore. Bruxelles ha chiara la necessità di rompere la dipendenza dalle batterie e dai chip made in China. Soprattutto in un regime di protezionismo e dazi, peraltro da noi stessi voluti, non possiamo permetterci di dipendere dal nemico. E allora da dove far partire questa rimonta se non dalla prima manifattura del continente? Una rimonta che, per forza di cose, dovrà essere fatta a tappe forzate, visto che l’Europa è l’ultima arrivata in un settore dominato da Usa, Giappone e poi Corea del Sud, Taiwan e ancora Cina, ormai da oltre quarant’anni. Ammesso e non concesso, però, che sia realistico l’obiettivo di Bruxelles di passare dal 10% al 20% di produzione globale di semiconduttori entro il 2030, restano i dubbi sulle risorse e sulle modalità per dare sostanza a queste ambizioni.
Al confronto con i 52 miliardi di dollari del “Chips and Science Act” degli Usa, ma ancor più con i 450 miliardi di dollari del “K-Semiconductor Strategy” della Corea del Sud, il Chips Act da 43 miliardi di euro dell’Ue resta in una modesta terza posizione. Di questi 43 miliardi, 11 sono investimenti diretti dell’Ue e 32 dovrebbero essere stanziati dai Paesi membri o raccolti da fondi privati. La misura europea va dalla garanzia della fornitura delle materie prime – il silicio dei chip europei viene da Brasile o Cina – all’aumento della produzione, fino ad arrivare alle attività di ricerca, sviluppo e sensibilizzazione all’accesso delle Pmi alle tecnologie avanzate. Tuttavia, la nostra effettiva debolezza sta nella visione d’insieme. Ancora negli anni Ottanta, il mercato dei chip vedeva, da un lato, Usa e Giappone contendersi il dominio della progettazione. Dall’altro, Corea del Sud e Taiwan, con il loro mercato del lavoro a basso costo, a far da gregari nella produzione. Oggi i ruoli si sono invertiti. Il Giappone ha perso via via lunghezze, gli Usa mantengono il boccino, ma sono tallonati da Corea e Taiwan, che invece godono di un dominio nato dall’aver avuto dei governi intenzionati a fare dei microprocessori una priorità nazionale.
Lo stesso ha fatto la Cina, che controlla circa il 10-15% del mercato. In circa quarant’anni, Seoul, Taipei e Pechino hanno indirizzato le proprie politiche industriali con l’esplicito obiettivo di controllare il mercato della microelettronica. Hanno imposto alle università di fare ricerca e alle imprese di investirvi. Hanno indirizzato i loro giovani ad acquisire le competenze necessarie per diventare una nuova generazione di tecnici e ingegneri. Tutto questo dirigismo non è nel Dna dell’Unione europea. Ma, volendo dare un significato a quel “cambiamento radicale” di cui in teoria si parla nel rapporto Draghi sulla competitività, è proprio questo ciò che ci serve. Cooperazione tra gli Stati membri e coordinamento dell’Ue. Solo così si può competere con chi di chip e microprocessori ne mastica da decenni. Solo così si può evitare che il caso Tsmc a Dresda resti un’isolata iniezione di risorse per la Germania malata, anziché una cura ricostituente per tutta l’industria europea.