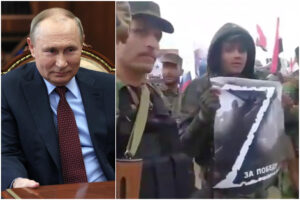Economia
Guerra del grano, la contro sanzione di Putin che può mettere in ginocchio un’Europa poco lungimirante

La vicenda è talmente seria che non pochi osservatori l’hanno già ribattezzata “guerra del pane”, paragonandola alla vera atomica che Putin ha in mano. Le agenzie hanno battuto la notizia ieri sera: la prima contro-sanzione della Russia riguarda il grano. Vietate le esportazioni fino al 31 agosto. Un duro colpo per i produttori di quel Paese, certamente. Ma, come nella logica ambivalente dell’istituto delle sanzioni, un duro colpo anche per noi.
Dalle sole Russia e Ucraina parte infatti oltre il 30% del grano utilizzato in tutto il mondo. La Russia, in particolare, ne è il primo esportatore mondiale. Nella bilancia commerciale riguardante proprio il grano, il 2021 ha fatto registrare numeri astronomici alla voce “importazioni”: 122mila tonnellate dall’Ucraina e 120mila dalla Russia. Se la prima voce ovviamente si cancella per ragioni più che ovvie, la seconda è stata invece azzerata dalla contro-sanzione dello Zar.
Conseguenze largamente prevedibili: scarsità di risorse e aumento del prezzo, già oggi al suo massimo da qualche anno a questa parte. Prendendo in considerazione il listino di oggi della Borsa di Altamura (zona considerata il granaio d’Italia per quantità e qualità), un quintale di grano duro è scambiato a oltre 52€, in aumento di settanta centesimi sulla settimana precedente. Aumenti che porteranno – già stanno portando – a conseguenti e relativi rincari dei prodotti ricavati dal frumento: pasta e pane su tutti, ma anche biscotti. Stessa situazione per il granturco, utilizzato nell’alimentazione degli animali, che aumenta vertiginosamente (+20%) in una sola settimana.
È possibile che in ambito europeo nessuno abbia annusato per tempo il pericolo e che solo ora, a bombe lanciate e ospedali dilaniati, ci si accorga che forse un minimo di diversificazione nell’approvvigionamento non sarebbe stata una scelta così negativa? È possibile che le istituzioni siano stati così miopi rispetto a una minaccia che andava sempre più stagliandosi all’orizzonte?
Prendiamo in considerazione la bussola dell’agricoltura del Vecchio Continente, la PAC (Politica Agricola Comunitaria). Anche solo guardandola per sommi capi, si capisce benissimo quanto abbia sfavorito la produzione di grano a vantaggio – era l’obiettivo – di un miglioramento qualitativo. Il risultato lo stiamo vedendo oggi, ed è lo stesso che si può trasporre in ambito energetico: dipendenza da produzioni estere. Russe soprattutto. L’Italia, maggiore produttore di cereali in ambito europeo, importa il 64% del proprio fabbisogno di grano per la produzione di pane e pasta. Percentuali che restano così elevate perché la nuova politica europea prevede, sostanzialmente, all’interno di una stessa proprietà una ferrea rotazione nella semina. Dove ho seminato quest’anno non semino l’anno prossimo. Non basta: oltre una certa estensione, è prevista anche una quota di cosiddetto “greening” (l’ossequio al verde imposto non manca mai), superficie lasciata completamente incolta. Nel 2018, la superficie totale coltivata a grano è calata rispetto a dieci anni prima da 2 milioni e 300mila ettari a 1 milione e 820mila ettari: quasi mezzo milione di ettari in meno, circa il 20%. Parimenti, la produzione è scesa da 9 milioni a 7 milioni di tonnellate. Nel 2019, poi, ISEMA aveva registrato un ulteriore calo del 7% della produzione di grano.
Non è un caso che la Confederazione Italiana Agricoltori chieda, tra le altre cose, la sospensione del Patto di Stabilità, l’eliminazione dell’IVA sulle accise per i carburanti agricoli e l’introduzione di sostegni per remunerare le perdite delle imprese agricole. E non è un caso neanche che in un recentissimo incontro con il sottosegretario all’Agricoltura Gian Marco Centinaio, il presidente di Coldiretti Ettore Prandini abbia parlato della possibilità immediata di recuperata oltre un milione di ettari alla coltivazione di cereali. “Ma bisogna garantire redditività alla coltivazione, contrastare seriamente l’invasione della fauna selvatica (che in molte zone interne sta portando all’abbandono dalla coltivazione) e intervenire seriamente sulle normative comunitarie che spingono a non coltivare i terreni, eliminando ad esempio l’obiettivo del 10% di terreni incolti”.
A buoi già scappati, insomma, si cerca di chiudere le stalle. Fa specie, però, che a farlo siano le associazioni di categoria, mentre le istituzioni europee continuano bellamente a sonnecchiare.
© Riproduzione riservata