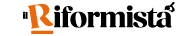È passato mezzo secolo dalla rivolta di Reggio Calabria ma nella testa di chi ha vissuto quei giorni ancora rimbomba il grido: “Reggio capoluogo-boia chi molla”. E fu veramente una rivolta di popolo. L’ho vissuta dall’altra parte della barricata e ho dinanzi agli occhi i volti dei manifestanti per “Reggio capoluogo” che, quantomeno nella prima fase, non erano fascisti e men che meno mafiosi ma le donne e gli uomini della città. Appartenevano a tutti i ceti sociali e sfilavano sul corso Garibaldi. Tutto ebbe iniziò con le elezioni amministrative del 7 e 8 giugno del 1970 quando per la prima volta s’era votato per la Regione. Furono elezioni noiose. I risultati elettorali consegnavano, ancora una volta, una nettissima maggioranza di suffragi ai partiti di governo.
Il Pci, dopo la sconfitta delle lotte per le terre, appariva sempre più come partito di apparato senza alcuna strategia meridionalista. Quindi non deve sorprendere se alle elezioni comunali di Reggio città, la Dc aveva conquistato ben 23 seggi rispetto ai 7 del Pci. A “Roma” si decise che Catanzaro doveva essere il capoluogo. Una decisione, frutto di un accordo tra i maggiorenti calabresi dei partiti di governo, che Reggio visse come l’ennesima mortificazione della città e della democrazia e il “capoluogo” divenne così un piccolo fiammifero casualmente caduto in un pagliaio ma in grado di sviluppare un pauroso incendio. Un mese dopo Reggio era un vulcano in eruzione non solo contro il governo ma anche contro lo “Stato” italiano. Dopo le prime pacifiche manifestazioni di massa, già il 15 luglio comparvero le prime barricate che crebbero di numero e dal corso Garibaldi si estesero ai quartieri popolari.
A presidiarle la gente comune e soprattutto i più giovani. L’appello alla lotta venne lanciato dal “Comitato per Reggio capoluogo” presieduto dal sindaco della città Piero Battaglia, un democristiano, espressione della burocrazia cittadina storicamente egemone in città, e che avrebbe voluto mantenere i “moti” nel perimetro della legalità e dell’ordine costituito. Battaglia non riuscì nel suo intento di stipulare un “compromesso onorevole” col “governo di Roma” che, in quel momento, non era in condizioni di dare risposte concrete ai manifestanti. Intanto la sinistra, iniziando dal partito comunista, commise il tragico errore di sfilarsi dalla rivolta popolare bollandola come stupida contrapposizione di campanile o, peggio ancora, come una lotta per il “pennacchio”. Non si accorsero che sotto i loro occhi si stava sviluppando l’ultima rivolta del Sud ridotto a colonia interna. Non capirono che, grazie a quella rivolta, una “città invisibile” marcava la propria esistenza in vita e, contemporaneamente, i ragazzi delle periferie cittadine manifestavano tutta la loro voglia di esser protagonisti della loro storia.
La “diserzione” della sinistra e l’ondivaga e timida presenza Dc, consentirono ai neofascisti di inserirsi alla testa dei “moti” in quanto disponibili a mettersi “fuori legge” e darsi alla latitanza così come fece Ciccio Franco, capo riconosciuto del “boia chi molla”. Non erano delinquenti. Molti di loro pensavano di reagire a un oltraggio contro la città. Alle manifestazioni pacifiche seguono le barricate, i sassi, le molotov, gli assalti alle federazioni del Pci e della Cgil. Poi gli scontri sempre più violenti con le forze dell’ordine. Cadono le prime vittime: il ferroviere Bruno Labate e l’autista Angelo Campanella e tanti altri ancora. La rivolta si inasprisce e diventa guerriglia urbana. Vengono mandati i carri armati a stazionare sul lungomare e, per la prima e unica volta nella storia della Repubblica, si registrò l’intervento dell’esercito e l’impiego dei blindati per la rimozione delle barricate. Seguono le bombe contro tutti i “luoghi- simbolo” dello Stato. Vengono spiccati i primi mandati di cattura contro i capi dei “moti” e i “guerriglieri” reagiscono dando l’assalto alle armerie cittadine.
A questo punto c’è il rischio concreto che i sassi e le molotov vengano sostituiti dalle pallottole e che la rivolta diventi guerra armata anche perché nel frattempo qualcuno si muove nell’ombra e per fini diversi rispetto ai manifestanti, facendo “deragliare” dolosamente un treno a Gioia Tauro e provocando la morte di ben sei persone e di tantissimi feriti. Mentre uno strano incidente stradale provoca la morte di cinque giovani anarchici che si stavano recando a Roma con documenti scottanti da consegnare alla rivista “Umanità nuova”. La rivolta si va trasformando negli uomini e nei fini. Progressivamente cambiano i protagonisti e dalle barricate scompaiono i figli del ceto medio e della burocrazia reggina, non disponibili a rischiare il loro stato sociale e mettersi “fuori legge”, ma restano ancora i ragazzi delle periferie cittadine. Tra i nuovi “protagonisti”, i rampolli della ‘ndrangheta reggina che, come vedremo, avevano fatto già la loro inquietante comparsa nell’arena “politica” della città nel mese di ottobre al seguito del principe nero Junio Valerio Borghese.
E già a fine settembre sono altri – rispetto a luglio – a dirigere i moti e a far in modo che la rivolta si trasformasse in un anello, sia pure importante, nella strategia della tensione iniziata con la bomba alla “Banca dell’Agricoltura” e che avrebbe dovuto avere come sbocco il golpe militare. Già nel mese di settembre del 1970 appare chiaro che i “moti” hanno i loro “capi” riconosciuti, soprattutto Ciccio Franco, ma sono privi d’ una classe dirigente all’altezza della situazione e di una strategia capace di portare il movimento al successo. I “boia chi molla” non sono in condizioni di accettare alcun “compromesso” perché prigionieri della rabbia della gente. Essendo neo fascisti, non credono nel “meridionalismo” e non rientra nei loro orizzonti la l’attuazione della Costituzione.
Si trovano così in un vicolo cieco. In questo clima è più che ipotizzabile che il mese di “ottobre” sia stato lo spartiacque tra la protesta per il capoluogo e la svolta verso l’eversione nera. Probabilmente non preventivata e non calcolata dallo stesso Ciccio Franco e dai suoi più stretti collaboratori. C’è un episodio inquietante rimasto sempre sullo sfondo: il summit delle cosche reggine a Montalto, in pieno Aspromonte, del 26 ottobre del 1969. Il summit avrebbe dovuto decidere l’alleanza della ‘ndrangheta reggina con la destra eversiva del principe Junio Valerio Borghese. Significativo il fatto che nessuno abbia mai saputo l’identità di tre uomini incappucciati che avrebbero presenziato al summit senza prendere la parola. Il giorno successivo a Reggio, in seguito alla mancata autorizzazione a Borghese di tenere un comizio, si registrano scontri durissimi in cui rimangono feriti una trentina di appartenenti alle forze dell’ordine. E stranamente solo 4 manifestanti.
A sostenere gli scontri oltre agli aderenti al “Fronte” e ad “Avanguardia Nazionale”, i giovani delle cosche reggine che non si accontentano più di essere parcheggiati nell’anticamera e negli scantinati del “potere”. Chiedono di entrare nel salotto buono della città. Il principe Borghese indica ai più “fidati” tra i dirigenti della rivolta e ai capi cosca un obbiettivo a breve scadenza: il golpe militare programmato per la notte del 7 dicembre 1970 quando uomini armati penetrano, nei sotterranei del ministro dell’Interno. Il golpe viene bloccato prima dell’alba e la deriva eversiva e “fascista” verso cui era stata spinta la rivolta di Reggio causa un contraccolpo inaspettato in difesa della democrazia. Il 4 aprile del 1971 viene convocato nel teatro comunale il consiglio regionale della Calabria per l’approvazione dello Statuto. È una prova di forza anche dal punto di vista di un possibile scontro fisico. Il “comitato d’azione” proclama lo sciopero e la mobilitazione generale.
Le forze antifasciste sanno bene di non poter contare sulle forze dell’ordine per la difesa della loro incolumità e per il loro diritto a manifestare liberamente. Nonostante ciò migliaia di persone confluiscono verso il teatro comunale. Alcuni verranno bloccati dai “neofascisti” nelle periferie cittadine, molti pullman danneggiati saranno costretti a ritornare indietro ma la maggioranza dei militanti antifascisti, raggiungeranno il teatro Cilea. Il “boia chi molla” ha perso in casa. La mobilitazione democratica farà da sponda alla borghesia cittadina intenzionata a rompere con le forze dell’eversione.
Alla fine della manifestazione del 4 aprile, i partecipanti rifiuteranno la proposta della questura di defluire dalle porte laterali del teatro e usciranno a testa alta dall’ingresso principale malgrado la grandinata di pietre e monetine lanciate dai ragazzi di Reggio di cui ricordo perfettamente il volto teso e lo sguardo smarrito perché intuivano – e non a torto – di esser stati abbandonati al loro destino. Borghese aveva lasciato l’Italia. La borghesia cittadina avrà i suoi impiegati negli uffici del consiglio regionale. La ndrangheta verrà associata ai lavori del “pacchetto Colombo” e riconosciuta come una “forza” con cui fare i conti. Restano fuori dei nuovi equilibri di potere sia i generosi ragazzi delle periferie cittadine che hanno creduto nella “causa” di Reggio; quanto i loro coetanei che, con altrettanta generosità, si erano schierati contro la deriva “fascista”. Nel 1972, malgrado Reggio sia elettoralmente la città più “nera” d’Italia, i “boia chi molla” non hanno più il controllo della piazza.
Il comizio di Pietro Ingrao del 5 maggio e la grande manifestazione sindacale del 22 ottobre, che vede sfilare per le vie di Reggio “centomila” tra metalmeccanici e antifascisti, dimostrano che a Reggio è stata riconquistata la libertà di manifestare liberamente ed esporre le proprie idee politiche. Nel momento in cui bisognava resistere ai “boia chi molla” e contrattaccare, i partiti dell’arco costituzionale avevano solennemente giurato che nel Sud, ed in particolare in Calabria, nulla sarebbe stato più come prima. Finiti i moti nulla di quanto promesso fu mantenuto. La Calabria visse un periodo di autentica “Restaurazione” che andò via via peggiorando man mano che ai “vecchi poteri” venivano associati, sia pure in posizione di assoluta subalternità, i sindacati prima e l’opposizione di sinistra dopo. La “destra” si avvicinava all’area di governo e di sottogoverno fino a farne parte organicamente.
La rivolta restava un ricordo da celebrare senza però analizzare e dar spazio alle ragioni vere che avevano spinto i giovani più poveri della città a salire sulle barricate. Per evitare altre “rivolte”, il governo, le banche, la Confindustria, danno la loro disponibilità a “concedere” alla Calabria fondi destinati soprattutto ai lavori pubblici che quasi sempre evaporano tra la distrazione degli organi preposti alla vigilanza. Ma soprattutto vengono “concessi” sussidi e migliaia di assunzioni artificialmente creati nella pubblica amministrazione. Pongono però come condizione “non negoziabile” la salvaguardia d’un sistema di sviluppo che avrebbe condannato inesorabilmente la Calabria al ruolo di colonia interna. È questo il cuore del problema a 50 anni dalla “rivolta”. La “Restaurazione” consentirà ai partiti politici di continuare a prendere i voti ma toglierà alla politica ogni autorità e ogni prestigio a favore dell’alta burocrazia, della magistratura (soprattutto di alcuni pm), delle banche, dei poteri occulti, tra i quali, certamente la ‘ndrangheta.
Oggi, a 50 anni della rivolta, la Calabria non fa più notizia se non per le maxi retate che non sono casuali: sono un raffinato strumento di propaganda che un sistema di governo coloniale e mafioso utilizza per legittimarsi agli occhi dei cittadini. A ogni scuola o ospedale che chiude, a ogni giovane che parte, per ogni paese che si svuota si agita dinanzi agli occhi dell’opinione pubblica nazionale il dramma della ‘ndrangheta che è reale. Ma diventa l’alibi per nascondere il cinismo e gli interessi delle classi dirigenti. La Calabria resta un vulcano dormiente, e non pochi calabresi si augurano un’eruzione democratica che spazzi via l’insopportabile cappa che ha ridotto una terra ribelle in una colonia penale.