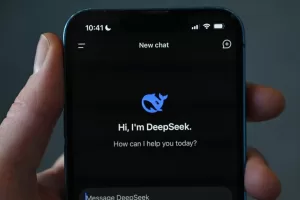L'editoriale
Il fantasma del Grande Vecchio

Ma dov’è il Grande Vecchio? E dov’è il mercato delle informazioni riservate? Li ha evocati entrambi il procuratore antimafia Giovanni Melillo nella sua audizione in Parlamento. Li ha indicati in maniera ancora più esplicita il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, adombrando un verminaio e potenze straniere dietro la fuga di notizie, salvo poi annunciare che l’inchiesta è partita tardivamente e in modo maldestro, e che le tracce per risalire ai mandanti occulti del finanziere infedele sembrano essere state cancellate.
Eppure, a ben vedere, ragionando sugli elementi a disposizione, l’idea di un Grande Vecchio dietro questa clamorosa spy story è implausibile. Perché il Vecchio è Grande se ha un disegno. Lo aveva Licio Gelli, a capo di una loggia massonica che voleva mettere sotto controllo le istituzioni e assoggettarle a un’oligarchia corporativa e occulta. Qual è il disegno di chi spia allo stesso modo Matteo Renzi e Matteo Salvini, Guido Crosetto e Vittorio Colao, Gabriele Gravina e Domenico Arcuri? Sì, a guardar bene, gli spiati del centrodestra sono in proporzione i tre quarti della lista. Ciò conferma che ci sono frange storicamente identificabili del mondo politico-editoriale e del giornalismo aduse a regolare i loro conti con i dossier. Ma i nomi di calciatori, vescovi, manager e imprenditori bastano da soli a escludere l’ipotesi di una Spectre ideologica unica, che con la gogna si proponga di mettere sotto scacco le istituzioni. Una simile organizzazione avrebbe certamente praticato una chirurgia più selettiva, affondando la sua lama nelle profondità della democrazia italiana. E probabilmente non sarebbe incespicata nei compensi, peraltro leciti, del ministro della difesa.
Questi indizi dicono sì che lo spionaggio è ideologicamente orientato, ma in realtà ha nel suo bersaglio una singolare forma di potere.
Quella che si manifesta mediaticamente ed espone i protagonisti al chiacchiericcio del dibattito pubblico. Gli 007 deviati operavano come una sorta di redazione giornalistica che, alla lettura dei quotidiani, si impegni negli approfondimenti. Ma con la metodologia tipica del giornalismo corrente, gli accessi erano a volo d’uccello. Tanto «mostruosi» per numero, come giustamente ha notato Cantone, quanto superficiali. Opera così una Spectre al servizio di poteri occulti o potenze straniere?
E se di mercato si tratta, dove stanno i pagamenti che da sempre qualificano uno scambio illecito? Non ve n’è traccia, almeno a valutare gli elementi filtrati dall’indagine. Pochi, ma non molto diversi da quelli a disposizione degli inquirenti, che – lo ha detto ancora Cantone – sul traffico di notizie riservate sarebbero arrivati male e in ritardo.
Non sappiamo se la strategia di comunicazione dei due procuratori sia stata intenzionale o involontaria. Ma l’idea di un mercato clandestino dello spionaggio e di una cupola che lo controlla rischiano di spostare l’attenzione del dibattito pubblico da ciò che davvero è accaduto. Altrettanto fa l’idea di uno o più finanzieri e magistrati infedeli o incauti, dipinti come mle marce di un paniere altrimenti sano. Mele da gettare nel cestino dell’immondizia per riesporre le mele restanti al centro del tavolo, come se nulla fosse. La sensazione è che la preoccupazione dei due magistrati auditi in Parlamento fosse essenzialmente politica. E avesse il comprensibile obiettivo di difendere il sistema di cui fanno parte o comunque attorno a cui gravitano, cioè quell’infrastruttura giudiziaria, investigativa, burocratica e politica che chiamiamo da quarant’anni Antimafia e che ha assunto nella democrazia italiana compiti crescenti. Perché, se c’è un Grande Vecchio che aleggia attorno a noi, e se pure non possiamo sapere chi sia, sarà bene tenere in piedi una macchina che il Grande Vecchio lo insegue da anni nell’intestino della democrazia.
Ma i tasselli di quest’indagine raccontano tutta un’altra storia. A cominciare da quelli più propriamente investigativi. Lo spionaggio illecito riguarda anzitutto gli accessi abusivi sulle banche dati, cioè non richiesti e legittimati da un magistrato che indaghi su una notizia criminis. Le banche dati sono quello che si dice un mondo. Lo sa chiunque abbia una conoscenza non effimera dell’universo digitale. In questa sconfinata piazza virtuale c’è una mole di atti, contratti, transazioni socialmente rilevanti, maggiore di quanto non ne producano tutte le fabbriche manifatturiere della cosiddetta economia reale. Un filosofo contemporaneo, Maurizio Ferraris, ha coniato il nome di «Documanità» per l’immensa biblioteca di documenti che ci raccontano e che in Italia la burocrazia pubblica archivia in tre distinti registri: il Serpico, acronimo di «Servizio per i contribuenti», che raccoglie le operazioni compiute con carta di credito e bancomat da ogni cittadino; lo Sdi, cioè Sistema di interscambio, con cui l’Agenzia delle Entrate gestisce il flusso generato dall’emissione di fatture elettroniche; il Siva, cioè Sistema informativo valutario, che riguarda le segnalazioni di operazioni sospette (Sos) trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia. Provate ad aggiungere a questi archivi il Registro delle imprese, cioè l’anagrafe economica nazionale, e l’Elenco telefonico nazionale (Etna) e a incrociare i dati in essi contenuti. Avrete l’esatta dimensione di che cosa sia una realtà virtuale dove s’incontrano e si collegano tra loro azioni e soggetti della cui relazione nessuno ha contezza nella vita reale. Volete che in questa sconfinata massa di connessioni non ci sia la traccia di ciò che noi chiamiamo ipotesi di reato?
È questo il non detto dell’intera vicenda. Pensiamo davvero che la polizia giudiziaria si astenga dal cercare da sé i presunti malfattori nelle piazze digitali, allo stesso modo con cui le volanti pattugliano di notte le strade delle città? Pensiamo davvero che gli accessi in questo labirinto di specchi della democrazia avvengano solo su delega e controllo dell’autorità giudiziaria? Se non usciamo da questa pietosa ipocrisia, non verremo mai a capo di ciò che è accaduto. Ci sono strutture investigative che si muovono random sotto la coltre della vita pubblica e raccolgono informazioni, sviluppano sospetti, attivano indagini. La loro pervasività negli ultimi decenni è aumentata esponenzialmente come riflesso del potenziamento tecnologico. E la loro tendenza a muoversi fuori controllo è tanto più forte quanto più si collocano in una burocrazia pubblica cresciuta oltre i compiti e le ragioni per cui è stata pensata e costruita.
Prendere sul serio questa vicenda vuol dire interrogarsi per la prima volta in maniera seria su che cosa è diventata l’Antimafia nella nostra democrazia, se e in che misura ha adempiuto al suo compito, qual è oggi la sua funzione e quali effetti collaterali produce per la società, che rapporto ha con la crisi della giustizia italiana e quali sono i vantaggi, o piuttosto i rischi, di una sua ulteriore espansione. Una risposta a queste domande è esattamente ciò che i discorsi di Melillo e Cantone in Parlamento rischiano di eludere. Ma è ciò che ha proposto un giurista e intellettuale indipendente come Sabino Cassese, e che noi intendiamo qui rilanciare.
Lo scandalo di questi giorni racconta che il Grande Vecchio altro non è che l’implosione di un sistema, pensato e costruito a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso per combattere un’organizzazione piramidale, innervata nella società, capace di seminare impunemente violenza e morte, un anti-Stato dotato di una sua soggettività politica e di un’autorità avvertita come una minaccia nella comunità, un’interfaccia economica in grado a suo modo di produrre ricchezza criminale e distribuire assistenza, una cultura concorrente, e talvolta egemone, rispetto a quella civile, dotata di miti fondativi, rituali iniziatici e pseudo valori assistiti da una retorica.
Nel frattempo la cosiddetta guerra di mafia è finita, la minaccia della criminalità è evoluta in qualcosa di molto diverso dalla cupola di Totò Riina, ma il sistema di contrasto messo in piedi ha continuato a crescere nella burocrazia pubblica seguendo un disegno inattuale e accentuando i limiti che già erano emersi al tempo di Giovanni Falcone. L’Antimafia oggi nella democrazia italiana è un carrozzone autoreferenziale e, per certi versi parassitario, che attraversa la giustizia, la politica, gli apparati dello Stato, le libere professioni e perfino il volontariato, che drena e distribuisce un’immensa quota di risorse pubbliche e private, e che utilizza una retorica emergenziale per legittimare e giustificare la sua ragion d’essere. Con l’aggiunta di un limite che, da un punto di vista strettamente investigativo, rappresenta un marchio d’origine: la procura nazionale non ha un effettivo potere di coordinamento sull’attività delle singole procure.
Il procuratore agisce come un rappresentante istituzionale, accomoda i conflitti che puntualmente sorgono tra i singoli centri territoriali di investigazione, ma non si ricorda negli ultimi anni una sola grande inchiesta che abbia visto protagonista la Direzione nazionale antimafia. Non è un caso che Melillo si dolga in Parlamento con la procura di Roma, poiché la prima comunicazione di un’inchiesta sugli accessi abusivi dai computer di «Via Giulia» non giunge a lui, ma solo a uno dei magistrati del suo ufficio, Antonio Laudati, che si guarda bene dall’informare subito il procuratore. Dietro questo deficit informativo c’è l’imprinting di un’azione penale che vede ancora le singole procure muoversi in totale autonomia.
Che fa una struttura inquisitoria tanto potenzialmente potente, quanto sostanzialmente improduttiva, perché non direttamente coinvolta nelle investigazioni? La risposta ce la dà uno smanettatore professionale come il luogotenente della Finanza Pasquale Striano, funzionario di fiducia dei vertici della Direzione nazionale antimafia fino ai giorni dello scandalo. Trasforma l’ufficio in una sorta di servizio segreto «a la page». S’interfaccia con altri poteri della democrazia mediatica e fornisce informazioni a richiesta. Tra i suoi clienti ci sono ovviamente giornalisti, ma non solo. Perché nel circuito ristretto di relazioni che fa la microfisica del potere capitolino si muovono faccendieri e portatori di interessi più diversi, che vanno dalla politica all’impresa, dallo spettacolo allo sport. E c’è soprattutto il ruolo crescente degli apparati di polizia giudiziaria, a cui la tecnologia negli ultimi dieci anni ha messo in mano superpoteri. In quanto tecnocrazie, questi apparati non rispondono a una finalità propriamente ideologia, ma piuttosto a un’ideologia del potere in quanto tale.
Come finirà? Siamo pronti a scommettere che l’esito di questa vicenda sarà un patteggiamento, secondo uno schema che ormai si ripete da anni. Nel 2017 gli atti riservati d’indagine della procura di Roma contro il cosiddetto sistema Messina, che coinvolgeva magistrati, imprenditori e i due avvocati faccendieri Amara e Calafiori, finiscono nelle mani degli indagati prima ancora di essere depositati. La fonte della fuga di notizie è un oscuro carabiniere, Francesco Loreto Sarcina, spia autodidatta che, per arrotondare la pensione, ha deciso di mettere a frutto le sue conoscenze nel sottobosco investigativo, che ha frequentato per decenni come sottufficiale dei Servizi segreti. Patteggerà la pena senza che nessuno dei suoi clienti sarà mai coinvolto da un’indagine. Due anni dopo, le intercettazioni di Luca Palamara, con cui si sorveglia prima e si ribalta poi la maggioranza del Csm, transitano sottotraccia in un reticolo di rapporti paraistituzionali che coinvolgono strutture investigative, procure, correnti della magistratura e vertici dello Stato, per cadere poi a pioggia nelle pagine dei giornali e scatenare lo tsunami in un organo di rilevanza costituzionale. Uno degli spifferi accertati è il cancelliere perugino Raffaele Guadagno, le cui opache relazioni con i magistrati della procura umbra apprendiamo in questi giorni dalle cronache di Giacomo Amadori su «La Verità». Anche Guadagno ha patteggiato una risibile pena e c’è da giurare che l’inchiesta sulla fuga di notizie che ha terremotato cinque anni fa la giustizia italiana si fermerà a lui.
Ma se il sistema della burocrazia investigativa cauterizza le sue falle per evitare il collasso, lasciando però che il pus cresca all’interno dell’organismo, la democrazia può fare di più. E iniziare a discutere di un fenomeno comune a tutte le vicende qui narrate: potremmo definirlo una diplopia del potere, cioè uno strabismo per cui il potere non si esercita solo all’interno delle istituzioni, ma anche attorno a queste, in forme meno visibili quando non del tutto occulte. Con l’effetto di svuotare la sostanza della loro dialettica interna e di degradare i loro processi formali. Questa discussione ha un punto di partenza ineludibile, e cioè la domanda su che cosa sia diventata la polizia giudiziaria negli ultimi anni, a partire da quella più potente dell’Antimafia. Ci tocca chiedercelo e tentare una risposta, senza più reticenze, timori reverenziali o preoccupazione di compiacere chi vuole convincerci della sua intangibile indispensabilità.
Chiederselo non vuol dire azzoppare la capacità investigativa delle procure e la strategia di prevenzione che, nella lotta al crimine organizzato e al terrorismo, si rivela indispensabile. Ma vuol dire sorvegliare il rischio che, in nome della prevenzione, le investigazioni impongano alla democrazia un racconto del sospetto, di cui lo scandalo dei dossier pare un sinistro esempio.
Coinvolgere il Parlamento sui limiti dei poteri eccezionali che la tecnologia e le nostre leggi hanno consegnato ad apparati della sicurezza sarebbe una doverosa risposta politica, di fronte alla gravità di ciò che è sotto i nostri occhi. Non si tratta di cancellare l’Antimafia, ma di smettere di considerarla un totem. Purtroppo il governo ha silenziato ancora una volta il guardasigilli Carlo Nordio, che proponeva una commissione parlamentare sui fatti di Perugia, e ha lasciato che a discutere degli eccessi dell’Antimafia sia la Commissione parlamentare Antimafia. Perché sa che il miglior modo per proteggersi dalle incursioni giudiziarie e far sì che il grande incendio deflagri dov’è scoppiato. Contro certi poteri, si sa, la politica non ha che strategie difensive.
© Riproduzione riservata