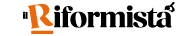Cosa ci ispira la osservazione del cielo, la contemplazione di un cosmo solcato continuamente da razzi, sonde e spedizioni? È vero che Leopardi per pensare l’infinito era costretto a immaginarselo, aveva cioè bisogno di una siepe (qualsiasi orizzonte marino ne sarebbe stato solo un modesto surrogato), insomma di una veduta ristretta. Eppure se guardiamo la volta celeste non abbiamo più bisogno di siepi: non c’è forse altra rappresentazione più tangibile, vivida dell’infinito, del suo essere – leopardianamente – «arcano mirabile e spaventoso». Ma dopo i viaggi spaziali, a partire dal dopoguerra è cambiato il modo in cui gli scrittori guardano il cielo?
La studiosa Alessandra Grandelis ha costruito un saggio documentato e affascinante – Il telescopio della letteratura (Bompiani) – sullo sguardo della nostra letteratura recente verso lo spazio, soprattutto nel periodo che va dal primo lancio dello Sputnik (1957) all’allunaggio (1969) e all’ultima spedizione lunare sovietica (1976). Da Landolfi e Buzzati a Consolo, Volponi, Morselli e Rodari, passando per Moravia e Pasolini, Primo Levi e Calvino, etc. Gli scrittori si confrontano con la modernità tecnica – riflessa sia dai voli spaziali che in Italia dal boom industriale – attraverso un mix di curiosità e preoccupazione, meraviglia e spavento (come ben delineato dalla definizione di Leopardi). Innumerevoli gli spunti. Né la studiosa si limita all’Italia: non solo perché cita il primo racconto di fantascienza, che è di Keplero (Il sogno, 1609: citato in una poesia di Sergio Solmi, e da lui proposto al regista Herzog per farne un film), ma perché ci segnala un articolo di Blanchot in cui polemizzando indirettamente con posizioni alla Heidegger ribalta ogni preoccupazione umanistica: forse la tecnica – e in modo spettacolare con le conquiste spaziali – ci stacca dalla terra, ma ciò è da vedere non tanto come sradicamento quanto come emancipazione, qualcosa che ci libera per sempre dall’ansia del possesso (certo, a patto che ci prendiamo cura della parola, coraggiosa nel rivendicare che la verità è nomade). Altro che radici! Fortunatamente non siamo radicati nemmeno sulla Terra. Mi soffermo però sul capitolo dedicato a Primo Levi e Calvino, che, sia pure in modi diversi, la scienza la conoscono meglio degli altri scrittori.
Il primo, chimico, lettore avido di riviste scientifiche specialistiche, oscilla tra il terrore di fronte all’aumento dell’entropia e fascinazione per la tecnologia umana. Viene attratto angosciosamente dai buchi neri (finiti in La ricerca delle radici, del 1981, sotto il titolo “Siamo soli”), ovvero dalla complessità inquietante di un universo ostile, violento, popolato da mostri celesti, da cui «emana disprezzata gravezza» mentre «tutti noi semi umani viviamo e moriamo per nulla» (corrispettivo del “buco nero” di Auschwitz inghiottitoio di donne, bambini e uomini). D’altra parte osservando gli astronauti durante il viaggio – e interpretando i voli spaziali come espressione di un istinto umano quasi biologico – vorrebbe essere un pesce volante per vivere nella realtà quanto ha vissuto solo in sogno: il volo incarna il bisogno di librarsi leggero, di liberarsi della corporeità, dell’esistenza stessa. In ultima analisi, proprio come per Blanchot, si riafferma la fiducia nella scrittura, memoria anche dell’indicibile, e perciò elemento di vita, come il carbonio del Sistema periodico (1975).
In un racconto della favola moderna di Marcovaldo (scritta negli anni ‘50) di Italo Calvino – nato in una famiglia di scienziati – i bambini confondono la Luna con un oggetto artificiale, pubblicitario, da poter spegnere con il lancio di una fionda. In un altro racconto dello stesso periodo, dopo il lancio dello Sputnik, lo scrittore immagina una tribù africana, incalzata da una multinazionale avida di profitti, che guarda il cielo e spera nei missili che lo solcano, segnali della Grande Profezia che porterà all’abbondanza nei campi coltivati. Più tardi, nel 1967, prima dell’allunaggio, ritrae nelle Cosmicomiche una Luna minacciosa che si avvicina alla Terra. E poi ancora nel 1975 prevale decisamente lo scetticismo verso le magnifiche sorti cosmonautiche: ci mostrerà proprio la «tragedia della scienza moderna», asservita all’industria, con Von Braun visto come «manager-tecnocrate-stratega del nostro minaccioso futuro». Tra i poeti e gli scienziati sembra momentaneamente scegliere questi ultimi, dando valore alla conoscenza che pure filtra dalle «immagini lattiginose e bucherellate» provenienti dal cosmo. Infine nell’opera conclusiva, Palomar, il suo protagonista riflette sull’universo: è ordinato o caotico? Ne viene fuori l’immagine di una complessità irriducibile, di un “sapere instabile e contraddittorio”, di una verità frantumata, parziale, ambigua, che solo la letteratura potrà restituirci.
Ma un vero poemetto lunare lo dobbiamo a Andrea Zanzotto, inesauribile e giocoso sperimentatore del ‘900, Gli Sguardi i Fatti e Senhal (1969), dove una voce principale femminile dialoga con 59 interlocutori, e dove il rientro dell’Apollo 11 viene riprodotto con suoni onomatopeici: «Flash crash splash down / flash e splash nella pozza dello specchio». Il poeta rappresenta una Luna violata – «lo so che ti hanno presa a coltellate» – e tradotta in un mito degradato (definita “Marogna”, termine dialettale per mucchio di sassi). Anche lui come Calvino è scettico verso una modernità insofferente dei limiti e incurante dei destini generali, persa in un delirio di onnipotenza. La società non è all’altezza della sua stessa tecnologia dunque la usa male: «In questo progresso scorsoio/ non so se vengo ingoiato/ o ingoio». In fondo, l’esperienza del Covid, pur muovendosi in spazi tutt’altro che celesti, non ci ha mostrato l’illusorietà di qualsiasi promessa di controllo assoluto (fatta dalla tecnica), i limiti invalicabili del nostro povero sapere, e insieme però anche la insostituibilità di questo stesso sapere?