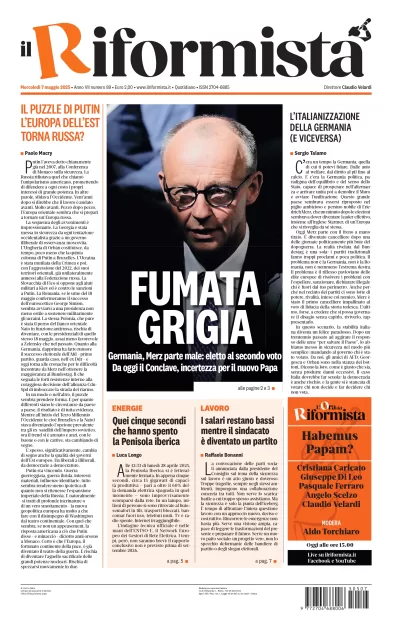Le sfide dell'Europa
Intervista a Jean Paul Fitoussi: “Basta paradisi fiscali in Europa, non c’è crescita senza uguaglianza”

Lo stato dell’Unione europea. La sfida per una nuova governance. Il Riformista ne discute con uno dei più autorevoli economisti europei: Jean Paul Fitoussi, Professore emerito all’Institut d’Etudes Politiques di Parigi e alla Luiss di Roma. È attualmente direttore di ricerca all’Observatoire francois des conjonctures economiques, istituto di ricerca economica e previsione. È autore di numerose opere tra cui La misura sbagliata delle nostre vite. Perché il PIL non basta più per valutare benessere e progresso sociale (Etas 2010 e 2013), scritto con Joseph Stiglitz e Amartya Sen; Il teorema del lampione o come mettere fine alla sofferenza sociale (Einaudi 2013) e La neolingua dell’economia. Ovvero come dire a un malato che è in buona salute (Einaudi 2019).
«L’equità sociale deve andare insieme all’economia fiscale. Se le imprese realizzano profitti è grazie alla qualità delle nostre infrastrutture, perciò mi pare il minimo che diano il loro contributo». Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Layen nel suo discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo. Qual è la sua opinione in merito?
Che vuole che le dica, quello evocato dalla signora von der Leyen è un problema vecchio come il mondo: come trovare un sistema fiscale equilibrato, sapendo che gli attori hanno benefici diversi dalle attività dello Stato. Le faccio un esempio: le imprese traggono benefici dalla rete di trasporto e in generale da tutte le reti infrastrutturali. Fanno guadagnare un sacco di tempo alle imprese e abbassare i loro costi. E traggono anche beneficio dalla qualità della formazione della gente. Se la gente è ben formata allora la produttività dell’impresa sarà molto più alta. E benefici si determinano anche da un sistema sanitario efficiente. La gente che gode di buona salute lavorerà meglio. Tutte le spese pubbliche che riguardano sia i sistemi nazionali di educazione, di sanità, le spese sociali, le infrastrutture producono benefici alle imprese facendo diminuire il loro costo e dunque facendo aumentare la loro produttività…
Cosa non va in questo schema, professor Fitoussi?
È la concorrenza micidiale tra le imprese nell’ambito dell’Unione europea, all’interno della quale ci sono tanti paradisi fiscali. Come si può accettare questo? Le cose vanno indicate per quello che sono: coloro che usufruiscono di questi paradisi fiscali, sono dei ladri. Ladri di denaro pubblico sottratto al miglioramento di quelle condizioni stesse che poi determinano i benefici per le imprese stesse. È un circolo vizioso che deve essere spezzato se si vuole dare concretezza alle buone intenzioni professate dalla presidente della Commissione europea. E la cosa è aggravata dal fatto che questi ladri godono della protezione di Stati che fanno parte dell’Unione. Questa si chiama concorrenza sleale. Vi sono spese pubbliche che favoriscono le imprese e dunque le imprese devono farsene carico in quota parte, contribuendo a finanziarle. Quando le imprese approfittano della concorrenza fiscale, beh, questo è un modo di non pagare. E questa è una ingiustizia. Perché se loro, che pure ne sono beneficiari, non le pagano, vuol dire che a pagarle saranno gli altri.
Sempre nel suo discorso sullo stato dell’Unione, la presidente della Commissione europea ha affermato, cito testualmente: «Dobbiamo riflettere su come la crisi ha colpito la nostra economia e per questo la Commissione rilancerà la discussione sulla governance economica». Chiedo a lei, uno dei massimi esperti in materia: su che basi dovrebbe poggiare questa governance economica?
Per me la cosa è chiara da tanti anni: c’è bisogno di uno Stato imprenditore. Uno Stato che assume la sua responsabilità. Perché la crisi pandemica ha dimostrato, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che c’è un ruolo importantissimo per lo Stato. Lo “Stato-imprenditore”. L’Unione europea è ancora molto lontana da questo orizzonte. Di fronte alla tragedia del Covid-19 l’Europa ha dimostrato, regole o no, di sapersi assumere le proprie responsabilità quando in gioco è la vita di migliaia di persone. È un problema di volontà politica e non di regole, trattati, pastoie burocratiche… Il grande tema è dunque quello del ruolo dello Stato. Un ruolo marginalizzato, demonizzato, nel lungo ciclo neoliberista. In economia, lo Stato era visto come “invasore” di campi altrui. C’è un ruolo per lo Stato nazionale e c’è un ruolo, non meno importante, per uno Stato federale europeo. Per venire alla sua domanda: un buon sistema di governance necessita di un responsabile che prenda decisioni non mettendoci troppo tempo. Perché in economia, come in politica, il fattore tempo è un elemento decisivo. È il contrario di ciò che oggi è e fa l’Unione Europea: non c’è un responsabile e per prendere una decisione bisogna passare per interminabili discussioni che possono durare anni. Occorre riflettere su questo. So bene che è un problema difficile, anche perché non si sa se la gente voglia davvero una Europa politica o no. Qui ribadisco quanto ebbi modo di dire in una nostra precedente conversazione: io sono convinto, ancor più alla luce di una crisi, quella pandemica -che non ha eguali, quanto a gravità, dal secondo dopoguerra ad oggi – che i diritti sociali sono elementi fondamentali del welfare, del benessere dei cittadini, delle popolazioni. Se non agiamo in tempo e con forza su questo versante, allora l’Europa avrà scritto un nuovo capitolo del libro enciclopedico delle occasioni perdute. Perdute, come in Afghanistan…
Un’occasione persa, perché?
Perché l’Europa non ha saputo, potuto, voluto esercitare un ruolo che fosse altro da un misero accodamento agli Stati Uniti. Essere alleati non significa essere vassalli, degli eterni “signorsì”. Ancora una volta l’Europa ha mostrato una inquietante carenza di linea politica e anche di leadership.
Professor Fitoussi, molto si discute attorno alla questione della “crescita”…
Anche qui: la crescita, come il cambiamento, non è qualcosa di oggettivo, di neutro. Una crescita che favorisca unicamente un piccolissimo numero non ci interessa affatto come obiettivo sociale, come obiettivo da perseguire nei nostri Paesi. Cerchiamo al contrario una crescita che garantisca l’uguaglianza dei cittadini di fronte al futuro. Crescita e benessere sociale o marciano assieme o l’una, la crescita per pochi, annienta il benessere sociale per i più. In questo senso, un banco di prova decisivo riguarda le politiche per l’occupazione. Il che ci rimanda alla necessità di uno Stato imprenditore che è poi il portato di una lezione che nei decenni di iper rigorismo avremmo dovuto imparare e far tesoro, e cioè non esiste virtù in economia: la corsa verso il rigore di bilancio può trasformarsi, come è stato, in una corsa sfrenata verso la depressione economica. L’iper austerità ha provocato devastazioni sociali alle quali non sarà facile porre rimedio. Di certo, non basteranno semplici ritocchi o misure emergenziali. Impariamo dalla storia: l’Europa ha bisogno di un suo “New Deal” che, sul modello rooseveltiano, faccia leva sull’intervento dello Stato in settori strategici dell’economia. Altro che “invasione di campo”. Oggi la sfida è ricostruire, su basi e idee nuove, un “campo” diventato impraticabile.
A proposito del riflettere sui meccanismi di decisione in ambito Ue. Non crede che per andare nella direzione da lei auspicata ci sia bisogno anche di superare il diritto di veto e il dovere di prendere decisioni su temi fondamentali all’unanimità?
L’obbligo dell’unanimità è il modo di togliere ad ognuno l’elemento federale. La definizione di una maggioranza sancirebbe l’esistenza una forma strutturata di federalismo europeo. La decisione sarebbe molto più facile e non richiederebbe dei ricatti reciproci o una compravendita di voti.
In ultimo vorrei passare da Bruxelles a Parigi. La corsa all’Eliseo si è arricchita di due nuove contendenti. A poche ore di distanza l’una dall’altra, la sindaca socialista di Parigi Anne Hidalgo e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, hanno annunciato le rispettive discese in campo per le presidenziali francesi in programma per aprile 2022. Due candidature che ampliano con nomi di peso la rosa degli attuali partecipanti alle elezioni, già formata dal presidente in carica Emmanuel Macron e dall’ex negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier. Lei come vede queste nuove scese in campo?
Le vedo male. Si avanzano candidature senza indicare i programmi, le priorità che stanno dietro quei nomi. L’unico programma che ci è dato conoscere è quello di Macron, ma ciò non significa che quello dell’attuale presidente sia un buon programma. Ma chi conosce il programma di Barnier o quello della Hidalgo? Siamo a pochi mesi dalle elezioni e ancora non sappiamo quali saranno i temi a confronto. Quello che sappiamo che a contendersi l’Eliseo non saranno statisti. Ê un po’ triste che un Paese come la Francia non trovi persone con un senso politico chiaro, ben formata, per guidare il Paese. Ma questo, a ben vedere, non è un problema solo francese.
© Riproduzione riservata