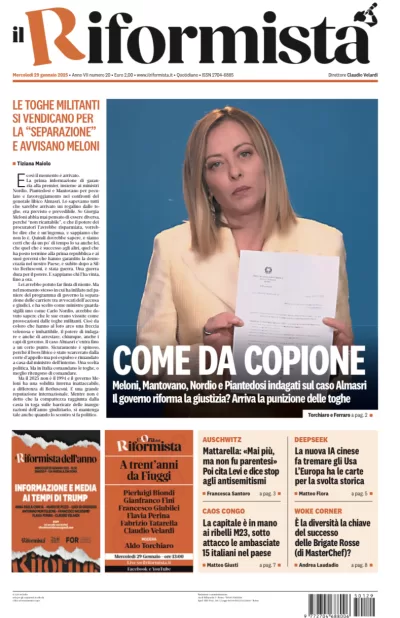Protestano storici (e riformisti)
La strana amnesia su Matteotti che nessuno chiama “socialista”: le acrobazie di Meloni, Fontana e Gentile

Non è stata una distrazione, dicono in coro. Se durante la giornata di commemorazione di Giacomo Matteotti a Montecitorio nessuno ha citato il suo essere socialista, non è stato per dimenticanza. Ha parlato il professor Emilio Gentile. Poi il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Quindi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Nessuno ha pronunciato, in associazione al deputato martirizzato dallo squadrismo fascista, le parole “Socialista”, “riformista”, “Psi”. O meglio: “Psu”, quel Partito socialista unitario che di Giacomo Matteotti era la casa. Di più: il partito di cui, su indicazione di Filippo Turati, Matteotti era segretario.
Per descriverlo senza usare la definizione corretta hanno fatto ricorso a tutte le acrobazie del vocabolario. Ne hanno ricordato l’essere stato antifascista. Uomo di sinistra. “Uomo libero”, lo ha chiamato Meloni. Socialista no, non lo hanno detto. Lo storico del riformismo italiano Zeffiro Ciuffoletti, ordinario di storia contemporanea all’Università di Firenze, lo segnala: “Da un po’ di tempo è come se i socialisti non ci fossero mai stati, in Italia. Un paradosso, per chi ama la storia politica. D’altronde è il partito che alla fine della prima Repubblica è stato distrutto, annientato”. Il suo ritratto rimette le parole a posto: “Matteotti era un riformista intransigente. Aderì a una idea di socialismo gradualista, riformista. La parola socialista era tutto per lui: era il leader del Psu che Turati aveva scelto (perché lui, il segretario non lo voleva fare) e quindi incarnava il filone centrale del socialismo italiano”.
E dirlo antifascista non basta. “C’era molta contrapposizione in quegli anni – sottolinea ancora il professor Ciuffoletti – che vedevano nel biennio rosso i socialisti massimalisti e poi i comunisti contrastare lo Stato liberale, considerato un vuoto a perdere della borghesia. Da abbattere con la violenza. I soviet erano lo strumento con cui i comunisti organizzavano gli operai in vista della rivoluzione armata e Matteotti si opponeva a quella visione. Con intelligenza. Perché sapeva che a quegli eccessi sarebbe seguita una terribile reazione”. E così fu. Matteotti, oggi preso a simbolo della sinistra, era in quel momento avversato da Gramsci e Togliatti. “Lo consideravano un poveraccio. E considerarono la sua morte come la dimostrazione delle loro ragioni. Il vero nodo della storia italiana è sempre quello: c’era chi guardava al modello russo e chi alla democrazia liberale”.
Tra questi ultimi, i riformisti. “Quello che faceva arrabbiare di più Mussolini era Matteotti, non i comunisti. Perché se loro erano funzionali allo spauracchio che serviva al regime, lui era più insidioso. Puntuale, informato. Anche su certi affari dei dirigenti fascisti, che temevano i suoi dossier”. Emerge una figura prismatica, particolarmente indigesta per la quasi totalità del Parlamento di allora. Anche un intellettuale come Riccardo Nencini, già senatore socialista e saggista – che dopo aver scritto “Solo” gli ha dedicato anche l’ultimo “Muoio per te”, uscito in questi giorni con Mondadori – è indignato per come una certa ipocrisia tratta, rivisita e riscrive la storia. “Non lo chiamano socialista perché altrimenti dovrebbero ricordare le ragioni per cui lo era”. Invise a molti. “Lui è stato il primo a lanciare l’idea, per bloccare il fascismo nascente (ai tempi del secondo governo Facta, nell’estate del ’22) di formare un governo di coalizione di centrosinistra che doveva includere i socialisti riformisti, i popolari di Sturzo, i liberali di Amendola, i repubblicani e i sardisti”. Un tentativo riformista che ne segnò, in nuce, la condanna.
“Il destino del riformismo è sempre stato quello di essere patrimonio di una parte intellettuale, mai di massa. Una parola tabù per tanti”. Perché viene ucciso proprio Matteotti e non un leader comunista? “Il suo essere social-riformista è alla radice dell’isolamento in cui era stato messo. Ed è la ragione per la quale Gramsci, davanti al cadavere di Matteotti, lo definisce ‘Pellegrino del nulla’, con parole sprezzanti fino a dopo il ritrovamento del corpo”. Del celebrato martire del riformismo i comunisti dissero: “Aveva sbagliato prospettiva politica”. Mussolini, che aveva riconosciuto l’Urss per primo, in Europa, aveva stipulato una sorta di patto di non aggressione con i massimi rappresentati di Mosca in Italia, che rispetterà ancora per un po’. “Mussolini – ricorda Nencini – conosceva bene il Partito socialista nel quale era cresciuto. Sapeva che erano i più pericolosi per lui, erano gli unici che con le capacità di Matteotti, che parlava con tutti i settori del Paese, ne potevano minare il potere. Aveva bisogno del rumore dei comunisti e di silenziare i socialisti. In egual misura”.
Anche perché Matteotti vedeva bene il pericolo delle due ali estreme: “Fu un antifascista rigoroso e un antibolscevico intransigente”, conclude il suo ritratto Nencini. Ciuffoletti aggiunge un elemento: “Fu antesignano del centrosinistra moderato ma anche del federalismo europeo. Diceva già più di un secolo fa che l’unica garanzia per avere una pace duratura sarebbe stata quella di unire l’Europa in uno Stato federale”. Un viaggiatore del tempo indigesto per gli estremisti di destra e di sinistra. “Omettere di chiamarlo socialista è una damnatio memoriae di stampo staliniano”, alza i toni Fabrizio Cicchitto, che del Psi è stato a lungo al vertice. Come Biagio Marzo, che si rammarica: “Anche da morti i socialisti in Italia continuano ad essere trattati come reietti”.
© Riproduzione riservata