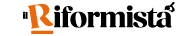In un vecchio saggio del 1942 il laico Benedetto Croce sosteneva che “non possiamo non dirci cristiani”. J. M. Coetzee, al quale nel 2003 l’Accademia Svedese assegnò il premio Nobel per la Letteratura, sembra evocare tale dichiarazione nella sua ultima trilogia romanzesca, tradotta da Maria Baiocchi per Einaudi e accolta non senza qualche perplessità, per dire un eufemismo, dalla critica di mezzo mondo: L’infanzia di Gesù (2013), I giorni di scuola di Gesù (2016) e, appena uscito, La morte di Gesù (2020). I titoli, inequivocabili, vanno considerate piste interpretative che, se da una parte possono illuminare il lettore, dall’altra rischiano di confonderlo.
Nel caso in cui ci limitassimo a recepire la trama senza l’indicazione precettistica imposta dall’intestazione, saremmo di fronte alla storia di un orfano, uno dei tanti bambini costretti a fuggire dalle guerre contemporanee che si ritrovano fra noi, privi di sostegno e accompagnamento, alla maniera di bocce impazzite uscite dal rettangolo di gioco e finite nell’erba alta: non ci chiederemmo nient’altro, ci basterebbe questo. Del resto la suggestione evangelica apre una risonanza simbolica talmente forte che sarebbe sbagliato e troppo comodo eludere. L’idea stessa di paternità e maternità non può prescindere, secondo lo schema culturale occidentale, dalla stalla di Betlemme. In tale prospettiva lo scrittore sudafricano ha composto un consapevole e malizioso palinsesto denso di echi ed assonanze, lasciando a chi legge il compito di scegliere la via per uscire dal labirinto.
Nel primo tomo Coetzee racconta di Simòn, giunto nella città di Novilla insieme a David, il bambino di cinque anni che ha incontrato in un campo profughi. L’obiettivo dell’uomo, dichiarato sin dall’inizio, è quello di trovare la madre del piccolo di cui ha deciso di prendersi cura. Dopo un paio di tentativi falliti, l’impresa riesce, anche se Inés, «questa donna un po’ ottusa, priva di senso dell’umorismo, tutta incontri di tennis e cocktail al tramonto», non assomiglia alla persona giusta.
Lei però s’affeziona al ragazzino che dimostra di essere davvero unico: fa strani discorsi filosofici sulle stelle e sui numeri, impara non si sa come a leggere il Don Chisciotte, eppure non va tanto bene a scuola e potrebbe addirittura essere trasferito a Punto Arenas, una temuta sezione per alunni speciali. Nella memoria del lettore restano incisi gli ambienti sociali della città che ospita i rifugiati, la caparbia volontà da cui è pervaso il padre, l’amore immaturo e tuttavia profondo della madre, la personalità stramba e irripetibile del giovane protagonista, il quale, dopo un incantesimo che avrebbe dovuto renderlo invisibile, rischia persino la cecità.
Nel secondo tomo i genitori si occupano della formazione di David iscrivendolo in una scuola privata: lui, imprevedibilmente, si appassiona alla danza classica ma resta coinvolto nell’omicidio della direttrice, Ana Magdalena, del quale si dichiara responsabile Dmitri, custode del museo posto al piano inferiore della scuola: individuo losco e apparentemente inaffidabile, che viene posto agli arresti e in seguito considerato un malato mentale. David si sta avviando ormai a diventare adolescente: i suoi rapporti con i parenti acquisiti sono quantomeno problematici e irrisolti. E così restano anche nel terzo romanzo in cui il ragazzo, dopo essersi appassionato al gioco del calcio nella squadra di un orfanotrofio, polo attrattivo evidentemente irresistibile, finisce all’ospedale a causa di un morbo misterioso che prima lo paralizza, poi lo uccide, impedendogli di consegnare la comunicazione a cui tanto teneva. A meno che, sostiene Dmitri rivolto a Simon, le cose che David aveva da dire non fossero incarnate da lui stesso: «Il messaggero era il messaggio: un pensiero abbagliante, non sei d’accordo?».
Quest’opera di magistrale fattura, che poggia le sue basi sulla prosa scarnificata, tesa ad estendere il tempo morto delle descrizioni e dei dialoghi in un continuo, virtuosistico rimando del nucleo narrativo, è percorsa da molte inquietudini novecentesche: il groviglio delle identità, il peso del futuro, la rimozione delle radici, il timore e il desiderio di diventare padri e madri. Come se di tutta la libertà che abbiamo cercato e di cui oggi possiamo disporre, non sapessimo più cosa fare.
La trilogia su Gesù composta da Coetzee si potrebbe leggere anche alla maniera di un romanzo sull’educazione: forse non si è mai discusso così tanto dei ruoli formativi che dovrebbero avere le generazioni adulte rispetto a quelle più giovani, a dimostrazione della crisi etica che sta attraversando la nostra epoca. Il piccolo David, nucleo ancestrale da cui ognuno di noi idealmente discende, avanza convinto verso l’ignoto, quasi fosse lui, in un rovesciamento paradossale, a dover rassicurare i suoi genitori adottivi dettando per loro i tempi e i modi attraverso i quali ricostruire le sagome oggi sbilenche della più straordinaria fra tutte le invenzioni umane: la famiglia.