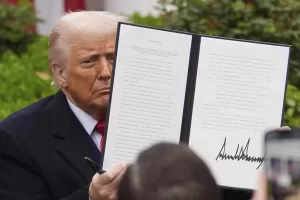Ecco come bisogna farle
Le riforme vanno fatte con progetti seri e strategie affidabili

Quella del programma nazionale di riforma è un’idea che nasce dalla strategia di Lisbona. Dal 2011 il programma nazionale confluisce, in Italia, nel Documento annuale di economia e finanza (Def), preparato dal Dipartimento del tesoro e dal Dipartimento delle politiche europee, quindi dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Per le prossime tappe, la Commissione europea ha preparato il 20 maggio raccomandazioni per l’Italia, approvate dal Consiglio europeo il 20 luglio. Con i fondi speciali approvati a seguito della pandemia, allo scopo di rilanciare tra l’altro le economie nazionali, la Commissione europea si accinge a preparare linee guida e veri e propri modelli, per la messa a punto dei piani nazionali e per la loro valutazione. Poi, i governi nazionali debbono preparare il programma, che sarà esaminato dalla Commissione europea e approvato dal Consiglio a maggioranza qualificata. I prossimi passi sono: invio a Bruxelles entro il 15 ottobre, valutazione entro due mesi da parte della Commissione, approvazione entro un mese da parte del Consiglio. Da anni diciamo che il Paese ha bisogno di riforme. Non si sono fatte per tre motivi di fondo.
Il primo riguarda la diversità di orizzonti temporali tra governi e riforme. I primi sono di breve durata, le seconde richiedono media o lunga durata. Nessun politico è disposto a pagare i costi per la ideazione e la realizzazione di riforme di cui beneficeranno i suoi successori o avversari.
Il secondo motivo delle mancate riforme dipende dalla asimmetria tra chi ne paga i costi e chi ne gode i benefici. Se i primi sono in posizione più forte o se i secondi non hanno voce, le riforme non partono.
Il terzo motivo riguarda la sordità della società civile, disposta a lamentarsi, ma non a impegnarsi per le riforme. Ne deriva che l’unico attore rimane il governo, poco interessato a riformare – come si è detto – per la sua breve durata.
Ora, però, è l’Unione europea che chiede di fare le riforme, e mette a disposizione risorse a questo scopo. Quindi, i riformisti potrebbero cominciare a sperare. Ma come procedere? Come evitare gli errori fatti finora?
Il primo errore da evitare è di procedere come nel passato anche recente, con i provvedimenti dai nomi altisonanti (Cura Italia, Rilancio, Semplificazioni) che contengono però un “bric-à-brac” di misure. I ministeri hanno aperto i loro cassetti e hanno riempito questi provvedimenti di ogni sorta di vecchia e nuova idea (Francesco Giavazzi, sul Corriere della sera, ha osservato che tra i 600 progetti inviati dai ministeri per il nuovo Programma non c’è quasi nessuna vera riforma). Oppure raccogliendo “desiderata” da questa o quella organizzazione di categoria o gruppo di interesse. Chi più aveva, più ci metteva. Il risultato è un disordinato elenco del telefono. Valerio Di Porto e Fabio Pammolli, in un articolo sul Foglio del 2 settembre scorso, l’hanno definita la “tecnica dell’inscatolamento”. Ha un precedente illustre nella preparazione delle minestre del venerdì – raccontata nel “Giornalino di Gian Burrasca” – che era fatta con la risciacquatura dei piatti di tutta la settimana precedente. Per evitare questo errore, occorre avere una strategia e fare quello che gli anglosassoni chiamano “goal setting”: sapere quali sono le priorità del Paese, scegliere quelle principali, redigere progetti, calcolare tempi, costi, protagonisti, beneficiari, scadenze.
Il secondo errore da evitare è quello di ritenere che un programma di riforme si rediga solo ricorrendo all’arte della mediazione. Non c’è politico che non operi mediazioni e compromessi. Moro era un maestro in materia. Ma Moro sapeva dove voleva arrivare, aveva ben chiaro in mente l’obiettivo che voleva raggiungere, anche se poi lo perseguiva deviando, aggiustando, cedendo su alcuni punti. La mediazione per la mera sopravvivenza è altra cosa.
Il terzo errore da evitare è ritenere che, scelte le priorità, ci si possa fermare. Le priorità vanno articolate in progetti. Ne vanno indicati i tempi di realizzazione. Ne vanno previsti benefici e costi. Va indicato come possa correggersi la rotta lungo la strada, in caso di difficoltà impreviste. Insomma, non è un’opera facile. È in quest’opera di precisazione che va stabilito un contatto con beneficiari prevedibili e strumenti necessari, che non possono esser esclusi, debbono partecipare. Ma questa partecipazione non può essere una di quelle procedure “bottom up” alle quali siamo abituati: si chiede alle regioni e ai comuni di inviare a Roma idee e progetti, si mettono insieme, si confeziona un pacchetto variopinto, si invia a Bruxelles. Nella formulazione di progetti che siano accettabili, sarebbe utile apprendere dai ricercatori che hanno avuto contatti con l’European Research Council, che hanno esperienza nella preparazione di questo tipo di progetti. In essi non può mancare un meccanismo e procedure di monitoraggio e di allarme, in caso di mancato rispetto di tempi e costi.
L’Italia ha grande bisogno di riforme, e l’occasione dell’intervento finanziario dell’Unione è unica, da non perdere. Non dimentichiamo quel che La strada smarrita, un’acuta e preoccupante analisi di Carlo Bastasin e di Gianni Toniolo (Laterza, 2020), ha ricordato in modo esemplare. Usciamo da un quarto di secolo diviso in tre parti: un dodicennio di ristagno, nel quale i partner europei correvano, noi procedevamo a passo lento; un tredicennio di declino, nel quale i nostri partner europei sono andati avanti, noi siamo ritornati indietro; ora si è aperta una terza fase, nella quale siamo tutti colpiti dalla crisi prodotta dalla necessità di difenderci dalla pandemia. Riformare, quindi, è importante e urgente. “Questa volta l’Italia non può sbagliare”, come hanno intitolato Marco Buti e Marcello Messori un “policy brief” della Luiss “School of European Political Economy” (21 agosto 2020), auspicando che si trovi la forza di liberarci della dipendenza dal passato.
© Riproduzione riservata