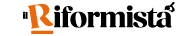Maradona è stato per Napoli più di quello che John Lennon è stato per New York, poco meno di quello che Che Guevara è stato per Cuba. In sette anni tutte le dimensioni del campione e dell’uomo: una promessa, la rivelazione, il capo-popolo, la vittoria, la bella vita, la malavita, la droga, l’amore, un figlio di nome di Diego Jr, il culto, la repulsione, la fuga, l’addio. Quando è morto, all’improvviso, il 25 novembre 2020, i napoletani sono scesi in strada a realizzare e a piangere. Si sono incontrati nei luoghi dell’idolo – al murales nei Quartieri Spagnoli e allo Stadio San Paolo soprattutto –, dentro e lungo le tracce che una delle icone del ‘900 ha lasciato in città.
Le scalette dello Stadio sono state il limes che il fenomeno e Napoli hanno attraversato insieme entrando in un’altra dimensione. Un warmhole. Il 5 luglio del 1984 erano in 70mila a Fuorigrotta. Mille lire il costo del biglietto. Mai vista un’accoglienza simile. In 58 anni di storia in azzurro erano arrivati Attila Sallustro, Antonio Vojak, Hasse Jeppson, Omar Sivori, José Altafini, Ruud Krol, Beppe Savoldi. Tutti ridotti a comparse: ci sarebbe stato solo un avanti e un dopo Diego. La città era quella del dopo terremoto del 23 novembre 1980, della Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo, e quindi della Nuova Famiglia, una decina d’anni prima l’epidemia di colera. Maradona fuggiva da Barcellona: come ha detto Daniel Gamper, filosofo e nipote del fondatore dei blaugrana Hans Gamper, la metropoli catalana “è stata un luogo di riposo per il ritorno allo specchio transatlantico di Buenos Aires: Napoli”.
“Questo ragazzino con l’aria di scugnizzo napoletano …”, aveva preannunciato Giacomo Mazzocchi su Tuttosport nel giugno 1979, costò 13 miliardi e mezzo di lire. Uno scandalo, secondo molti, per un 24enne con la faccia da Mapuche e un’elasticità alla Nureyev, in una città a pezzi, in crisi. È diventato Capitano di Napoli, non del Napoli, ha scritto Gianni Mura. Due Scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa UEFA. “È la cosa più grande della mia vita”, disse a Galeazzi dopo il primo Scudetto nel 1987. L’anno prima aveva conquistato da solo o quasi il Mondiale in Messico con l’Argentina. Ha vinto a Napoli come sa vincere Napoli: con la sfrontatezza e con l’estro.
Il San Paolo stesso è cambiato nel frattempo, e non solo per gli interventi in vista di Italia ’90: è diventato un luogo di festa, di spettacolo, dopo anni di delusioni. La città riscattata da uno scetticismo cronico, un popolo che si sfiziava e che si arricreava. Fabrizia Ramondino ha scritto che i gol di Maradona hanno avuto la funzione del miracolo di San Gennaro: una ricostruzione dell’identità. Un campione, anche nel senso di simbolo, di parte, un rappresentante della napoletanità. E quindi tutta la retorica sul riscatto, la rivincita sui club del Nord, del Sud del mondo sul Nord del mondo, fino alle parole prima della semifinale dei Mondiali del ’90 con l’Italia: “Dopo che per 364 giorni all’anno li chiamano terroni, appestati, terremotati. Dopo averli presi a schiaffi in tutte le maniere possibili, ora dicono che anche i napoletani sono italiani”. Scoppiò un caso. Alla fine il San Paolo tifò per l’Italia; molti napoletani tifarono comunque per lui, per Isso, el diez, dios, Dieco, Tièco, Tiechìto, e l’Argentina arrivò in finale, poi persa con la Germania. L’ultima partita a Fuorigrotta, con l’assist per il gol vittoria di Gianfranco Zola, il 17 marzo 1991, contro il Bari. Dopo il test anti-doping positivo alla cocaina, la squalifica di un anno e mezzo. E il numero 10 se ne tornò a Buenos Aires, senza il tempo per i napoletani di dirgli grazie. Senza quel congedo in molti rimasero ad aspettarlo, per anni.
La mappa di Maradona a Napoli percorre i luoghi del mito. Quelli attraversati, quelli vissuti, le tracce in collezioni private e musei al momento improvvisati o poco più, i luoghi di una devozione sempre condita da ironia, e comunque additata da bacchettoni e moralisti. Il capello, la boccetta con le lacreme napulitane, le statuette dei maestri presepai, i murales – gli street artist si sono fatti prendere la mano, a partire dal primo nei Quartieri Spagnoli dopo il secondo Scudetto nel 1990, ragion per cui si invita a segnalare altri omaggi – si progettano statue e monumenti. Tutti effetti collaterali di una malia, una malatia; un patrimonio materiale e immateriale straordinario che il Comune ha annunciato di voler capitalizzare con il Maradona Experience. Chissà.
Quando l’11 maggio del 1991 un gruppo di intellettuali si riunì per il convegno Te Diegum in onore del campione argentino, i soliti moralisti e bacchettoni si affrettarono ad additare la celebrazione di un pessimo esempio di vita; un mito che doveva essere mito in ogni dimensione, altrimenti che scandalo, e jamm. Questo mentre la città – forse non se ne accorgeva – ma usciva da sette anni che erano stati come vivere dove combatteva Muhammad Alì ogni domenica, dove Frida Kahlo esponeva puntualmente, dove Andy Warhol animava la sua Factory. Alla fine di otto ore di dibattito, quegli screanzati e irresponsabili di intellettuali si strinsero in lacrime guardando un video con le magie del Pibe de Oro al San Paolo – che giustamente oggi si chiama Stadio Diego Armando Maradona – sulle note di Ancora di Eduardo De Crescenzo. Se i napoletani hanno smesso di aspettarlo, non hanno smesso di cercarlo, di interrogarlo forse. E non solo i napoletani.
Le foto della mappa sono di Lapresse, degli autori degli eventi o dei murales, anche tramite social network