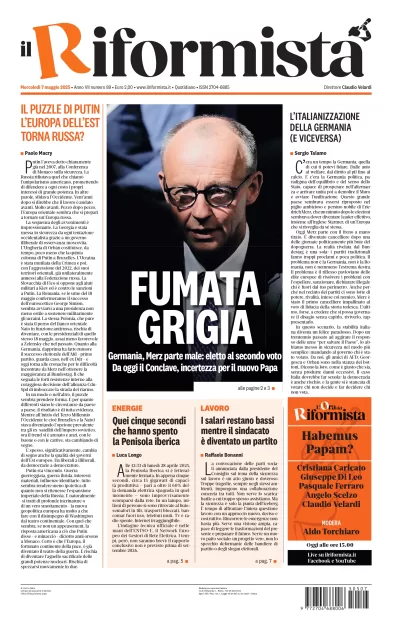Servono la politica, la diplomazia, il realismo
“Meglio i bolscevichi che i talebani”, la lezione di Amendola: sull’Afghanistan serve dialogare con Pechino

Dinanzi alle parole di Conte sul nuovo volto “distensivo” dei talebani, divenuti per così dire dei tagliagole pragmatici con cui trattare in maniera “serrata”, viene da chiedersi se non avesse una qualche ragione a suo tempo Giorgio Amendola. In una direzione del Pci egli rispose in maniera anche brusca alle istanze pacifiste che Fabio Mussi aveva avanzato dopo l’invasione sovietica di Kabul. «Preferisco la stella rossa dei carri armati sovietici ai simboli armati dei mujaheddin», disse il “bolscevico riformista” napoletano.
Per quello che di occidentale aveva il socialismo reale (cosa c’è di più europeo però dell’idea della rivoluzione che salta il tempo lineare e con la dittatura sovrana sfida l’esistente per inventare altri ordini?), era in corso anche allora uno scontro tra la politica che costruisce, innova, rompe e il fondamentalismo tribale che resiste a ogni cenno di modernizzazione. E le truci barbe dei reazionari armati (di ieri e di oggi) per la guerra santa, con lo scopo dei traffici loschi e dell’ignoranza e dell’oppressione femminile, non avevano nulla a che fare (questo andrebbe rammentato a tanti reduci del né-né) con le belle barbe dei rivoluzionari e dei riformisti del’800 e del ‘900 in lotta per un mondo nuovo.
La sconfitta e la precipitosa ritirata delle truppe Nato di oggi, appartengono, almeno in parte ovviamente, alla stessa storia che vide la fuga dell’armata rossa. Chi, come Letta, ne fa una bella questione di principio (la democrazia non si esporta con le armi) dice una banalità che nulla ha a che fare con la complessità e tragicità della politica. Dinanzi alle truppe napoleoniche, che marciavano nella vecchia Europa imponendo con le armi il linguaggio della costituzione e dei diritti, anche Marx non poteva esimersi dall’ammirare lo stratega della guerra continentale. Con essa l’imperatore edificava ed esportava la civiltà borghese (codici, garantismo, divorzio, secolarizzazione, libero commercio e libertà civili) “aprendo con la baionetta nuovi mercati e saccheggiando il mondo”.
Cosa sarebbe la democrazia italiana senza la forza delle armi, le bombe e la guerra che hanno distrutto il totalitarismo? Lo Stato nazionale, nella intuizione acuta di Cavour, non avrebbe mai potuto fiorire senza un intreccio di momenti (diplomatici e bellici) che richiedevano in certa misura il necessario coinvolgimento delle armi agli ordini di eserciti stranieri. E la repubblica ha avuto come processo costituente proprio la guerra condotta dalla strana alleanza stipulata dall’America con l’esercito dei soviet. Senza quella bandiera rossa alzata su Berlino da un ufficiale di Stalin, mai la Germania avrebbe conosciuto una democratizzazione spontanea. Quale sarebbe stato il responso dell’autodeterminazione dei popoli a Berlino o a Roma negli anni Trenta?
Quasi tutte le (ora) consolidate democrazie sono state imposte in origine dalle armi (la costituzione tedesca fu scritta con la consulenza e il suggerimento obbligante degli eserciti alleati di occupazione). Il problema dunque non verte sulla estraneità valoriale tra fuoco e libertà, che nessuna testa ragionevole osa negare. Il rapporto tra guerra e politica rientra però nella sfera imponderabile del fatto, non della pura opzione etica. Diceva Machiavelli che, nel mondo della storia effettuale, che si sa non è quello dei principi immutabili, la guerra è giusta se è necessaria, essa obbedisce cioè non a un fondamento mistico ma ad un metro di valutazione esclusivamente politico, rinvia a un calcolo dell’efficienza.
Ed è proprio sul piano della efficacia che l’avventura afghana, che non rientra tra le illegittime guerre di occupazione decise da Bush e Blair per esportare la democrazia con finte prove sulla detenzione di armi chimiche di distruzione di massa, andrebbe giudicata. Essa fu una risposta all’11 settembre che coinvolse molteplici stati sotto il coordinamento della Nato. Non ci fu una occupazione tradizionale ma un celere intervento armato per completare il lavoro di una guerra civile e supportare con le più sofisticate tecnologie belliche dell’occidente la costruzione di una parvenza almeno di Stato-nazione con una qualche capacità di sussistenza dinanzi agli eserciti del terrore.
Stando ai suggerimenti di un padre del liberalismo come Stuart Mill, l’asimmetria tra una potenza occupante democratica e un paese arretrato nella sua struttura civile ed economica si risolve soltanto con una dittatura provvisoria (un “vigorous dispotism”) incaricata di rompere il passato di immobilismo e tradizionalismo per modernizzare e civilizzare terre lontane e diventare così nel tempo superflua come potestà autoritaria. Anche quando l’occidente, nel mondo islamico, ha scartato l’opzione Mill (un “good despot” per civilizzare) e ha adottato percorsi più miti, il risultato non è stato brillante. Alle politiche per la scolarizzazione e la costruzione di una società civile non si sono affiancate a Kabul politiche per l’integrazione sociale e la formazione di una élite politica e militare in grado di resistere alle tentazioni della corruzione.
La fuga donchisciottesca di Biden rende ormai visibile che l’impero è nudo e questo spogliarello muta gli equilibri mondiali rendendo ancora più gracile la civiltà occidentale. Dinanzi alla minaccia che il fondamentalismo armato pone all’ordine e sicurezza internazionale sarebbe destinata alla sconfitta ogni riproposizione dello “scontro di civiltà” declinato nella maniera tradizionale. Un occidente sempre più piccolo, se vuole respingere l’attacco ai suoi principi costituzionali, sociali e culturali, non può spingere oltre un accettabile limite la contesa per la supremazia economica (Cina) e per la egemonia strategica (Russia).
La necessità di allargare il ventaglio degli Stati aggregabili in politiche di condivisione dei pilastri di un ordine mondiale policentrico e pacifico è avvertita soprattutto dalla Merkel che però è sulla via del pensionamento politico. La sterzata anticinese di Biden rivela calcoli strategici sin troppo miopi (un bel successo sarebbe costringere la Cina alla inedita corsa agli armamenti per una riedizione di una escalation militare degna del bipolarismo post-bellico). Come ha argomentato Sabino Cassese, a livello internazionale il valore della democrazia, riconosciuta nelle carte sottoscritte dalle Nazioni Unite, non può coincidere con l’imposizione del modello classico europeo-americano assunto in senso stretto. Esso può essere perseguito solo come il riconoscimento di una istanza di democrazia minima, con modelli differenti di gestione del potere, e quindi secondo una griglia di classificazione dei diritti essenziali funzionante a maglie sufficientemente larghe.
L’utilizzazione della nozione di totalitarismo per esorcizzare il pericolo della concorrenza cinese non regge alla prova del realismo politico indispensabile in questa fase di estrema vischiosità e incertezza per l’esaurimento in corso della centralità americana. Osservava Marx che “certo il socialismo cinese potrà corrispondere a quello europeo quanto la filosofia cinese a quella di Hegel”. E comunque, nelle proporzioni indicate da Marx, un richiamo al socialismo (sia pure nella versione cinese e addomesticato con la idea di Confucio dell’armonia, una variante orientale di Leibniz) di per sé ha qualcosa di occidentale.
Proprio perché non esistono talebani “distensivi” e, parafrasando Amendola, un dialogo con la stella rossa cinese per la gestione dei nuovi equilibri internazionali è comunque preferibile alla seduzione per spada dei tagliagole (perché Pechino adotta il linguaggio della politica e non del terrore, lavora per la ricezione del diritto romano e non della sharia), serve una lungimiranza politica che su iniziativa europea allarghi ad altri partner i confini dell’occidente la cui cultura, per la pochezza della leadership americana, è sotto scacco e rischia il tramonto.
© Riproduzione riservata