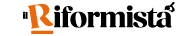Da ragazzo rimasi impressionato da un film intitolato L’ultima spiaggia. Uscito del 1959 era diretto da Stanley Kramer, interpretato da Gregory Peck, Anthony Perkins, Fred Astaire e Ava Gardner. Il soggetto del film risentiva delle paure e delle suggestioni di quell’epoca: il rischio di una guerra nucleare tra le due potenze imperiali che avrebbe distrutto l’umanità. L’opinione pubblica aveva introietto questa psicosi tanto che, soprattutto negli Usa, si costruivano, nel giardino di casa, rifugi antiatomici, ricolmi di vettovaglie per poter sopravvivere fino a quando non fossero spariti nell’atmosfera gli effetti delle radiazioni.
L’ultima spiaggia (una definizione che da allora è entrata nel linguaggio metaforico) rappresentò l’apoteosi di quel clima da “mille non più mille”. Al termine della terza guerra mondiale – si legge nella scheda del film – l’emisfero settentrionale è un mondo completamente distrutto dalle esplosioni nucleari. Anche il resto della Terra è destinato a subire l’ondata devastatrice delle radiazioni, ma, per il momento, in Australia la gente si illude o finge di illudersi di avere ancora una via di scampo. Un sottomarino americano, il Sawfish, comandato da Dwight Lionel Towers (Gregory Peck), sfuggito al disastro perché in immersione al momento dell’esplosione atomica, fa rotta verso le coste australiane per valutare le possibilità di sopravvivenza. Le speranze sono destinate a sfumare e gli uomini, consapevoli dell’approssimarsi della fine, fanno un bilancio della propria esistenza misurandosi con il significato della vita.
È in tale contesto che nasce la disperata storia d’amore tra il comandante Towers e la disillusa Moira Davidson (la bellissima Ava Gardner). Ma i venti sono implacabili nel portare la morte anche nell’ultima spiaggia. Il film si chiude con la desolante immagine delle piazze di Melbourne prive di vita mentre il ritmo della celebre canzone “Waltzing Mathilda”, che per gli australiani è quasi un secondo inno nazionale, accompagna il silenzioso ed insignificante sventolio di una bandiera. La mia generazione è cresciuta in quel clima. Anzi ero già grande (frequentavo i primi anni di università) quando scoppiò, nell’ottobre del 1962, la crisi di Cuba: un duro confronto tra gli Usa e l’Urss per i missili che il Cremlino stava installando nell’isola caraibica ad un tiro di schioppo dalle spiagge americane. Per fortuna il buon senso prevalse (le vicende di quei tredici giorni sono state raccontate molte volte).
Tra John Kennedy e Nikita Kruscev si trovò un compromesso che fu il segno di quei tempi nuovi che vennero chiamati della “distensione”. Nato nei primi anni della Seconda guerra mondiale ho potuto conoscere i bombardamenti, il riparo nei rifugi, lo sfollamento; poi la vita grama del dopoguerra, la miseria, le coabitazioni, le malattie esantematiche, una dopo l’altra, che venivano curate restando a letto. All’improvviso tutto cambiò: venne il miracolo economico, con il frigorifero, la televisione, la lavatrice, le vacanze, la Vespa; poi la prima auto usata. Alla fine degli anni 60 sembrò possibile affrontare la scalata del cielo; fino a quando ben due crisi petrolifere imposero un’ampia riconversione dell’economia. Ho conosciuto – da vicino – lo stragismo e il terrorismo.
Poi è caduto il Muro di Berlino e ho creduto anch’io che fosse finita la storia. Invece ne era cominciata un’altra peggiore, dove sono tornate alla ribalta forze e subculture ritenute emarginate, se non addirittura estinte. Come nel gioco dell’oca siamo tornati alla casella di partenza. Ma non è più la stessa di prima. In quasi ottant’anni ne ho viste di tutti i colori. Non avrei mai pensato, però, che il mio “mondo” cadesse vittima di una crisi di nervi a causa – l’ha definita così Ilaria Capua – di una simil-influenza, fino al punto di suicidarsi, uccidere l’economia e la vita sociale, accontentandosi di costruire nei tinelli di casa dei simil-rifugi antiatomici, gli stessi che, a suo tempo, suscitavano una diffusa ilarità quando ce li mostrava la Settimana Incom prima del film.
Il virus pestifero non è il Covid-19. Non è il Coronavirus ad impestarci, ma la comunicazione, la tv, le reti, il web, che scelgono non solo le notizie da dare ma anche come darle. Si crea in questo modo (ormai lo abbiamo visto in troppe occasioni) un’opinione pubblica sobillata che si rivolge alle autorità politiche ed amministrative, le quali vanno a rimorchio, non hanno il coraggio di sostenere la sola via di persuasione in casi come questi: sottoporre i fatti ad una valutazione di relatività, in modo che tutti ricordino che l’essere umano non è immortale. E che tante, ben più gravi, sono le cause di morte. D’altro canto che cos’altro potrebbero fare i governanti?
Viviamo in un Paese in cui una sindaca è stata condannata perché non aveva dato l’ordine di chiudere le scuole quando la sua città fu sommersa dalle acque; ad un amministratore delegato delle Ffss è stata imputata la responsabilità di un incidente ferroviario gravissimo verificatosi mentre lui dormiva nel suo letto a centinaia di Km di distanza; i componenti della Commissione Grandi Rischi hanno dovuto rispondere penalmente di non essere indovini e di non aver previsto il verificarsi di un terremoto. Questa logica dovrebbe farci capire che – nel caso dell’epidemia simil-influenzale – ci siamo infilati lungo una strada senza ritorno. I predicatori di morte non sono legittimati a inneggiare alla vita. Hanno un bel da lamentarsi, i sindaci, le imprese, persino i sindacati. «Malanno sei scatenato – afferma Marc’Antonio al termine dell’orazione funebre davanti al cadavere di Cesare – Ora fai il tuo corso».