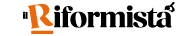Il termine garantismo circola sempre più con una sorta di specializzazione semantica che lo rivolge in maniera prevalente all’attività inquisitoria della magistratura. In realtà, quando parliamo di garantismo, dobbiamo far riferimento all’intero sistema di garanzie che offre l’ordinamento giuridico, a partire dalle “garanzie costituzionali” che lo informano in tutta la sua struttura. Certo, nel vecchio Stato di diritto, la garanzia fondamentale del cittadino era che il giudice fosse sottoposto alla legge, ma con le costituzioni della seconda metà del XX secolo (tra cui la nostra) si è modificata in maniera radicale la posizione dei diritti fondamentali, che, dette costituzioni, non istituiscono più, affidandole al potere legislativo, ma presuppongono rispetto allo stesso potere costituente.
E ciò proprio per evitare il “torto legale” imputabile a leggi (come ad esempio quelle “razziali”) pur valide dal punto di vista formale. E le Corti costituzionali sono istituite proprio come “giudice delle leggi” costituendo, così una garanzia apicale.
Ma che significa questa presupposizione dei diritti fondamentali anche contro il potere legislativo come incarnazione della sovranità del popolo? Significa che la legittimazione dell’ordinamento non riposa più soltanto sulla sovranità che tale potere incarna, ma anche sulla vigenza di tali diritti, da mettere in salvo, per il fatto di essere fondamentali, anche nei confronti delle mutevoli maggioranze a cui la democrazia affida il potere di fare le leggi. Da questa nuova condizione consegue necessariamente l’ampliamento, rispetto agli altri poteri costituzionali, del potere del giudice posto in relazione diretta con i principi della costituzione.
Alla vecchia separazione dei poteri, sotto la sovranità del legislativo, si è sostituita la “cooperazione” tra detti poteri tutti vincolati alla garanzia dei diritti come concorrente fondamento di legittimità dell’ordinamento. Resta scontato che la cooperazione può anche generare conflitti, nonché egemonie più o meno passeggere di un potere rispetto agli altri (come abitualmente avviene a favore del potere esecutivo) allorché si creano “vuoti di potere” in relazione all’espletamento di determinate competenze; ma tutto ciò può anche restare nella fisiologia, per così dire, della democrazia rappresentativa.
È, invece, la patologia del tessuto dello Stato costituzionale democratico che può determinare gli eccessi del “potere del giudice” o (in caso di rigida subordinazione ad altri poteri) le sue deficienze. Se dunque partiamo dal presupposto oggettivo che lo Stato di diritto costituzionale in cui abita la democrazia occidentale poggia su una doppia legittimità, vale a dire sulla sovranità del popolo e sui diritti fondamentali, dobbiamo anche ammettere che tra le due possa esserci, oltre l’auspicata convergenza o addirittura sinergia, anche divergenza e frizione.
La sovraesposizione del potere giurisdizionale a cui assistiamo oggi è, soprattutto, l’esito dell’indebolimento della volontà politica, talché la giustizia si offre come luogo di esigibilità della democrazia di fronte al discredito delle istituzioni politiche e alla depressione dello spirito pubblico. E parlo chiaramente della giustizia nel suo complesso e non solo di quella parte iperprotagonista che in Italia è rappresentata dai Pubblici Ministeri (pur interni all’unico “ordine” dei magistrati) e che, per altro, altrove (es. tradizione anglo-sassone), non rientra pienamente nel puro potere giudiziario (esponendo la natura politica della funzione).
Il centro di gravità della democrazia si è spostato verso la giustizia: i suoi metodi, le sue argomentazioni, il suo vocabolario (trasparenza, motivazione, imparzialità, contraddittorio, ecc.) appaiono più credibili dell’esercizio della volontà politica. Tale tendenza ha accentuato un profilo a sua volta connaturato alla struttura ambivalente della democrazia costituzionale: la difesa dei diritti individuali e collettivi di cui i cittadini si sentono titolari al di là della loro soggettività politica attiva e che vogliono veder tutelati davanti a un’autorità imparziale.
Ma, si badi bene, altro è la tutela giurisdizionale dei diritti – funzione coessenziale alla democrazia costituzionale – altro è la sfiducia nella rappresentanza politica, che ha generato un atteggiamento di sorveglianza “giudiziaria” dei cittadini sull’operato dei loro rappresentanti.