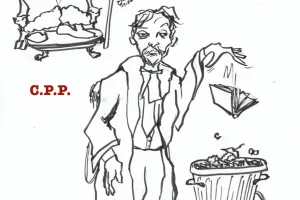"Chi era contro la guerra, oggi rimprovera gli Usa di aver lasciato Kabul"
“Pragmatismo con i talebani, per difendere i diritti umani servono compromessi”, parla Marcello Flores

Tra la scorciatoia militarista e il non interventismo imbelle ci può essere una terza via. Il Riformista ne discute con uno dei più autorevoli storici italiani: Marcello Flores. Il professor Flores ha insegnato Storia comparata e Storia dei diritti umani nell’Università di Siena, dove ha diretto anche il Master europeo in Human Rights and Genocide Studies. Tra i suoi libri: Il secolo del tradimento. Da Mata Hari a Snowden 1914-2014, (il Mulino, 2017), Il genocidio degli armeni (il Mulino, nuova ed. 2015), Traditori. Una storia politica e culturale (il Mulino, 2015), Storia dei diritti umani (il Mulino, nuova ed. 2012), La fine del comunismo (Bruno Mondadori, 2011) e 1917. La Rivoluzione (Einaudi, 2007), Tutta la violenza di un secolo (Feltrinelli, 2005), La forza del mito. La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo (Feltrinelli, 2017) e il recente Il genocidio (Il Mulino, 2021).
In queste settimane in molti si sono cimentati nel definire gli accadimenti in Afghanistan e le scelte dell’Occidente, America in primis: fuga, resa, tradimento o, sul versante opposto, una decisione che doveva essere presa almeno 18 anni prima. Lei come la vede?
Intanto mi sembra che troppo spesso si sia cercato di individuare colpe ed errori di una storia che è molto più che ventennale, ma è almeno cinquantennale, per restare all’ultima fase della storia dell’Afghanistan. E ognuno si è cimentato a individuare quello che era, a suo dire, l’errore o la colpa principale: l’intervento russo, ovvero l’appoggio Usa ai mujahiddin, oppure l’intervento nel 2001 dopo l’attentato alle Torri Gemelle. Alla ricerca di una specie di peccato originale per quello che è successo adesso. Ora, se non vogliamo riandare alla storia che ci ha dimostrato più volte l’irriducibilità nel grande gioco delle grandi potenze nel tentare di sottomettere l’Afghanistan, bisogna anche riconoscere che ci sono state tante situazioni complesse in cui le cause erano molteplici, le situazioni difficili, le scelte erano tante e non facili per tutti quanti. Bisognerebbe avere il coraggio di fare una analisi maggiore, anche se capisco che poi nei titoli, nei tweet, questo non si può fare. Per limitarci alla situazione più recente, cioè di questo secolo, io credo che la reazione americana del 2001 avesse delle basi giuridiche nel Diritto internazionale ed ebbe, peraltro, l’avallo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lì però sicuramente il primo errore, come diversi testimoni anche dell’epoca hanno poi scritto in articoli o in interviste su vari giornali, soprattutto stranieri, è che quando l’Alleanza del Nord, con cui gli americani erano alleati per sconfiggere i Talebani, quando gli “Studenti coranici” vengono sconfitti già a dicembre 2001, e l’Alleanza del Nord chiede una sorta di accordo di pace, quella richiesta viene rifiutata dagli Stati Uniti perché volevano sconfiggere il Terrore, con la “t” maiuscola. Quello credo sia stato uno dei primi momenti in cui è entrata in gioco per gli Usa una logica che non era quella né di pacificazione né di creazione o di aiuto alla creazione di istituzioni nuove, di appoggio alla società civile afghana, che esiste sia pure in forme diverse da quelle che noi siamo abituati a vedere. Direi che c’è sempre stata, sia pur in modo diverso, da parte di tutti i presidenti Usa, dell’ultimo ventennio, da Bush a Obama , da Trump e ora a Biden – che oggi viene additato come il “traditore” e il “fuggiasco”, come se tutti gli errori siano il portato della sua presidenza – – una idea sostanzialmente militare del controllo del territorio, che ha comportato l’accordo con le forze più retrive, conservatrici e corrotte del potere afghano, cioè le grandi famiglie, i signori della guerra. A ciò si aggiunge il fatto che l’Europa non ha avuto alcuna autonomia rispetto alle scelte americane, anche se gli europei presenti, italiani compresi, si sono mossi per cercare di creare delle strutture soprattutto legate alla scuola, alla sanità, cioè a una ricostruzione civile del Paese. Uno sforzo positivo che però veniva contraddetto dalla logica militare per cui gli americani bombardavano alla ricerca di un terrorista anche famiglie che non c’entravano niente e che invece gli europei aiutavano per la ricostruzione. In tutti quei vent’anni c’è stata una doppia se non tripla presenza dell’Occidente. E qui, dopo avere sottolineato gli errori americani, mi lasci aggiungere qualche parola sul fronte opposto…
Prego, professor Flores…
Quelli che erano schierati, e che lo sono ancora, rivendicando la loro posizione contro l’intervento in Afghanistan, si son guardati bene dal dire cosa avrebbero potuto o voluto fare nei confronti dei Talebani. E adesso accusano gli Stati Uniti di andarsene, di tradire gli afghani, cosa un po’ contraddittoria. Quella del mai intervenire, mai nessuna guerra, è la logica un po’ da pre-Seconda guerra mondiale, pre-Diritto internazionale nuovo del ’45-’48: lasciamo fare alle sovranità nazionali quello che vogliono. Io credo che per fortuna si sia andati avanti. Poi è vero che la maggior parte, se non quasi tutti gli interventi che l’Occidente ha fatto nel secondo dopoguerra, sono stati, anche quando erano magari giusti, condotti male. Questo è un grosso problema. Per restare all’Afghanistan, il dramma era questa forbice, per cui se è vero che, dal 2001, sono state migliorate le condizioni delle donne, dell’educazione, della salute, della sanità, è altrettanto vero che il bombardamento dei civili nella caccia ai terroristi ricreava invece questa ostilità e favoriva il legame con i Talebani. Se mi permette, vorrei fare due esercizi di memoria di cui sono stato testimone diretto…
Un esercizio molto utile e pedagogico…
Agli inizi degli anni ’70 lo zio di mia moglie, era l’ambasciatore italiano in Afghanistan. Beh, il suo problema principale era quello di riuscire a farsi prestare dagli americani dei grandi freezer per tenere i cadaveri dei giovani italiani morti di droga che si trovavano lì. Questa era la principale occupazione dell’ambasciatore nei primi anni ’70. Poi cambia tutto. C’era un mondo completamente diverso, che è cambiato nel giro di pochi anni, con l’intervento sovietico, che, c’è poco da fare, è la chiave di volta che ha cambiato radicalmente tutto quanto. L’altro ricordo è che, alla fine degli anni ’90, al master europeo sui Diritti umani che avevamo all’Università di Siena, veniva a insegnare un italiano, Antonio Donini, che era stato il responsabile delle Nazioni Unite in Afghanistan nei primi anni della presenza dei Talebani, cioè nel governo che nasce nel 1996. Lui c’era stato fino al 1999. E raccontava come, dopo contatti e “accordi” durati mesi, erano riusciti ad ottenere che le ragazze e le bambine potessero essere prese in ospedale, perché prima alle donne, anche bambine, non era data la possibilità di andare in ospedale, e quindi morivano o si trovavano in situazioni gravi. In quell’occasione, se ricorda, Emma Bonino, allora Commissaria europea, andò lì e fece una dichiarazione giusta, di principio, sui diritti, le libertà, e fu anche fermata per un paio d’ore. Per quella cosa lì i Talebani stracciarono l’accordo che c’era stato. E questo fatto Donini poneva sempre come esempio: il problema che, da una parte, è giusto rivendicare sempre i principi e quindi non cedere, e dire vabbè ora mettiamo tra parentesi i diritti umani. Ma nello stesso tempo, i diritti umani hanno bisogno di un estremo pragmatismo per poter essere davvero costruiti e difesi. Non bastano le parole. E a volte addirittura le parole sono in conflitto con il pragmatismo e lo mettono in discussione. Per dire che oggi è questo che bisogna cercare di avere: un forte pragmatismo, che può significare anche avere rapporti e arrivare addirittura a dei compromessi, a firmare degli accordi con il nuovo governo talebano su alcuni aspetti, ma allo stesso tempo mantenere in linea generale una forte ostilità nei confronti delle violazioni dei diritti, dei principi di libertà. Su questo credo che l’Europa possa fare molto.
Cosa, ad esempio, professor Flores?
Intanto ho piacere che finalmente si parli di nuovo della possibilità di creazione di una Forza europea d’intervento rapido, che sia l’inizio di qualche cosa di più strategico, cioè di una vera Forza militare europea, cosa che da decenni le persone più avvedute auspicano. E dunque, potersi muovere per pretendere e ottenere corridoi umanitari, garanzie per quelli che rimangono lì, o almeno un certo tipo di garanzie, e al tempo stesso fare un’opera in Europa sui profughi e i rifugiati che ha ben riassunto il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, domenica nel suo intervento. C’è poco da fare; non si può dire vogliamo difendere le donne, i diritti umani etc., e poi non fare nulla di concreto come vorrebbero, ad esempio, Salvini e la Meloni.
© Riproduzione riservata