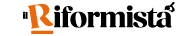Meno quattro giorni. Nella notte in cui tutti in Italia, e nel resto del mondo con orari differenziati, festeggeranno l’arrivo del nuovo anno, entrerà in vigore nel nostro paese una nuova regola, quella della giustizia infinita e assoluta, quasi una giustizia divina che colpirà innocenti e colpevoli con l’abolizione della prescrizione. A un fallimento storico dello Stato che già rinuncia ogni anno a concludere circa 120.000 processi a causa della propria pigrizia e della propria incapacità, si aggiungerà l’impotenza perenne a giudicare, codificata in una legge. Cioè “fine processo mai”. Il ministro guarda sigilli Bonafede e i suoi ispiratori in toga non demordono: dal primo gennaio 2020, dopo il processo di primo grado, per condannati e assolti i termini di scadenza si fermeranno e si apriranno le porte di un limbo processuale infinito.
Il Partito democratico, il cui ultimo ministro di giustizia Orlando aveva già dilatato al massimo i termini di scadenza per i reati più gravi, ha presentato ieri ai partner di governo il suo brodino tiepido. Congeliamo la prescrizione per due anni dopo la sentenza di primo grado e un altro anno e mezzo dopo l’appello, hanno detto i dirigenti del partito. Chiarendo però che la loro non è neppure una vera proposta alternativa, come ha spiegato il responsabile giustizia del Pd Walter Verini, ma uno spunto per trovare poi un punto d’incontro nel vertice di maggioranza del prossimo 7 gennaio. Così, se il brodino si raffredderà ulteriormente, rischia di diventare secchiate di acqua gelata soprattutto nei confronti di condannati e assolti per i reati meno gravi. Perché è ovvio che se aggiungi due anni ai 17 già previsti per la corruzione, arrechi un danno notevolmente inferiore in proporzione rispetto a chi è stato processato per reati che prevedono la prescrizione dopo sei anni. Un altro risultato è che nei fatti si aboliscono i tre gradi di giudizio.
Pensiamo alla vicenda di Enzo Tortora, che è nella memoria di tutti come il più grande simbolo dell’ingiustizia. Tortora era stato condannato nel processo di primo grado e poi assolto in appello. Ma probabilmente non sarebbe mai arrivato prima di morire a vedere sanate l’ingiustizia e la gogna vergognosa che aveva subito. Perché con il blocco della prescrizione chi avrebbe avuto fretta di sottoporre di nuovo a giudizio un personaggio pubblico già definito da un pubblico ministero “trafficante di morte” e già condannato anche in sede processuale?
Il fatto singolare (ma non poi tanto perché questa democrazia giudiziaria incute timore un po’ a tutti) è che nelle serrate discussioni di questi giorni tra politici, giuristi, mass media e opinione pubblica in genere, vengano costantemente sottovalutati i dati che lo stesso ministero di giustizia ha reso pubblici. Innanzi tutto la fase in cui si concentra il maggior numero di prescrizioni è quello delle indagini preliminari, cioè quello in cui è dominus il pubblico ministero e che spesso procede di proroga in proroga. Tanto che si arriva al primo grado di giudizio mentre è già maturato un buon 75% di prescrizioni. Questa parte del processo non è toccata dalla legge Bonafede, e soprattutto nessuno, in parlamento né fuori, chiama in causa le responsabilità di chi troppo spesso si trastulla con retate ad effetto o provvedimenti clamorosi tanto quanto fragili, che verranno annullati dal tribunale del riesame o nei successivi gradi di giudizio. Per non parlare della questione dei tempi processuali. Come mai a Venezia e Torino l’estinzione del processo riguarda il 40% dei procedimenti definiti, mentre nelle corti d’appello di Milano, Lecce, Palermo, Trieste, Caltanissetta e Trento il numero di prescrizioni non arriva al 10%?
C’è il sospetto che, a trent’anni dall’entrata in vigore del codice del 1989 che dovrebbe aver introdotto in Italia un sistema processuale “tendenzialmente” accusatorio, ci siano tra le toghe, anche tra i magistrati più giovani che proprio in quegli anni nascevano, molte resistenze. Per esempio nell’uso del patteggiamento e dei riti alternativi, che toglierebbero gran parte del carico ai tribunali. Ma ci vorrebbe una vera cultura laica del diritto, una visione della società che non dilatasse al massimo la pretesa punitiva dello stato (lo stesso papa Francesco ha denunciato l’”espansione dell’ambito della penalità”), che non identificasse la certezza della pena con la certezza del carcere, che non avesse come punto di partenza delle indagini la “pericolosità sociale” del soggetto invece che il singolo fatto criminoso.
Ci sono stati in passato procuratori come Maddalena e Zagrebesky ( e oggi il procuratore di Milano Francesco Greco) che hanno cercato, in modo isolato e quasi artigianale, di riorganizzare gli uffici in modo efficiente, anche prevedendo corsie preferenziali per tipologie di reato ben individuate. Ma rimangono esperienze appunto isolate, artigianali e a volte, come nel caso recente di Milano, osteggiate dagli stessi sostituti procuratori che dovrebbero metterle in atto.
La verità è che su tutta la vicenda del processo in Italia, e di conseguenza anche sulla prescrizione, aleggia da sempre lo spettro del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, il mostro che i costituenti vollero come garanzia di una giustizia uguale per tutti e a bilanciamento di una ritrovata indipendenza della magistratura, garantita anche ai pubblici ministeri, dopo la dittatura fascista. L’articolo 112 della costituzione oggi non ha più senso di esistere. Non nel sistema processuale di tipo accusatorio, pur se ambiguo e abbondantemente annacquato negli anni successivi al 1989 da una serie di piccole e grandi controriforme. Non per la palese contraddizione con un altro principio costituzionale, quello della ragionevole durata del processo che deve essere garantita a tutti i soggetti, imputati, vittime e parti civili.
Nel 1993, pur nel tumulto delle note vicende giudiziarie e politiche, ci fu un ministro di giustizia, competente e galantuomo, di nome Giovanni Conso, il quale nominò con decreto una commissione di riforma dell’ordinamento giudiziario composta da magistrati di vario orientamento. Quell’organismo lavorò e stese una relazione finale, nella quale mise una pietra tombale sul principio dell’azione penale obbligatoria, non solo prendendo atto dell’impossibilità di perseguire tutti i reati, ma denunciando anche il fatto che tutti i giorni nei tribunali si commettevano ingiustizie con il totale arbitrio nelle mani dei pubblici ministeri. Quando c’era un ministro competente e galantuomo. Ora c’è Alfonso Bonafede.