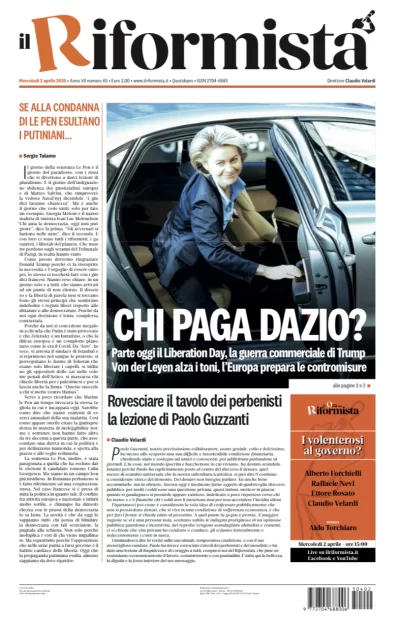La polemica
Privatizzazioni, Prodi evoca il ‘modello Germania’ ma dimentica il suo passato…

Quello che più è mancato, nel dibattito sulla destinazione dei fondi europei per la crescita, è un inquadramento storico-politico che meglio contribuisse a chiarire il senso delle impegnative scelte di governo. Il “debito buono” comporta politiche pubbliche che archiviano la dogmatica economica della seconda repubblica e anche lo statalismo sussidiario e non strategico prevalente nell’età grillina. Quando oggi Prodi invita a fare come la Francia e (soprattutto) a seguire la lezione della Germania (azionariato popolare, prestiti e partecipazione pubblica di minoranza, credito e partecipazione diretta nel capitale d’impresa) rimuove senza un esame critico trent’anni di storia economica. E invece servirebbe fare i conti con la dottrina Andreatta che negli anni Novanta ha insistito per smantellare l’impianto dell’economia mista che con i suoi elevati ritmi di crescita ha accompagnato l’Italia nel novero dei paesi più industrializzati.
Correva un tempo di svolta che sprigionava per i governi quasi un oggettivo obbligo alle privatizzazioni. Però Andreatta, abbandonato il keynesismo d’un tempo, pose un enorme carico ideologico alle soluzioni dettate dal vincolo esterno. Sulla scia di Guido Carli, egli invitava a fare una guerra radicale allo Stato imprenditore. In questa lotta per le privatizzazioni urtava contro una parte della sinistra Dc, con “il ragazzo Bodrato”, come lo chiamava Carli, ricordandogli “la ferita profonda” delle lontane nazionalizzazioni dell’energia elettrica che sconsigliavano il suo “moderato interventismo” per mantenere il compromesso tra democrazia e capitalismo. Andreatta se la prendeva in particolare con la riluttanza della maggioranza ad assumere misure “sanguinose”. Gli stipendi, a cominciare da quelli pubblici, dovevano scendere, le tariffe dell’acqua aumentare, le aziende pubbliche andavano vendute per chiudere gli “uffici cariche di partito”. Il cuore della dottrina Andreatta, una sorta di dirigismo privatista, pulsava molto vicino al liberismo estremo di Carli che tuonava ad ogni occasione: “via il socialismo reale dell’economia”. A questa ondata ideologica contro lo Stato-padrone partecipò anche Prodi con numerosi saggi apparsi sul Mulino. In essi esortava a scacciare “i moderni Principi” dall’economia e a respingere come il male più radicale il modello tedesco o francese di neo-capitalismo reo di ospitare ancora un eccessivo ruolo di gestione del pubblico.
Ad accodarsi al vangelo delle privatizzazioni furono i post-comunisti. Il loro ministro ombra Cavazzuti, alfiere delle privatizzazioni, si scagliava contro “la Dc che è come il Pcus”. Altre volte l’economista se la prendeva con i socialisti accusati di essere “attaccati a modelli brezneviani”. Quando la delegazione del Pds con Occhetto si recò dai laburisti, dinanzi all’illustrazione del fresco verbo liberista sventolato dai post-comunisti, in condivisione con la componente bolognese della sinistra Dc, i leader del Labour rimasero sbigottiti e increduli. La giustificazione della raffica di privatizzazioni agognata dalla Quercia venne trovata nella necessità di eliminare il punto di forza dell’occupazione socialista delle banche, delle società partecipate. Nessun modello economico alternativo, dunque, ma solo un uso tattico delle privatizzazioni a pioggia per sciogliere la costituzione materiale della partitocrazia. Una follia che con la svendita delle imprese, le privatizzazioni di Eni, Bnl, Enel, Ina etc. ha demolito un peculiare sistema economico gettando l’apparato produttivo nel vuoto di direzione politica. Secondo la visione ideologica di Andreatta correvano bei tempi con occasioni irripetibili per i profitti. Occorreva semplicemente cancellare lo Stato padrone e afferrare delle occasioni straordinarie. Per questo polemizzava con «l’industria piagnona che non ha colto la eccezionale opportunità e non ha la volontà sadica di far penare i francesi e anzi di distruggere interi settori dell’industria francese o tedesca».
L’impresa “piagnona” però non disponeva di capitali necessari per acquistare i giganti pubblici dismessi. E nemmeno poteva immaginare di condurre l’assalto alle grandi imprese straniere. È avvenuto esattamente il contrario, la penetrazione di capitali esteri è stata celere e inevitabile è stata la smobilitazione delle strutture produttive, con la conseguenza di una perdita di controllo di settori nevralgici senza i quali evanescente è la stessa sovranità nazionale, come ora ammette anche Prodi. Senza uno Stato che svolge funzioni rilevanti di indirizzo-programmazione, e senza una trama di grandi imprese pubbliche e private, il trentennio della seconda repubblica ha fatto precipitare l’Italia in una condizione economica del tutto periferica. Con la fine dell’economia mista, nessun altro modello è stato progettato e un arco di tempo così ampio nel segno di decrescita e stagnazione reclama un esame critico per il concepimento di una nuova politica economica. Peccato che la sinistra e il sindacato siano completamente assenti nel dibattito sul nuovo intreccio pubblico-privato. Con le loro fragilità essi rinunciano ad ogni rappresentanza delle peculiari ragioni del lavoro nel quadro degli obiettivi strategici che il governo di tregua assume quali prioritari, naturalmente dal punto di vista di un rilancio della funzione direttiva del capitale nel medio periodo.
Le organizzazioni del lavoro hanno ormai scelto la via subalterna del sindacato di strada, cioè della amministrazione dei servizi per la cura dei diritti, ovvero il livello della pura redistribuzione. Il Pd vede il trionfo proprio dei discendenti degli artefici della distruzione dell’economia mista. Per una nuova stagione, non basta evocare il pubblico e il debito buono. Le ragioni del lavoro servirebbero anche all’agenda Draghi che sconta in questa congiuntura proprio l’assenza di una moderna cultura di sinistra.
Tra risorse pubbliche destinate ai ricchi per la ripartenza e sussidi indispensabili riservati ai poveri per la sopravvivenza a mancare è la parola blasfema della programmazione per una innovazione che guardi oltre i limiti organici del capitalismo italiano. Non bastano misure caritatevoli per la protezione dal rischio e agevolazioni a pioggia per la resilienza. Il pubblico serve per creare nuovi beni collettivi, infrastrutture efficienti, miglioramento dell’impatto ambientale, attenzione alla cura, alla salute, alla scuola, affinamento della ricerca, crescita dell’occupazione anche pubblica e di qualità. In tempi migliori si sarebbe senz’altro detto: elementi di socialismo.
© Riproduzione riservata