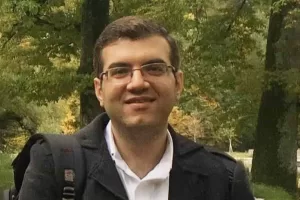La dittatura della "democrazia incompiuta"
Putin e il passato che non c’è più: la storia sovietica guida la Russia di oggi che sogna di riscrivere il progetto imperiale
Lo zar ha plasmato il paese in un ibrido di autoritarismo e populismo. Controllo delle risorse, repressione interna ed espansione militare hanno consolidato il suo potere

Sono trascorsi esattamente trentatré anni dalla notte di Natale (cattolico) del 1991, e l’Urss non c’è più. Al suo posto, una superpotenza che l’Occidente ha forse compreso solo a metà. Quella “democrazia incompiuta” che Washington e i suoi alleati avevano considerato come una tappa verso una società liberale si è lentamente trasformata in un ibrido che oscilla tra la nostalgia della Russia zarista e la nostalgia della Russia sovietica.
Forte dell’appoggio dottrinale del Patriarcato ortodosso e di intellettuali come Ivan Ilyn, Lev Gumilëv e Alexander Dugin, profeti di una missione salvifica e redentrice della “Nuova Russia”, Vladimir Putin ha potuto così stipulare un contratto sociale con il popolo, basato sullo scambio tra sicurezza e libertà. Una libertà, come si disse nei decenni terminali del Novecento, che nel corso di un millennio i russi avevano respirato soltanto per quattro mesi: dall’ottobre 1917 al gennaio 1918. Troppo poco per affezionarsene.
Più facile, invece, si è rivelato il consenso alle imprese belliche nel Dagestan, in Cecenia, in Georgia, in Crimea, nella Siria e in Ucraina. Una politica muscolare che pare aver sedotto migliaia di giovani e perfino i loro padri: molti dei quali – secondo un sondaggio demoscopico da prendere con le pinze – sognano che i loro figli entrino a far parte delle forze speciali e ammirano senza riserve Stalin, non più oscurato dalla vergogna delle purghe e dei milioni di morti di carestia dell’Holodomor, ma considerato un padre della patria come Puskin considerava Pietro il Grande.
L’avventura di Vlad “The Mad”, come è stato ribattezzato, comincia con la nomina a primo ministro (agosto 1999), seguita l’anno successivo dalla vittoria alle elezioni presidenziali, ottenuta col sostegno di Boris Eltsin. Putin si dedica quindi a una “ricostruzione” dello Stato segnata da indubbi successi iniziali, agevolati dalle grandi risorse di cui Mosca poteva godere grazie all’esportazione di semilavorati e di materie prime, l’energia in primis.
Risorse che fornivano i mezzi alla severa politica di “ordine pubblico” nelle grandi città che corrispondeva alle esigenze del perbenismo conservatore dei ceti urbani. Siamo qui di fronte alle radici della popolarità, vera, di Putin; entrata in crisi nel 2010, ma successivamente rianimata dalla “riconquista” della Crimea nel 2014, cioè da scelte legate all’uso della forza per ripristinare i vecchi confini, e dai frequenti richiami alle minoranze russe e russofone delle ex repubbliche, dei cui interessi egli si presentava come difensore già prima dell’ascesa ai vertici del potere.
San Pietroburgo, ottobre 2017: non si vedeva un manifesto, uno striscione, l’avviso di una celebrazione, di una mostra, di un convegno che ricordasse in qualche modo il centenario della nascita dell’Urss. La memoria di Lenin si era ridotta a una lapide di granito incastonata fra le vetrine di un McDonald’s e il sontuoso ingresso di una concessionaria della Rolls-Royce. Veniva così rimosso il padre della rivoluzione: imbalsamato a Mosca e dimenticato nell’antica capitale dell’impero.
Mosca, 1 settembre 2022: Vladimir Putin rende un frettoloso omaggio al feretro di Mikhail Gorbaciov esposto al Central Clinical Hospital. Il suo portavoce, Dmitry Peskov, fa sapere che non sono previsti funerali di stato e che il presidente non parteciperà alle esequie per impegni di lavoro.
Volgograd (ex Stalingrado), 1 febbraio 2023: con un giorno di anticipo, Putin scopre un busto di Josif Stalin per celebrare l’ottantesimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Sono gli ultimi esempi di quel rimpianto dell’Urss che permea l’ideologia ufficiale del regime e le sue aspirazioni di “grandeur” nel nuovo millennio, in cui si combinano ambizioni imperiali, populismo statalista e potenti sfumature nazionaliste. Un rimpianto che contempla non solo la glorificazione della “battaglia più sanguinosa della storia”, ma anche una sostanziale “damnatio memoriae” di chi viene considerato il becchino della dissoluzione dell’impero sovietico. Un trauma, quest’ultimo, “non ancora superato e che spiega in buona il misura il forte legame, almeno fin qui, tra l’ex tenente colonnello del Kgb e il suo elettorato” (Gian Piero Piretto, “Quando c’era l’Urss. 70 anni di storia sovietica”, Raffaello Cortina, 2020).
Un legame, beninteso, che non tollera nessuna manifestazione -individuale e collettiva- di dissenso. A ciò oggi provvedono le diciotto agenzie di sicurezza che fanno capo al Cremlino. Non soltanto, quindi, il potentissimo Gru (il servizio informazioni delle forze armate), l’Fsb (l’ex Kgb) e il Svr (l’agenzia di spionaggio estero). Sono strutture cruciali che hanno consentito a Putin di selezionare gli oligarchi amici e di eliminare, imprigionare, mandare in esilio i meno graditi.
Vent’anni fa il neopresidente aveva convocato gli uomini d’affari che si erano accaparrati le immense risorse industriali del paese, concedendo loro di tenersi le ricchezze -quasi sempre fraudolentemente accumulate – a condizione che si mantenessero lontani dalla politica. Un particolare suona beffardo e anche sinistro: il summit per la spartizione del potere avvenne nella dacia di Kuntsevo, la stessa dove dimorava Iosif Stalin e dove morì il 5 marzo 1953. Per alcuni di quegli oligarchi, infatti, la circostanza è stata infausta.
Del resto, la loro personale fortuna è come un birillo su una pista di bowling: basta un tiro azzeccato e cade con fragore. E non ci sono guardie del corpo che tengano: quelle di Boris Berezovskij, di Michail Chodorkovskij e di Vladimir Gusinskij – rispettivamente ras di Aeroflot, di Yukos e delle tv – hanno potuto fare ben poco di fronte ai siloviki inviati dallo zar per arrestarli. E ben poco hanno potuto fare Anna Politkovskaja e Alexander Litvinenko, Boris Nemtsov e Sergej Skripal, avvelenato con la figlia – ma sopravvissuti entrambi – con lo stesso agente nervino inalato da Aleksei Navalny.
© Riproduzione riservata