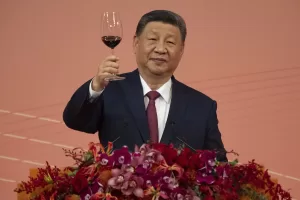Il dibattito
Rsa, opportunità per un processo virtuoso di crescita intelligente
Le tante realtà legate al Terzo Settore devono prendere coscienza della loro responsabilità sociale e dell’opportunità di intendersi come imprese sociali

Grande e ampio è il dibattito in queste settimane attorno al mondo dell’anziano e delle RSA, sia per quanto previsto dal Governo Meloni in tema di non autosufficienza sia perché è in corso una grande trasformazione all’interno del mondo della geriatria che non si può certo ignorare. Da qui arrivano anche le diverse dichiarazioni prima dell’assessore della Lombardia Guido Bertolaso circa le RSA (“Bisogna chiudere le RSA”), poi di Mons. Paglia impegnato, da tempo, in una riflessione sul mondo dell’anziano. Le diverse interpretazioni di questi moniti hanno scatenato reazioni contrastanti. Si va da chi difende oltremodo il modello RSA a chi, eccedendo di ottimismo, vorrebbe davvero portare le cure domiciliari ovunque e a tutti dimenticando che l’Italia ha innanzitutto una sanità regionale. Imporre, quindi, un modello calato dall’alto è molto complicato perché quello che va bene per una grande città difficilmente potrà essere replicato con successo in una valle di montagna. Occorre quindi fare un po’ di ordine e utilizzare il buonsenso per aprire un dibattito virtuoso che abbia sempre, come primo obiettivo, il benessere e la salute del paziente geriatrico. Da una parte occorre capire e comprendere cosa sono oggi le RSA, la loro storia e il loro futuro.
Le RSA sono il risultato, spesso, di realtà locali con alle spalle una lunga tradizione di ospitalità e che sono punti di riferimento per i paesi e le comunità dove si trovano. Pensiamo alle Fondazioni, alle Associazioni, a tutto questo mondo di Terzo Settore impegnato da più di un secolo nell’ospitalità geriatrica. Il modello “ospizio” del secolo scorso, però, va detto che è ormai superato e pertanto serve davvero iniziare ad emanciparsi. Lo dicono anche gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Settoriale sulle RSA della LIUC Business School diffusi poche settimane fa. Nella sola Lombardia, infatti, la regione certamente punto di riferimento in questo mondo, esiste un tasso di saturazione molto alto dei posti letto (media 96,83%) a dimostrazione di una effettiva domanda, confermata anche dalla media di 9 giorni quale sommatoria delle giornate intercorse tra il liberarsi di un letto e la rioccupazione dello stesso.
Rimane stabile la media che vede in 581 giorni i giorni di degenza dall’ingresso dell’ospite in RSA al suo decesso: un indicatore che, combinato con il dato sempre più altro delle classi SOSIA 1-2 (le più complesse) che entrano in RSA, conferma come nelle RSA giungono ospiti sempre più complessi da assistere e curare nell’ultimo tratto della loro vita. È quindi vero che un impulso alla domiciliarità diventa sempre più cogente, soprattutto per aiutare e sostenere i caregiver, ma occorre che tutte le parti in causa si attivino anche per un ragionamento profondo su un mondo che ancora si regge su regole ormai superate e obsolete che non tengono conto, per esempio, di quanto la tecnologia oggi sia un grande aiuto nella cura dell’ospite. Basti pensare all’uso dell’intelligenza artificiale nel controllo del paziente mentre è nella sua stanza. Demonizzare le RSA, però, è comunque sbagliato: alcune patologie dell’età anziana, per esempio l’Alzheimer, richiedono strutture e professionisti formati per una assistenza efficace e spesso è la resistenza dei famigliari un vero scoglio difficile da superare.
È quindi necessario pensare anche a un accompagnamento e a una formazione delle famiglie e dei caregiver sui percorsi da individuare per ottenere il massimo beneficio nella cura. A tal proposito, per esempio, occorre pensare di potenziare e sostenere sempre di più anche la possibilità dei centri diurni, luoghi nei quali l’anziano può essere accudito durante il giorno rientrando poi la sera nella sua dimora, che ancora oggi non sono ben considerati dentro a un percorso che porta sì, infine, alla RSA ma che non vede l’RSA come unica soluzione possibile per l’anziano. Sono queste le ragioni che mi spingono a dire che sia sbagliato l’atteggiamento manicheo nei confronti delle RSA, ma che anzi questo grande mondo – che non dimentichiamo, dà anche lavoro a tantissime persone e consente a molte famiglie di pagare mutui e mantenersi – debba essere sempre più coinvolto in un processo virtuoso di crescita intelligente e misurata. Questo vale soprattutto per quelle tantissime realtà legate al Terzo Settore che, necessariamente, devono iniziare a prendere coscienza non solo della responsabilità sociale che esse hanno, ma anche dell’opportunità di intendersi come imprese sociali che devono innanzitutto tendere a una sostenibilità economico e finanziaria non sempre vista come pilastro di queste attività. Il momento storico richiede impegno, come tutte le fasi di transizione, resta il fatto tuttavia che affrontare in maniera non strutturale i problemi cercando invece di rifugiarsi sempre e comunque in misure una tantum, rischia di innescare processi che impediscono un dialogo franco, schietto e leale su una questione importante come la cura e l’assistenza nell’età anziana. Servirebbero da parte della politica risposte in tempi sufficientemente rapidi, perché i bisogni urgenti del tempo in cui viviamo richiedono prontezza e visione.
© Riproduzione riservata