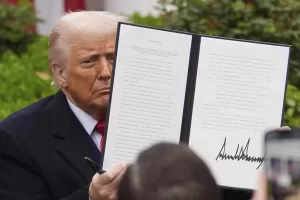Firme on line per liste e quesiti
Spid democracy, quali sono i vantaggi e gli svantaggi della democrazia 2.0

Penso che dobbiamo evitare una tentazione del tutto improduttiva, quella di ripartire almeno in questa fase con una discussione sulle formule elettorali. Dalle urne è uscita una maggioranza in seggi dovuta al combinato disposto tra la legge vigente e un’offerta politica asimmetrica. È del tutto ovvio che la maggioranza parlamentare non intenderà, almeno in questa fase non breve, ridiscutere la formula vigente da cui è stata appena beneficiata. Caso mai si potrebbe aprire più avanti, se ben istruita, una più utile discussione sui disincentivi costituzionali alle crisi in corso di legislatura.
Per questa ragione mi sembra più opportuno perché più produttivo lavorare ora, già da questa fase, su riforme della legislazione elettorale di contorno che sono relativamente neutre, che debbono essere pensate per tempo, in quanto comportano rilevanti problemi di attuazione pratica e sulla cui importanza insiste sempre meritoriamente il professor Lanchester. Le priorità sulla legislazione di contorno sono indubbiamente due: il tema del “voto dove vivo”, oggetto tra l’altro nella XVIII legislatura di una meritoria proposta Madia (Atto Camera 1714) e rilanciato poi dal rapporto dell’aprile scorso della Commissione di esperti nominata dal Governo coordinata da Franco Bassanini (leggibile qui; quello delle firme elettroniche e della cosiddetta spid democracy rilanciata ora dal ministro Colao con il lancio della piattaforma per le firme digitali per referendum e proposte di iniziativa popolare.
Essendo il primo tema già ampiamente arato, mi concentrerò quindi sul secondo. Quella che chiamiamo spid-democracy è una tendenza generalizzata. D’altronde se utilizziamo questi strumenti per la vita quotidiana sarebbe ben strano che ne restasse esclusa la politica. Finora, com’è noto, l’apertura è stata limitata, anche se già significativa. Già la legge Rosato nel comma 7 dell’art. 3 (legge 165/2017) aveva teoricamente previsto di “consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l’utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata”.
Il decreto-legge 77/2021 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) ha poi previsto in particolare che: il certificato di iscrizione alle liste elettorali, necessario per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politiche, europee ed amministrative, nonché di proposte di referendum e per iniziative legislative popolari possa essere richiesto in formato digitale tramite posta elettronica certificata; il deposito del contrassegno da parte dei partiti politici che intendono presentare liste di candidati alle elezioni possa avvenire anche su supporto digitale; l’atto di designazione dei rappresentanti della lista possa essere presentato anche mediante posta elettronica certificata; inoltre la presentazione del suddetto atto di designazione possa avvenire sia di persona sia tramite Pec; le autenticazioni degli atti di designazioni dei rappresentanti di lista non siano necessarie quando gli atti di designazione siano firmati digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata dai delegati dalle persone autorizzate dagli stessi delegati con atto firmato digitalmente, a condizione che tali documenti siano trasmessi tramite posta elettronica certificata; i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici e delle liste competitrici in elezioni amministrative in comuni con almeno 15mila abitanti possano fare richiesta anche tramite posta elettronica certificata dei certificati penali rilasciati dai casellari giudiziali per i propri candidati, ai fini dell’ottemperanza per i partiti dell’obbligo di pubblicare sul sito internet il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati; è prevista la pubblicazione tempestiva sul sito internet istituzionale dell’ordine dei nominativi degli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni elettorali; la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori fuori sede prevista dalla legge di bilancio 2020 per le elezioni politiche ed europee e per i referendum è estesa anche alle elezioni regionali e amministrative.
Con la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178; art. 1, commi 341-344) era stata disposta l’istituzione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali e con il decreto-legge n. 77 del 2021 è stata quindi definita una nuova disciplina per la sottoscrizione elettronica per i referendum e per le proposte di legge di iniziativa popolare. Iniziativa che va principalmente a merito del deputato Riccardo Magi, ora completata dal ministro Colao. Si tratta, questo è il punto, di precedenti che possono e debbono aprire la strada anche per le elezioni amministrative, regionali e politiche, sempre nella logica di consentire anche nuove modalità senza sopprimere quelle tradizionali. I principali ordinamenti nei quali è ammessa la sottoscrizione elettronica delle candidature per le elezioni politiche nazionali sono il Belgio, il Canada, l’Islanda, la Romania, la Spagna e l’Ungheria. In Belgio, la sottoscrizione online può essere effettuata esclusivamente tramite un’applicazione predisposta dall’amministrazione competente; il modulo generato dall’applicazione, in ogni caso, deve essere successivamente stampato e consegnato agli uffici.
In Canada, la sottoscrizione si effettua tramite un modulo che può essere inviato digitalmente, anche per email. In Spagna, la sottoscrizione digitale delle candidature è soggetta alla medesima disciplina prevista, in via generale, per gli atti della pubblica amministrazione. Ai casi appena illustrati, va aggiunto il Portogallo, dove la sottoscrizione elettronica delle candidature (tramite un portale dedicato) è invece consentita per l’elezione del Presidente della Repubblica. Già questa serie di esempi è sufficiente a segnalare che il problema tende sempre più a sfociare in una discussione sul COME introdurre queste innovazioni, avendo già superato a monte in senso positivo la questione del SE. Il COME significa valutare le modalità per assicurare la affidabilità, sicurezza, personalità e univocità della sottoscrizione e in particolare l’individuazione di un’autorità a cui spetti il monitoraggio dell’applicazione delle nuove modalità di raccolta delle sottoscrizioni in forma digitale. Peraltro la digitalizzazione costituisce fondamento nella Missione 1 del Pnrr e obiettivo che attraversa l’intero Piano.
Anche in sede di Unione europea il tema è di particolare attualità: da ultimo con la Comunicazione COM (2021) 118 final dal titolo “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade” del 9 marzo 2021, la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per La trasformazione digitale dell’Europa entro il 2030. Tra gli obiettivi dell’Ue rientra quello di garantire che entro il 2030 la vita democratica e i servizi pubblici online siano completamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, anche attraverso il voto elettronico che incoraggerebbe una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica. Qual è il rischio principale? Quello di una eventuale proliferazione delle liste da presentare alle competizioni elettorali a seguito dell’utilizzo distorto di programmi informatici che consentono di alterare l’ordinato procedimento di presentazione delle liste e che rischiano quindi di mettere a rischio il complessivo funzionamento del procedimento elettorale che, per la sua delicatezza e unicità nel sistema di democrazia rappresentativa, deve poter funzionare in maniera trasparente ed efficace in tutte le sue fasi, senza alterazioni o rischi, sin dalla fase del procedimento preparatorio da cui il sistema elettorale ha origine.
Per questa ragione appare maturo il tempo di confrontarsi su alcune scelte normative. Ne propongo qui quelle che ritengo le due principali, in attesa di conoscere meglio i dettagli del decreto voluto dal ministro Colao, parzialmente anticipati sulla stampa in questi giorni.
Anzitutto la piattaforma potrebbe essere collocata presso l’Ufficio centrale nazionale della Cassazione, che svolge già un ruolo-chiave nel procedimento elettorale. Le istituzioni da coinvolgere per realizzare la piattaforma e per assicurarne il sicuro funzionamento dovrebbero essere il Ministero della giustizia, il Ministero dell’interno, il direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza e il Garante per la protezione dei dati personali.
In secondo luogo presso l’Ufficio centrale dovrebbe anche essere istituita una Commissione per la trasparenza e il monitoraggio della raccolta delle sottoscrizioni con componenti designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’interno, dal Presidente della Corte di Cassazione, dall’Istituto nazionale di statistica, dalla Conferenza Stato-Regioni e dai Presidenti delle Camere. A partire da queste prime scelte di fondo potremmo trovare anche le ulteriori soluzioni di dettaglio per giungere ad una disciplina organica, risolvendo nel contempo anche in modo organico e coerente il nodo politico più sensibile della disciplina delle esenzioni. L’occasione potrebbe essere colta anche per adeguare ai medesimi principi la piattaforma ora predisposta per le proposte di referendum e di iniziativa popolare, consentendo per quanto possibile di garantire una firma ‘informata’, anche al di là delle forme previste dal decreto in corso di emanazione.
© Riproduzione riservata