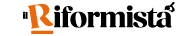Millenovecentosessanta. Il governo Fanfani II è stato affondato dai “franchi tiratori”, democristiani a lui ostili. Il 9 marzo Segni è incaricato di formare il nuovo governo; il 21 rinuncia. L’incarico (per un governo “a tempo”, fino alla fine dell’anno) viene trasferito a Tambroni che ottiene la fiducia alla Camera con 300 voti favorevoli e 297 contrari; determinanti i voti del Msi. Per questo, l’11 aprile Tambroni si dimette. Ci prova di nuovo a Fanfani; il 22 dello stesso mese, però, rinuncia a sua volta. Gronchi invita Tambroni a presentarsi al Senato per completare l’iter della fiducia; la ottiene anche lì, sempre con l’appoggio dei missini. Il 30 giugno durissimi scontri a Genova fra la polizia e decine di migliaia di manifestanti scesi in piazza per impedire lo svolgimento del congresso del Msi nella città medaglia d’oro della Resistenza. Il 2 luglio l’annuncio che il congresso del Msi non si terrà a Genova. Il 5 luglio c’è un morto a Licata. Il 6 luglio nuovi scontri a Porta San Paolo a Roma. Il giorno dopo a Reggio Emilia la polizia spara sui manifestanti: cinque morti e decine di feriti tra la popolazione. L’8 due morti a Palermo e uno a Catania. Il 19 luglio Tambroni si dimette ed è sostituito, il 26, da Fanfani.
Questa la cronaca. Il luglio 1960 fu un passaggio cruciale nella storia della politica della prima repubblica. È in questa ottica che si devono valutare quegli avvenimenti; altrimenti si corre il rischio di indulgere a letture propagandistiche e agitatorie, fotocopie più o meno sbiadite delle polemiche di allora. C’è chi si chiede – ad esempio – se la protesta delle forze dell’antifascismo democratico contro il connubio con il Msi non sia stata un favore al Pci, quindi di per sé un errore; come se fosse possibile fare la storia dell’Italia repubblicana cancellando il Pci. D’altra parte, non basta certo esaltarsi nel ricordo di una lotta popolare, di un “risveglio giovanile” che pure ci furono. La “Nuova resistenza” di cui allora si parlò, è uno slogan efficace, funzionale a una precisa strategia politica: portare a termine la rivoluzione democratica e antifascista, iniziata – appunto – con la Resistenza del 43/45: intento comprensibile e – se vogliamo – apprezzabile; certo non criterio di interpretazione storica.
La specificità del luglio ‘60 è il confronto fra la Dc da una parte e tutte le sinistre dall’altra. Nel corso della prima repubblica è stata, forse, la sola occasione in cui ciò sia avvenuto sul terreno concretamente politico, e non come ipotesi propagandistica. Nel corso di quel passaggio si è dimostrato che la sinistra, riducendo la conflittualità al suo interno, poteva riuscire a condizionare la Dc; e la Dc ha sperimentato che, se non avesse dato una efficace risposta politica e strategica, avrebbe rischiato di perdere il primato politico e perfino di mettere in pericolo la sua unità. L’esito di quel confronto è stato la archiviazione definitiva del centrismo. L’antifascismo ebbe certamente un peso, alimentò un vasto moto di protesta. Ma il fattore antifascista fu una “complicazione” scaturita dalla estenuante ritrosia della Dc a dare corso alle nuove relazioni politiche di cui lei stessa vedeva la utilità e la ineluttabilità. Quando comincia la terza legislatura dopo il voto del 25 maggio 1958, repubblicani e socialdemocratici, ciascuno per motivi e con obiettivi propri, non sono più disponibili per il centrismo: lo hanno detto e dimostrato. In particolare i secondi si rendono conto che è impossibile sbarrare la strada al Psi che, dopo il 1956, non può più essere presentato come un partito “a sovranità limitata” rispetto al Pci.
I protagonisti diretti, e tutti gli attori sulla scena non si domandano più se giocare la partita della “apertura a sinistra”, ma come farlo; cercano di posizionarsi e di equipaggiarsi nel modo migliore. Se ne ha la prova nei congressi del Psi, della Dc e del Pci, che si susseguono a pochi mesi uno dall’altro. Il Psi, nel XXXIII congresso (Napoli gennaio 1959) non dovette far altro che confermare e sottolineare quanto aveva già elaborato e detto negli anni precedenti. Quel congresso produsse, però, una novità significativa: la nuova direzione del partito (14 persone) fu composta solo da esponenti “autonomisti”, che condividevano, cioè, le posizioni di Nenni beneficiarie del 58% dei voti congressuali. Il Psi dice, così, di esser pronto, non solo politicamente, ma anche “operativamente”. A settembre, nel Comitato centrale dichiara che garantirà l’appoggio esterno a un governo che chiuda sul fianco destro. Il messaggio è rivolto al Congresso Dc che si riunirà qualche settimana dopo.
Il 24 ottobre a Firenze, Moro, per la prima volta in veste di segretario della Dc, apre il VII congresso. Coloro che hanno determinato la caduta del governo Fanfani – che, avrebbe dovuto avviare l’apertura al Psi – vengono da lui bollati come «autori del tradimento non ad un uomo, per quanto benemerito, ma alla Dc, all’elettorato, al Paese che ha bisogno di tutta la forza della Dc». Il riscontro, per il Psi è sì positivo, ma anche molto impegnativo; Moro chiede ai socialisti di pronunciarsi chiaramente sul carattere politico della alleanza. Nenni lo capisce e, nel Comitato centrale dell’8 febbraio 1960, chiude il ragionamento: per evitare soluzioni a destra – dice – il Psi deve impegnarsi con le forze laiche e con la Dc nella costruzione di una maggioranza autosufficiente.
Il IX Congresso del Pci si riunisce a Roma ai primi di febbraio del 1960. Togliatti, nella relazione, prende le mosse da una approccio rigorosamente “programmatico”. Una nuova maggioranza, dice, richiede si passi «dalle indagini astratte di possibili o impossibili combinazioni parlamentari, concessioni, tolleranze e così via, al suo vero terreno, che è quello della ricerca di un indirizzo programmatico.» – I programmi del Psi non sono lontani da quelli del Pci; che, dunque, nel perseguire la loro attuazione, può esercitare il massimo di influenza e far pesare la sua forza. Ed è conveniente per Togliatti distogliere l’attenzione dalle motivazioni politiche del convergere fra Dc e Psi, imbarazzanti da affrontare in quanto connesse con i motivi che rendono impraticabile al Pci la via del governo. Ma il Pci non può evitare di pronunciarsi anche sulla specifica questione politica che domina la scena nazionale e che ha occupato i lavori dei congressi socialista e democristiano. La mozione conclusiva del congresso, dopo aver elencato sei punti programmatici definiti irrinunciabili, afferma senza alcuna ambiguità: «i comunisti dichiarano di essere disposti ad appoggiare un governo che dia alle forze popolari garanzia di realizzare questo programma; anche se ad esso partecipi il Psi e non il Pci».
All’inizio del 1960, è dunque questa la dislocazione dei pezzi sulla scacchiera; con un particolare molto rilevante: i quattro “pianeti” alla sinistra della Dc (Pri, Psdi, Psi e Pci), muovendosi ciascuno sulla propria orbita, si trovano in quel momento allineati nell’intento, variamente motivato ma comune, di obbligare la Dc alla “apertura a sinistra”. Continuando nella metafora “astronomica” si può dire che, in quella posizione, le “forze gravitazionali” dei singoli corpi si sommano; cresce, dunque, obiettivamente la pressione sulla Dc, e si riduce la sua libertà di manovra. Nella storia della politica nell’Italia repubblicana questo allineamento non si era mai verificato. Per la Dc si trattò di “costrizione” o no? Vediamo. Nell’auto di Moro in Via Fani fu ritrovato – come si sa – un articolo destinato alla pubblicazione su Il Giorno. È l’ultimo scritto di Moro libero: si occupa di una discussione fra Amendola e me a dieci anni dal ’68, il cui resoconto era uscito da pochi giorni su l’Unità di cui ero, allora, condirettore. L’intento principale di Moro, è – come lui stesso scrive – di «rettificare il rilievo critico di Amendola circa le scelte a destra che la Democrazia cristiana avrebbe fatto dando il via all’esperienza Tambroni, bloccata dall’indomabile ripresa delle forze democratiche del Paese».
Siamo a quasi venti anni di distanza; l’attenzione di Moro dimostra quanta importanza egli attribuisse a quel passaggio e alla interpretazione che se ne dava. E, ben comprensibile, perché la sua leadership nella Dc si è delineata e consolidata nel corso di quella prova, sulla base di un preciso giudizio strategico. Egli affermò allora che i caratteri, la funzione, la stessa esistenza della Dc dipendevano, alla fine dei conti, dalla disponibilità e capacità di impegnarsi in un confronto realistico e in una collaborazione consapevole e controllata con la sinistra; e di farlo insieme, uniti; in modo che la Dc esercitasse la massima “padronanza” possibile sulla situazione.
La leadership di Moro si è svolta per un ventennio lungo questi binari con assoluta coerenza, dalla incubazione del primo centro-sinistra alle conseguenze estreme della solidarietà nazionale. Moro riconosce che nel luglio ‘60 possono esserci stati «errori anche gravi», ma non «una linea strategica diversa da quella che si venne, mano a mano, chiarendo e realizzando». La “rettifica” di Moro ad Amendola è fondata; la Dc con Tambroni non aveva inteso cambiare la strategia, che restava quella enunciata dallo stesso Moro poche settimane prima a Firenze. Ma uno «sviluppo tattico non ben calcolato – sono ancora parole tratte da quell’articolo – fece danno e provocò gravi e comprensibili reazioni». Ma – viene da osservare – proprio perché la strategia non mutava, si deve fornire qualche spiegazione per quello “sviluppo tattico” in contrasto così stridente con il fine di quella strategia oltre che “obiettivamente pericoloso”.
La prima che viene in mente è una errata valutazione, da parte della Dc, della situazione; e delle posizioni, degli orientamenti delle forze in campo. È probabile che ci sia stata una sopravalutazione della offensiva – peraltro assai rumorosa e aggressiva – della destra clericale, che in alcuni momenti sembrò esprimere la posizione della Chiesa in quanto tale; Pio XII era morto alla fine del 1958 e gli orientamenti del nuovo pontificato non erano ancora ben percepibili. Sicuramente hanno avuto un peso le preoccupazioni per l’unità della Dc, alimentate dalla vicenda Milazzo che, all’inizio del 1960 si stava concludendo, ma che per l’anno e mezzo in cui era stata viva, aveva seriamente allarmato i vertici democristiani. Soprattutto, però, risulta evidente, da parte democristiana, una sottovalutazione dell’”allineamento congiunturale” che si era verificato sulla sua sinistra, e che le tolse quelle occasioni di manovra di cui, in altre circostanze, anche recenti, aveva potuto usufruire.
Ecco le cause politiche degli “errori anche gravi” che Moro riconosce. Guardando, dunque, alla strategia che si era data e che non fu modificata, non si può dire che la Dc sia stata “costretta” da altri a porre fine nel “più breve tempo possibile” all’azzardo, all’errore Tambroni. Ma è indiscutibile che, non ci fosse stata la reazione popolare e la pressione convergente di tutte le forze della sinistra, le cose sarebbero andate diversamente, se non altro sul piano “tattico”; con tempi e modi certamente diversi. Quanto alle considerazioni di Amendola c’è – a mio avviso – più di quello che ci legge Moro. Penso – anche per essere stato nell’occasione il suo interlocutore – che Amendola non fosse interessato a schiacciare la Dc su una posizione di destra, quanto a valorizzare l’allineamento di tutte le forze della sinistra che si determinò nel luglio ‘60; allineamento che pesò – e come! – nella vicenda Tambroni. Penso che il giudizio positivo di Amendola su quel momento, come la valutazione critica sul ’68, derivino da un orientamento e da un ragionamento del tutto politico.
Amendola avrebbe voluto che l’allineamento (cosa diversa dall’ “unità”) che influì in quel passaggio non fosse un episodio passeggero, congiunturale, ma divenisse la forma permanente delle relazioni fra le forze della sinistra, socialiste e laiche. Quando, nel 1978, ne discusse con me, sapeva bene che quel suo auspicio, quella sua strategia politica non aveva trovato riscontro nei fatti. Il 1960 restò una eccezione. Sarebbe stato possibile diversamente? Cosa impedì che diventasse permanente? Che fosse preservato anche dopo che l’apertura a sinistra” aveva dato luogo al centro-sinistra “organico”; e dopo che questo si era – rapidamente – esaurito? È un altro capitolo della storia della politica nell’Italia repubblicana; forse, ormai, è possibile scriverlo senza che le passioni e gli scontri di allora prevalgano sulla serenità e obiettività della ricostruzione e del giudizio storico.
PS – Il luglio ’60 io l’ho vissuto. Avevo diciannove anni, ero al secondo anno di università e indossavo anche io, come tutti i giovani di allora le “magliette a strisce”. Scrivendo queste note mi sono detto, come lo scoprissi all’improvviso: ma il ’60 è anche l’anno delle Olimpiadi di Roma! È la stessa estate! Passa appena un mese fra la caduta di Tambroni e il 25 agosto, quando si accende la fiamma della XVII Olimpiade. E mi sono reso conto che fatti così prossimi sono separati non solo – sorprendentemente – nelle cronache e nelle polemiche del tempo, ma nella mia stessa memoria. Eppure, io ero la stessa persona: a Porta San Paolo in mezzo alle cariche e ai lacrimogeni e – dopo poche settimane – a guardare le Olimpiadi, davanti all’apparecchio televisivo appena arrivato in casa mia, come in milioni di altre case italiane. Fra i morti di Reggio Emilia e l’inizio dei giochi passano meno di cinquanta giorni.
Nel ricordo, sono come due epoche lontanissime. Perché? Me lo sono spiegato con la enorme distanza emotiva fra due esperienze: opposte, incompatibili. Cupa, drammatica, paurosa, la scena dei caroselli, degli spari, dei morti; noi che avevamo vent’anni, eravamo sbigottiti, angosciati all’idea di essere risucchiati nel passato. Uno squillo di gioia, di fiducia, un tuffo felice verso un futuro nel quale ogni orizzonte era aperto, ogni speranza si poteva realizzare, la scena di quel pomeriggio del 3 settembre, quando Livio Berruti (un mio coetaneo, come lo erano Lauro Farioli e Ovidio Franchi uccisi a Reggio Emilia) concluse il suo volo di inimmaginabile leggerezza e naturalezza sul filo di lana dell’Olimpico. Quanto di più lontano!! Due Italie opposte; eppure, contemporanee. La prima, purtroppo, l’Italia della politica; l’altra, l’Italia dell’intelligenza, dell’applicazione, dell’ottimismo, pronta a conquistare il suo ventesimo secolo. Quanto più lenta, più insicura, più cattiva la prima! Di tentativi per raggiungere la seconda, per avvicinarsi alla leggerezza di Berruti, ne ha fatti; ma non c’è riuscita. È uno dei motivi, forse, per cui oggi anche l’Italia di Berruti non riesce più a correre, e non ha neppure voglia di farlo.
(Questo articolo è stato pubblicato dalla rivista Ragioni del Socialismo, fondata e diretta da Emanuele Macaluso)
3 – Continua