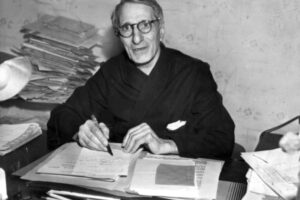Il futuro dell'Occidente
Welfare state a rischio: dopo il virus rinasceremo, ma come?

L’eccezionalità della pandemia e delle misure connesse ha messo in rilievo un nuovo “interventismo dello Stato”, anche in economia. La permanenza, la conversione in misure normali di atti eccezionali in ambito economico ad esempio, dipenderà dall’azione di imprenditori politici e dal sostegno che ne daranno partiti ed elettori. Il virus ha riaperto il tema della privatizzazione dei servizi rispetto al carattere pubblico, dalla sanità ai trasporti, all’istruzione. In questa fase eccezionale lo Stato ha reperito misure straordinarie. Si potrebbe riaprire la discussione ermeneutica sul dogma capitalista non controllabile né regolabile, e quindi sul ruolo dello Stato nell’economia.
Del resto, la classica tripartizione di Montesquieu va integrata e aggiornata con il controllo economico. La concentrazione di risorse finanziarie in proporzioni superiori a quelle statali rende l’economia il “quarto” potere e come tale da controbilanciare con l’azione degli altri tre. Il cui ruolo è indefinito, astratto non solo a livello nazionale, ma anche su scala europea allorché questi debbano intervenire per regolare il mercato delle concentrazioni finanziarie.
Una condizione che somiglia alle prime mosse dei parlamenti, e dei partiti, intenti ad ammaestrare il cavallo della Rivoluzione industriale dell’Ottocento, e della seconda Rivoluzione prima della Grande Depressione e dell’avvento del nazifascismo. Il paradosso deriva dal fatto che sia proprio il libero mercato, la libera circolazione delle persone, delle cose, dei diritti, della conoscenza, delle idee, e persino dei virus, a rappresentare il compimento della società umana mondiale.
La debolezza del turbocapitalismo di fronte alla gestione dell’emergenza pandemia non va misurata dunque nella intrinseca disuguaglianza che genera nei sistemi senza tutele universalistiche, quanto anche nella capacità di risolvere l’eccezionalità. Da questo punto di vista i regimi democratici e quelli non democratici rischiano di somigliarsi non solo per l’apertura dei mercati: entrambi decretano lo stato di eccezione, affrontano la crisi e provano a risolvere il “problema”. Rimettendo solo in parte in discussione gli ambiti di gestione di “spada, moneta e bilancia”.
In questo contesto eccezionale, dunque, le società dovranno comunque definire un nuovo paradigma sociale, economico e politico, persino istituzionale. Una sfida, un rischio e un’opportunità. Il pensiero dominante in molte democrazie, ossia il retrenchment nazionalista e le derive populiste (di estrema destra ed estrema sinistra) sono di fronte a una tenzone importante per il loro futuro.
L’afonia del Populismo e dell’estrema destra sono solo transeunte. In Europa e in Italia in particolare le difficoltà dipendono dalla statura delle rispettive leadership. Soprattutto nei momenti decisivi la caratura dei politici emerge chiaramente, ma a patto che abbia elementi per manifestarsi. In fasi di “normalità” le opinioni senza fondamento possono trovare giovamento in un tessuto sociale – come quello italiano – in cui i due terzi (2/3) della popolazione è analfabeta funzionale, mentre in contesti di eccezionalità, direbbe Max Weber, è necessario palesare qualità “extra normali”. Il populismo è dunque debole intrinsecamente, ontologicamente incapace di gestire l’eccezionale ché tende a renderlo “normale”.
Infatti, i nazionalisti populisti di estrema destra chiedono di chiudere le frontiere confidando che da misura “eccezionale” si trasformi in consuetudine, in regola, in nuova norma. Non importa, nella fattispecie, che l’assunto sia infondato, ossia che il virus non conosce limiti da ius soli o ius sanguinis, l’essenziale è scardinare attraverso una misura eccezionale un impianto istituzionale avversato. Il Covid-19 non è la causa delle contraddizioni delle società mondiali, europee e italiane. Gli effetti che esso ha generato hanno contribuito a palesare le distorsioni del sistema economico, le diseguaglianze sociali e di diritti, l’impatto sul pianeta Terra dell’attività dell’Homo Sapiens Sapiens. La risposta, se verrà, potrà andare nella direzione della chiusura “nazionale” ovvero nella prospettiva di maggiore integrazione e cooperazione tra gli Stati, non in una indistinta governance internazionale, quanto in cessioni e cogestione di sovranità statale su competenze specifiche.
Il sovranismo non è la soluzione, è del tutto evidente. Non da ora. Rappresenta però un residuo della società tribale, della chiusura cannibalesca e clanica, l’ideologia del gruppo, qualunque esso sia, che contrappone i suoi destini al resto. Succedeva nella jungla e – mutatis mutandis – accade tra le persone.
© Riproduzione riservata